
di Giuseppe Pennisi
Premessa. Ricorrono quaranta anni dal 1968. In Italia, ed in certa misura in Francia, sono programmate varie iniziative per ricordare gli avvenimenti di quell’anno che, per molti aspetti, hanno segnato la vita (e le carriere) di molti di coloro che oggi anziani sono in posizioni di rilievo. Non si programmano (che io sappia) importanti manifestazioni in Germania, dove, in particolare all’Università di Francoforte, del “Sessantotto” vennero poste le premesse e formulata una teoria; non per nulla, alcuni dei leader del “maggio francese” erano tedeschi.
Non parteciperò alle iniziative in programma per vari motivi. Per uno soprattutto: a 25 anni, ero un graduate student italiano negli Stati Uniti (a Washington D.C.) in un’università internazionale, la School for Advanced International Studies (Sais) della Università Johns Hopkins. Quindi, unitamente ai miei altri due colleghi italiani (oggi ambedue Ambasciatori d’Italia), nonché ad altri giovani europei che completavano il ciclo di studi alla Sais, vidi il “Sessantotto” europeo con il cannocchiale, mentre ebbi modo di osservare da vicino il “Sessantotto” Usa. Sotto il profilo personale, ero privilegiato (rispetto ai colleghi europei) in quanto in un periodo in cui a Washington la stampa italiana arrivava in ritardo e poteva essere acquistata solamente in un negozietto di pubblicazioni internazionali (spesso nascosta dietro riviste porno francesi o latino-americane), collaboravo regolarmente con “Il Sole-24 Ore” e lo ricevevo via aerea. Quindi, anche gli altri due italiani ed i colleghi che leggevano italiano avevamo più informazioni di quelle (scarse) che arrivavano sul “New York Times” e sul “Washington Post”.
Il “Sessantotto” inoltre è stato per me soprattutto anno di avvenimenti personali importanti; in febbraio incontrai la persona che da allora è mia moglie, ci sposammo in agosto in Provenza ma (dato che lei è francese) ci trovammo a Parigi all’inizio di giugno, proprio mentre infuriava quella che viene ricordata come la “battallie de l’Odéon”. Vinsi, in aprile, un concorso in Banca Mondiale dove presi servizio a metà settembre. Queste vicende private si intrecciavano più con il “Sessantotto” degli Stati Uniti, Paese in cui ho vissuto per oltre tre lustri e puntavo necessariamente gli occhi più su ciò che mi circondava che su ciò che richiedeva inforcare un cannocchiale.
Il Sessantotto americano. Molti dimenticano che in parallelo con il “Sessantotto” europeo, ci fu un “Sessantotto” americano. Iniziò convenzionalmente il 21 ottobre del 1967 con la marcia al Pentagono di un milione di persone, gestita principalmente dalla Students for a democratic society (Sds - organizzazione che allora si proponeva il rinnovamento della società Usa) ed ebbe come suoi momenti importanti: in aprile, l’assassinio di Martin Luther King e successivamente i moti che misero a ferro e fuoco la capitale ed altre città americane, in maggio l’omicidio di Robert Kennedy e in parallelo l’annuncio del Presidente Lyndon Johnson di non ricandidarsi alla Casa Bianca, nonché in estate la difficile contesa per la scelta del candidato del Partito Democratico (con i disordini al Lincoln Park a Chicago), in novembre la vittoria (a larga maggioranza) di Nixon nelle elezioni alla Presidenza della Repubblica. Due i temi di fondo del “Sessantotto” americano: la guerra in Vietnam e il non facile completamento del processo di integrazione razziale richiesto dalla normativa sulla “Grande Società” approvata alla metà degli Anni 60.
Paradossalmente, i teorici tedeschi del “Sessantotto” (in primo luogo Hebert Marcuse, negli Usa dal 1930 ma in stretto contatto con la maggiore università sulle rive del Meno) e gli intellettuali francesi vicini al “maggio” (quali Edgard Morin e Jean-François Revel, a cui si giustapponeva l’ironia di Romain Gary, due volte Premio Groncourt ed allora console generale di Francia a Los Angeles - nonché sposato con un attrice che si definiva appartenente alla sinistra radicale) guardavano agli Usa , in particolare alla California, come al modello di società libera e moderna (“senza Marx e senza Gesù”, secondo il titolo di un saggio di successo di Revel) a cui avrebbe dovuto aspirare l’Europa vecchia, parruccona e polverosa. Alcuni di loro leggevano avidamente un settimanale che si produceva a Washington D.C. (la redazione era in un piccolo appartamento di Thomas Circle), il “Quicksilver Times” – il “Times dell’Argento Vivo” che con articoli frizzanti e foto di nudi integrali era diventato uno dei vessilli del Sessantotto “made in Usa”.
In Europa e in Italia in particolare, si usava e si usa, mitizzare il “Sessantotto” Usa dipingendolo con tratti analoghi a quelli dei miti costruiti sui “Sessantotto” del Vecchio Continente (quello nostrano in primo luogo). Lo si tratteggia come pacifista in quanto contrario all’intervento in VietNam. E’ un’immagine che non ha riscontro nella realtà. L’opposizione alla guerra nel Sud Est asiatico sarebbe cresciuta soprattutto negli anni Settanta (a ragione dell’inconcludenza del conflitto e delle sempre maggiori perdite), ma nell’ultimo scorcio degli Anni Sessanta, accanto ad un movimento di opposizione alla guerra, ma non necessariamente alla presenza Usa nel Sud-Est asiatico (quello, ad esempio, della marcia del 21 ottobre 1967), c’erano un vasto strato di “sessantottini” che vedevano la vittoria delle libertà contro il comunismo in Asia come elemento essenziale per affermare maggiori libertà (per gli afro-americani, per gli ispano-americani, per le fasce a basso reddito) nella stessa società americana. In tal senso, i “guerrafondai” erano “sessantottini” alla stessa stregua dei pacifisti, si vestivano e si comportavano allo stesso modo, partecipavano agli stessi parties dove gli happenings o lo streaking (allora di moda) erano talvolta ai confini con l’orgia. Molti colleghi americani alla Sais partirono volontari alla volta del Vietnam: uno, patriota di ferro per tutta la vita, ha successivamente fatto la sua intera carriera alla Cia ed è padrino di nostra figlia; un altro, vincitore di numerosi premi di giornalismo, è stato sei settimane prigioniero dei Viet-Cong e, riuscito a scappare, è tornato a Saigon come corrispondente del “Washingon Post”, restando immortalato nella foto del reporter attaccato all’elicottero che lascia l’Ambasciata Usa il giorno della caduta della capitale del Vietnam del Sud.
Il cannocchiale sul Sessantotto europeo. I “settantottini” americani si interessavano, necessariamente, più ai problemi del loro Paese che a ciò che stava avvenendo in Europa, malgrado che i miei colleghi Usa fossero un campione molto particolare: non solamente erano impegnati in un programma di studi internazionali, ma parlavano tutti o francese o spagnolo (oltre all’inglese e spesso altre lingue, anche orientali). Una cinquantina di loro parlava italiano anche in quanto aveva passato un anno accademico al Bologna Centre della Johns Hopkins University. Il “Sessantotto” europeo veniva da loro percepito come un episodio dell’ormai lungo ma inevitabile declino dell’Europa ( che pure era, allora, il secondo pilastro dell’Alleanza e della Comunità Atlantica e veniva invitato ad acquistare obbligazioni del Tesoro Usa, i “Roosa Bonds”, dal nome del Sottosegretario americano, per saldare i conti degli Stati Uniti con il resto del mondo).
Anche se gli “europei” alla Sais (una ventina – austriaci, belgi, francesi, inglesi, tedeschi, ed i tre italiani, me compreso) contro-argomentavano che si trattava invece di un segno di modernizzazione, con il senno del poi occorre dire i nostri colleghi americani non avevano tutti i torti. Il “Sessanta” fu, al tempo stesso, la svolta verso il declino e la svolta verso un lungo processo di perdita di produttività comparata dell’Europa rispetto sia agli Stati Uniti sia all’Asia (che allora cominciava a galoppare, ma pochi se ne accorgevano). In privato, sulle sponde del Potomac, si condivideva, infatti, l’analisi di molti coetanei americani che studiavano nella medesima università. Ricordo, in particolare, le preoccupazione di un collega tedesco (che ha successivamente seguito una carriera bancaria nella Repubblica Federale ed in parte negli Usa) non tanto per ciò che avveniva nella Repubblica Federale (e che si sarebbe presto spento, nonostante l’attività di alcuni gruppi terroristi sino alla seconda metà degli Anni Settanta), ma per gli “avvenimenti” in Francia dove, a suo parere, si metteva a repentaglio il riassetto dell’amministrazione dello Stato in corso di realizzazione (nella prima parte della Quinta Repubblica) e soprattutto si indeboliva un management imprenditoriale che (allora) era il più moderno ed il più innovativo in Europa occidentale. Timori analoghi veniva espressi da colleghi belgi, olandesi ed austriaci (i cui Paesi, soprattutto l’Austria, sono stati solamente sfiorati dal Sessantotto). Noi tre italiani accoglievamo con incredulità le notizie che venivano dalla Francia trovando anomala e di breve durata l’alleanza di studenti ed operai, come punta del rinnovamento (tema di un libro di Maria Antonietta Macciotti pubblicato all’inizio degli Anni Settanta): gli studenti francesi erano, a nostro giudizio, tra i più privilegiati al mondo – a ragione della carriere brillanti che si schiudevano automaticamente a coloro che frequentavano “les grandes écoles” e del carico relativamente leggero per coloro che invece andavano nella Facultés (in ogni caso con rette universitarie più figurative che nominali). Maggio (il mese dell’esplosione del “Sessantotto” francese) era comunque per noi periodo di esami finali dopo due anni di studi post-universitari, di colloqui con potenziali futuri di lavoro (li organizzava la stessa Sais con le maggiori multinazionali, specialmente del settore finanziario), di preparazione a concorsi (per coloro che li avrebbero fatti nei loro rispettivi Paesi), di scelte di vita (come il matrimonio). Gli “évenements” francesi, quindi, venivano visto con distacco e distanza; quelli italiano sarebbero scoppiati alcuni mesi più tardi – in effetti nel 1969 ed ha la data convenzionale del suo inizio al 12 dicembre di quell’anno, l’eccidio di Piazza Fontana con cui cominciò “la notte della Repubblica”.
C’era comunque qualcosa che ci interessava molto. I colleghi francesi si procuravano copie della stampa del “Sessantotto” nella loro Patria. Il lessico, il linguaggio era straordinariamente involuto e, per certi aspetti, di difficile comprensione. Ciò non poteva attribuirsi unicamente o principalmente al fatto che tra noi la “lingua franca” era l’inglese (notoriamente lineare, semplice e secco). Una componente era verosimilmente il fatto che i “sessantottini” del maggio francese avevano difficoltà a comunicare le loro idee, le loro strategie (ove fossero esistiti) e soprattutto i loro programmi (ove ci fossero stati). Una difficoltà che contrassegnava confusione di pensiero più che di parola.
Ebbi pure io un contatto diretto con il “maggio” francese. Rientrando in Europa (con la mia futura moglie) ci fermammo a Parigi mentre viaggiavamo alla volta della Borgogna (dove andavo a farmi conoscere dai suoceri). Venimmo ospitati dal prozio di mia moglie che allora aveva un appartamento sull’Ile Saint Louis: vedevamo gli scontri tra dimostranti e forze dell’ordine nel quartiere latino, era in corso la “battaglia dell’Odéon”; dai giornali ci sembrava difficile comprendere cosa volesse chi (in breve quale fosse il nolo del contendere). Soprattutto trovammo fastidioso (nonché faticoso) arrivare a piedi (e con le valigie) alla Gare de Lyon (oggi Gare Bercy) - da dove andavamo in Borgogna - a ragione di uno sciopero di tutti i mezzi di trasporto. Ci fu, però, un curioso aspetto positivo: il sindaco di Colonzelle (piccolissimo comune della Provenza occidentale) ci sposò “sulla parola” (a causa di uno sciopero al Comune di Roma i documenti che mi riguardavano arrivarono con numerosi mesi di ritardo rispetto alla data delle nozze) sia a ragione del clima libertario (si era nell’agosto 1968) sia in quanto in dieci anni nelle vesti di primo cittadino non aveva celebrato alcun matrimonio (a causa dell’invecchiamento dei concittadini e del progressivo spopolamento del villaggio).
Epilogo Dall’autunno del 1968 (rientro negli Usa per prendere servizio in Banca Mondiale), presi raramente il cannocchiale per guardare al “Sessattotto” italiano: l’autunno caldo, i primi cenni di terrorismo erano rumori di fondo per una giovane famiglia che viveva negli Usa in cui nasceva la nostra prima figlia ed il lavoro portava me per diversi mesi l’anno in Estremo Oriente (dove il “Settantotto” italiano era ancora più lontano). Le vacanze in Italia (ed in Francia) erano una corsa da congiunto a congiunto per farsi vedere e mostrare la prole (normale per chi vive all’estero). All’inizio dell’estate del 1972, passai tre settimane in Italia. Si era nella “notte della Repubblica”, ma non lo avvertivo. Dopo ormai cinque anni negli Usa, Roma mi sembra délabrée e malmessa in un’atmosfera da Europa centro-orientale. Incrociai Adriano Sofri, che avevo conosciuto ai tempi dell’Università in quanto frequentavamo lo stesso stabilimento balneare. Ci parlammo senza che l’uno capisse quello che diceva l’altro; il “Sessantotto” – dissi a me stesso – era stato un potente strumento di incomunicabilità. Il ricordo mi tornò al 1968 alla Sais- al Professore di Economia Internazionale Isiah Frank (morto quasi centenario pochi anni fa e docente brillante sino all’età di 90 anni). Iniziava qualsiasi lezione con un cordiale “Buon giorno a tutti” e la terminava (anche dopo le spiegazioni più astratte) con “Arrivederci e soprattutto non fatevi mai illusioni!” . Adriano ed altri -pensai - se ne erano fatte. A sproposito.
domenica 20 gennaio 2008
Il 68 europeo visto dagli Usa aveva già i colori del declino
Etichette:
68,
Storia,
Unione Sovietica,
Usa
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
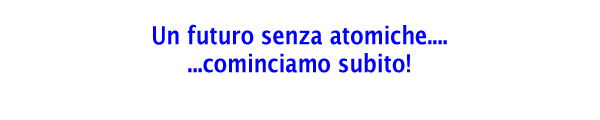





































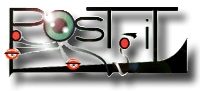
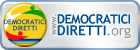
















Nessun commento:
Posta un commento