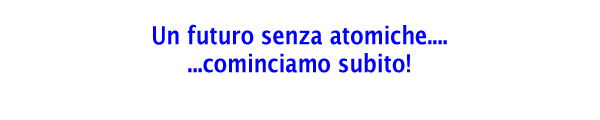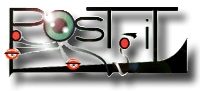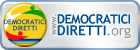mi trasferisco, da oggi il nuovo sito che prende il nome di anarchismo liberale è qui:
mercoledì 5 maggio 2010
MI TRASFERISCO!
martedì 4 maggio 2010
MUTUALISMO, ED IN FRANCIA SI FOTTE LO STATO!

di Domenico Letizia
RIPORTA IL CORRIERE DELLA SERA DI OGGI: "La stampa francese l'ha ribattezzata "la mutua dei truffatori" perché nell'ultimo anno ha fatto perdere circa 80 milioni di euro alla Ratp, la società che gestisce i mezzi di trasporto parigini. Sono piccole associazioni non autorizzate formate da studenti, disoccupati e squattrinati che truffano quotidianamente la società transalpina con un sistema semplice: ogni mese ciascun membro versa alla sua associazione una quota di 7 euro e viaggia senza biglietto sui mezzi pubblici della capitale. Coloro che incappano nei controlli pagano le multe attingendo alla cassa comune della propria associazione e i risultati premiano sempre i trasgressori: il numero dei "senza biglietto" è di gran lunga superiore a quello dei sanzionati visto che la Ratp può contare solo su 968 controllori".
Chi ha detto che le società di “mutuo soccorso” non funzionano? in Francia, stavolta davvero originali, il mutualismo è divenuto lo strumento di critica alla gestione statale dei trasporti: "Piccole associazioni non autorizzate formate da studenti, disoccupati... ogni mese ciascun membro versa alla sua associazione una quota di 7 euro e viaggia senza biglietto sui mezzi pubblici della capitale. Coloro che incappano nei controlli pagano le multe attingendo alla cassa comune della propria associazione e i risultati premiano sempre i trasgressori: il numero dei "senza biglietto" è di gran lunga superiore a quello dei sanzionati
Frédéric, studente di 22 anni, dichiara al quotidiano parigino: «In tutto versiamo 7 euro al mese e con questa quota riusciamo a pagare le multe che i membri della nostra associazione ricevono sui mezzi di trasporto. Alla fine dell'anno nelle casse dell'associazione sono rimasti solo 3 euro». Ma come spiega Michael, un altro studente parigino, lo scopo vero fine dell'associazione è politico: «Non è giusto che le persone che vivono in periferia debbano pagare prezzi esorbitanti per viaggiare. Invece i parigini che vivono al centro e che sono molto più ricchi pagano molto meno»". (http://www.corriere.it/cronache/10_maggio_04/mutua-truffatori-parigi-francesco-tortora_8da97528-5775-11df-8ce3-00144f02aabe.shtml)
Bravi! con una gestione mutualista si sta criticando lo stato e la sua interferenza nel mercato, ora va fatto capire a questi studenti che invece di pretendere più stato e più assistenzialismo sono proprio queste loro azioni che dimostrano non solo come lo stato è fallimentare nella gestione della “cosa pubblica” ma che questi sono anche metodi gestionali antistatalisti e funzionali perchè all'ombra dello stato e di certo, come si nota, funzionano!
(http://www.movimentolibertario.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5134:mutualismo-ed-in-francia-si-fotte-lo-stato&catid=1:latest-news)
domenica 2 maggio 2010
Contro-economia al Meridione
CONTRO ECONOMIA: Preferire ai mercati regolamentati e tassati dallo Stato Italiano che con i nostri soldi finanzia il Nord, i mercati deregolati e non tassati, ovvero i mercati neri. I soldi che paghiamo con le tasse che fine fanno? Il governo di Roma è come un vampiro che succhia il sangue dalla sua vittima, però nei film i vampiri non possono entrare nella tua casa se non sei tu ad invitarli. Vale lo stesso per il governo, quando compriamo un bene, con la certificazione introduciamo il governo nella nostra vita. Così ogni attività in nero elude il governo. E’ l’unica soluzione per far sì che il nostro denaro resti sul territorio e non corra per canali e canalini verso Roma. Lo stato difende le aziende del nord che monopolizzano il nostro territorio e estraggono risorse, godendo di privilegi e distribuendosi il bottino. E’ una scelta perseguibile del consumatore, ma anche dal produttore o dal commerciante. Indeboliamo lo Stato italiano attaccandolo sul lato economico, affidiamoci quando compriamo ai mercati non regolati, alle ‘bancarelle’, agli ‘abusivi’ e a tutti quei piccoli commercianti che esercitano la professione alle spalle della burocrazia e della tassazione dello stato, nessun scontrino, nessuna tassazione, nessuna estorsione mafiosa del fisco.
http://comitatiduesicilie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2935&Itemid=77
mercoledì 28 aprile 2010
Figlio della Libertà: Lysander Spooner

Tra i più conosciuti anarchici individualisti della tradizione americana, sconosciuto per i più alla tradizione europea, ricordiamo Lysander Spooner nato il 19 Gennaio 1808 e morto il 14 Marzo 1887.
Spooner è certamente una delle mentalità più forti che la tradizione libertaria possa ricordare, in prima persona a battersi per una società antistato è stato paladino delle libertà individuali: I vizi non sono crimini ripeteva nella sua america sempre più oppressiva e sempre meno libera.
Ammirato anche dalla tradizione liberale americana, Spooner ha fatto della sua vita una lotta al monopolio statale, fonda una compagnia postale indipendente da quella nazionale nel 1844, la compagnia postale statale, unica autorizzata, grazie ad una legge suscita malcontento diffuso, date le alte tariffe e Spooner decide, privatamente, di organizzare il proprio servizio antistatalista. L’iniziativa ottiene un ottimo successo commerciale ma la compagnia cade in una sistematica repressione da parte delle forze stataliste, i dipendenti dell’agenzia vengono arrestati e i vettori ricevono minacce di ritorsione qualora non interrompano di sostenere l’agenzia di Spooner, come facile immaginare alla fine la compagnia fallisce.
L’anarco-individualista Benjamin R. Tucker, amico personale di Spooner, nel ricordare la sua scomparsa pubblica un articolo che appare su “Liberty” del 28-05-1887, qui Tucker oltre che rimpiangere la morte dell’amico ne illustra il pensiero soffermandosi sulla questione dei monopoli e della sua lotta allo stato: “ … ciò cui Spooner tirava colpi era il monopolio, e questo permane ancora oggi, più stabile e radicato che mai, favorendo una quantità di danni cui la competizione potrebbe subito rimediare. La gente è stata dissuasa dal chiederne l’abolizione grazie alle ripetute riduzioni concesse come altrettanti bocconi….” Spooner è stato tra i precursori di uno sperimentalismo volontarista e libertario che la cultura originaria americana ha ben assorbito per poi dimenticare completamente, ha ragione Pietro Adamo nel ritenere che alla metà dell’Ottocento, Lysander Spooner, certamente pensava potesse essere allargato il “modello far west”, cioè una società di piccoli agricoltori, o di piccoli imprenditori, in grado di reggersi da soli -con la loro famiglia, la loro impresa-, proprio perché erano autonomi, liberi, sul territorio. Questo era, in fondo, un ideale che risaliva ai jeffersoniani del secolo precedente; era l’ideale, appunto, di una nazione di agricoltori indipendenti e autonomi che potevano benissimo costruirsi una società libera per loro conto, senza alcun bisogno di avere rapporti strutturati con l’esterno.
L’invito che posso fare è quello di ricercare e studiare il pensiero di Spooner in particolare la sua opera: La costituzione senza autorità. La critica di Spooner alla costituzione americana del 1787 discende tutta da un presupposto semplicemente pragmatico: secondo Spooner un contratto, per essere valido, deve essere stipulato da persone fisiche in rapporto tra loro, messo per iscritto, firmato dalle parti. Senza questa procedura un contratto non ha alcuna autorità e non produce alcun obbligo. Spooner riteneva che i governanti usassero la costituzione come null'altro che una raccolta di belle frasi che nessuno intende davvero realizzare.
Sarebbe davvero lodevole intitolare un circolo o un club libertario a questa figura dell’anarchismo individualista, sarebbe ancora più giusto intitolarlo nella città di Caserta, città ove la tassazione era
Fino a pochi mesi fa anche sui banchetti e il volantinaggio ( la battaglia contro questi diritti d’istruttoria contro il comune di Caserta è stata vinta grazie alla cittadinanza e ai Radicali di Caserta).
Domenico Letizia
Seme Anarchico “periodico di informazione anarchica”
Anno 31 n 19 Aprile 2010
lunedì 26 aprile 2010
Il genocidio dimenticato, quello Armeno

La caratteristica di questo genocidio è stata finora il silenzio: al silenzio degli assassini si è aggiunto quello degli Stati, delle vittime, delle diplomazie e delle coscienze degli uomini.
I pochi Armeni che sono riusciti a fuggire al massacro si sono rifugiati in tutti i paesi del mondo, si sono messi a lavorare, hanno rispettato le leggi dei paesi che li hanno ospitati e hanno costruito famiglie. Non hanno parlato delle terre che hanno dovuto abbandonare per sopravvivere: è come se avessero cercato di dimenticare per trovare la pace in una nuova vita. Ma il ricordo delle case abbandonate, dei genitori, dei fratelli, degli amici e degli amori massacrati non si può spegnere; questo peso si può sopportare in silenzio, ma il ricordo si trasmette dai padri ai figli e con il tempo il silenzio diventa insopportabile.
In questi giorni, ho scritto un libretto intitolato “24 Aprile. Non lasciamoli soli”. L’ho scritto per ricordare la data del 24 Aprile e per descrivere come è avvenuto anni fa il riconoscimento del genocidio da parte della Camera dei Deputati. Continuando a sperare che lo straordinario esempio della Francia sia seguito dai Parlamenti di tutti i paesi membri dell’UE.
Spero troviate interessanti le pagine che le allego e , in questo caso, le sarò molto grato se troverà il tempo per “girare” questo testo a quante più persone possibile.
Con la più viva cordialità
Giancarlo Pagliarini
(lettera inviata al Movimento Libertario)
sabato 24 aprile 2010
Massoneria e Anarchismo

di Luigi Corvaglia
Un po' di chiarezza per sgomberare il campo da due contrapposti miti, quello della filiazione del movimento anarchico dalla Massoneria (diffuso dal tradizionalismo cattolico e da Forza Nuova), e quello della assoluta incompatibilità fra movimento anarchico e libera muratoria (diffuso fra gli anarchici meno consapevoli della storia).
“L'8 gennaio 1847, venni accolto come Massone, col grado di apprendista, nella Loggia Sincerità, Perfetta Unione e Costante Amicizia, 'Oriente di Besançon'. Come ogni neofita, prima di ricevere la Luce, dovetti rispondere a tre quesiti d'uso: Cosa deve l'uomo ai suoi simili? Cosa deve alla sua patria? Cosa deve a Dio? Alle due prime domande, la mia prima risposta fu all'incirca, quella prevedibile; alla terza io risposi con questa parola: la GUERRA: Giustizia a tutti gli uomini, Devozione al proprio paese, Guerra a Dio, cioè all'Assoluto. Tale fu la mia professione di fede. Io domando perdono ai miei rispettabili fratelli per la sorpresa che causò loro questa parola, specie di smentita al motto massonico, che io ricordo qui senza derisione, ALLA GLORIA DEL GRANDE ARCHITETTO DELL'UNIVERSO. (……) Seguì una lunga discussione che le usanze massoniche mi impediscono di riferire. (…..) L'antiteismo, non è l'ateismo: verrà un tempo, io spero, in cui la conoscenza delle leggi dell'animo umano, dei principi della giustizia e della ragione, giustificherà questa distinzione, tanto profonda quanto apparentemente puerile.”[1] Questa narrazione di Pierre Joseph Proudhon, padre dell’anarchismo, mostra, più di altre, il misto di fascinazione e conflittualità su cui si fonda la relazione fra pensiero anarchico e massoneria. Relazione non facile, certo, eppure non così travagliata come si potrebbe pensare. Anarchismo e libera muratoria, infatti, si sono spesso stretti in lunghi e insospettati abbracci. Il primo avvenne all’epoca della cosiddetta I Internazionale. Fin dalla sua costituzione, nel 1864, questa organizzazione venne attraversata dai grandi contrasti interni fra le diverse anime che la costituivano, cioè i marxisti, i socialisti moderati, i mazziniani e gli anarchici. Proprio quest’ultimi riuscirono a prendere in mano le redini del movimento in Italia. Orbene, come ha scritto Marco Novarino, molti anarchici “nel loro lavoro di penetrazione e d’egemonizzazione della Prima Internazionale transitarono sotto “le volte stellate” per cercare di trasformare la massoneria in un movimento rivoluzionario antiautoritario e antireligioso” [2]. Tale intento, così distante dai precetti di neutralità previsti dalle Costituzioni di Anderson, appariva sostenibile, non solo sulla base dei ben noti principi massonici di libertà, fratellanza ed uguaglianza o della adogmaticità del metodo “di lavoro”, ma anche alla luce del fatto che le massonerie latine, a seguito della scomunica papale, avevano perso in attrattiva per i cattolici ma guadagnato molto in furore anticlericale e fervore civile. Del resto, per il suo carattere democratico, la Massoneria offriva già da tempo un ricetto propizio a quanti rifiutavano ogni tipo di sistema politico assolutistico. Non pochi anarchici, poi, appartenevano all’allora crescente movimento per il ”Libero Pensiero”. Scrive Pedro Alvarez Lazaro che “Il travaso ideologico fra Libero Pensiero e Massoneria si canalizzò in due direzioni: da un lato molti nuclei liberopensatori non erano in realtà che emanazioni profane di talune logge ed Obbedienza; su un altro versante le Massonerie di ispirazione razionalistica andavano ingrossando le proprie fila con liberi pensatori militanti”[3]. E’ nel via vai di questo scambio che molti anarchici si trovarono “sotto le volte stellate” dei templi. Non si ritiene, allora, di poter condividere in toto l’idea del Novarino che vede il fallimento dell’opera di costruzione di una “Massoneria rivoluzionaria” nel fatto che “era difficile per un anarchico, fondamentalmente refrattario al concetto di trascendenza e alla struttura gerarchica, trovarsi in sintonia con la spiritualità e l’organizzazione ritualistica massonica, pur se i principi di libertà, fratellanza ed uguaglianza erano condivisi.” [4] Infatti, l’idea di una “refrattarietà” degli anarchici a “trascendenza” e “struttura gerarchica” non rende giustizia alla fedele e totale adesione alla massoneria di illustri pensatori ed agitatori anarchici quali Elisee Reclus, Louise Michel, Andrea Costa (che, però, non rimase fedele all’anarchismo) e, soprattutto, Francisco Ferrer. La “refrattarietà”, piuttosto, sembrerebbe essere stata quella della preponderante massa di fratelli che, pur se spesso in un’ottica irregolare, secondo i canoni della Gran Loggia Unita d’Inghilterra, non piegarono l’Istituzione a strumento per i fini, e con i mezzi, che solo alcuni di loro propagandavano. Esemplare il caso di Mikahil Bakunin. Il noto rivoluzionario russo, iniziato probabilmente in Svezia, si dimostrò talmente poco refrattario alla struttura della massoneria che creò, prima a Firenze, poi a Napoli, una serie di società, quali la “Fratellanza Rivoluzionaria”, che avevano una “organizzazione piramidale” e “un rituale di iniziazione di sapore marcatamente massonico”[5].
Scrive Luigi Paolo Friz che l’adesione di Bakunin alla massoneria è fatto storicamente “sopravvalutato o negletto”[6]. Negletto, andrebbe aggiunto, soprattutto dagli anarchici, in particolare gli italiani, abbastanza suggestionati dalla lettura gramsciana della massoneria quale “partito della borghesia” e da note deviazioni di cui la storia serba recente traccia. Sopravvalutato, invece, soprattutto dall’anti-massonismo del tradizionalismo cattolico che vede nell’adesione del rivoluzionario russo una delle più valide prove dei nefandi scopi dell’Istituzione. Per quanto non si conosca con esattezza la loggia alla quale egli fu iniziato, nel 1845, ciò che è certo è che a Torino Bakunin fu accompagnato da una lettera di Klapka per il Gran Maestro Frappolli, in cui, tra l’altro, si legge: “l’ho condotto nel nuovo locale massonico e l’ho ricevuto Rosa-Croce sotto la volta celeste”[7]. Scrivendo a Garibaldi, Bakunin raccontava da Firenze di Blanche “Maestro massone che gli amici fiorentini stavano per elevare al 30 grado e forse anche più per consentirgli di fare in Svezia ciò che lui faceva in Italia, disorganizzare la Massoneria governativa e sostituirla con una democratica”[8]. I fini di questa Istituzione democratica “l’emancipazione completa dell’uomo, la costituzione dell’umanità sulle rovine di ogni autorità”[9] . Anni dopo, l’agitatore russo riconosce essere la Massoneria “scesa al triste ruolo di vecchia intrigante rimbambita, (organizzazione che) non vale nulla essendo inutile, qualche volta nociva e sempre ridicola”[10]; prima del 1830, però, “avendo riunito nel suo seno, con poche eccezioni, tutti gli spiriti elevati, i cuori più ardenti, le volontà più fiere, i caratteri più audaci” aveva rappresentato l’ “incarnazione energica e la messa in pratica dell’idea umanitaria del XVIII secolo”[11]. Come disse il massone Giannelli all’anarchico Nettlau, “Bakunin aveva fiducia nella massoneria in genere, era esso stesso massone, ma s’ingannava ritenendo che codesta Istituzione, guidata allora in Italia da Frappolli, potesse neppure minimamente accettare o appoggiare le sue idee nihiliste”[12]. Egli, in pratica, aveva fiducia della Massoneria quale “incarnazione energica” e “messa in pratica dell’idea umanitaria del XVIII secolo”[13], ma la perse nei massoni. Stessa sorte toccò a Errico Maltesta, il quale, nella convinzione che farne una organizzazione rivoluzionaria significasse “riportare la massoneria alle sue origini ideali”[14], abbandonò il tempio dopo che la sua loggia decise di ricevere il ministro Nicotera con musica e bandiere[15].
Anche il gesuita Ugo Mioni scrisse che l'anarchia fu, per un po', al traino della massoneria, ma quest'ultima, in mano alla borghesia (“guidaica”, egli scriveva col consueto spirito del cattolico più sospettoso) era poco incline alla rivoluzione[16].
Tali fatti, però, lungi dal dimostrare un’incompatibilità fra il professare l’idea libertaria e l’adesione alla Massoneria, cosa che, altrimenti, non avrebbe portato le maggiori teste pensanti del movimento a farsi iniziare, testimoniano esclusivamente dell’incongruenza fra la pretesa di trasformare una Istituzione di uomini che si suppongono, o almeno si proclamano, liberi in strumento di una sola idea, piuttosto che vedere la libera muratoria, nella sua versione ideale che attrasse Bakunin, come l’ambiente di coltura per lo sviluppo di idee, ognuno le sue, che gli uomini potranno poi mettere in pratica fuori. Fulgida espressione di tale coscienza fu Francisco Ferrer Y Guardia. L’ anarchico catalano, massone fin dall’adolescenza, traspose i suoi ideali di libertà e tolleranza nella creazione della “Escuola Moderna”, un progetto educativo basato sull’ educazione razionale e scientifica da impartire senza instillare idee preconcette né dogmi, di cui il bambino è ancora sprovvisto. La scuola di Ferrer pubblicava, tra l’altro, anche dei bollettini ai quali collaborarono illustri esponenti del mondo anarchico e/o massonico, come il geografo Elisee Reclus, lo scrittore Lev Tolstoj e l’antropologo Petr Kropotkin (ma anche di Anatole France, Herbert Spencer, Ernst Haeckel). La rivoluzionarietà del progetto di Ferrer è testimoniato dalla sua fucilazione in seguito a un processo farsa che lo volle dichiarare l’ispiratore della “Semana tragica”, la rivolta scoppiata quando la popolazione si ribellò alla Guardia Civil che aveva il compito di imbarcare i coscritti mandati a combattere le guerre coloniali in Africa[17].
Sarà sempre la Catalogna, alcuni decenni dopo, il teatro dell’ultimo abbraccio fra anarchismo e massoneria. Infatti, durante la guerra civile spagnola (1936-39) che portò al governo anche gli anarchici, Il Supremo Consiglio del Rito Scozzese proclamava il 6 Luglio 1938: “La massoneria spagnola ha formulato dichiarazioni pubbliche chiare e coerenti di adesione al governo della repubblica e al Fronte Popolare”. L’alternativa era il fascismo di Francisco Franco. Non è dunque un caso che il noto simbolo anarchico della “A cerchiata”, la cui diffusione viene in genere riferita all’opera del gruppo anarchico milanese negli anni sessanta, compare, in realtà, nei primi anni del secolo XX proprio in Spagna ed in una conformazione realmente interessante[18]. Il simbolo dell’ Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), gruppo anarco-sindacalista, fu usato per la prima volta al Consiglio Federale di Spagna e rappresenta una “livella in un cerchio”, con tanto di “filo a piombo”, segno di rettitudine morale.
[1] Proudhon, J.P., La Giustizia nella Rivoluzione e nella Chiesa, pag. 694
[2] http://www.bicentenario-goi.it/Relatori_Palermo.pdf
[3] Alvarez Lazaro, P., Libero Pensiero e Massoneria, Gangemi, Roma, 1991, pag. 102
[4] ibidem
[5] http://italian.ruvr.ru/main.php?lng=ita&q=65&cid=85&p=19.12.2006&pn=1
[6] Friz, L. P. La massoneria italiana nel periodo postunitario. Lodovico Frappolli, Franco Angeli, Milano, 1998, pag. 82
[7] ibidem
[8] ibidem
[9] Friz, L. P. La massoneria italiana nel periodo postunitario. Lodovico Frappolli, Franco Angeli, Milano, 1998, pag. 83
[10] ibidem
[11] ibidem
[12] ibidem
[13] ibidem
[14] http://www.bicentenario-goi.it/Relatori_Palermo.pdf
[15] http://www.anarca-bolo.ch/a-rivista/295/56.htm
[16] Mioni, U., I sogni dell’anarchico, Il Litorale Libri, 2008
[17] www.anarca-bolo.ch/a-rivista/261/34.htm
[18] Valin Fernadez, A., LA MASONERÍA Y EL MOVIMIENTO OBRERO: IMAGOS E IDEAS PARA UNA REFLEXIÓN TEÓRICA http://tallerediciones.com/cuza/masonesyobreros.htm
dalla Rivista Libertaria "Tarantula"
giovedì 22 aprile 2010
Libertiamo, beh... Censura!
Nussun commento, vi riporto solo al blog di Luca, tulla la vicenda lì: http://iovotopli.wordpress.com/2010/04/22/libertiamo%E2%80%A6-una-bella-sega/
mercoledì 21 aprile 2010
martedì 20 aprile 2010
Fuori lo Stato dall' università

Giuseppe Motta
Soltanto un cieco o un alienato mentale può continuare a ignorare o a negare che il bilancio dell’occupazione integrale dell’Università da parte degli Stati, durata circa due secoli, è fallimentare su tutti i fronti. Le Università migliori del mondo sono oggi quelle che sono riuscite, almeno parzialmente, a sganciarsi e a liberarsi da questo bacio della morte, da questa morsa, da questa gabbia d’acciaio, da questa camicia di forza politico-burocratica imposta a un sistema nato in Europa come espressione di libertà e di indipendenza del pensiero e della conoscenza.
Dai monasteri mecenati alle città libere, delle quali sono state esempio per tutto il mondo quelle centro-settentrionali italiane, l’Università ha visto uno sviluppo ininterrotto delle sue potenzialità e capacità, con la preparazione di specialisti e di scienziati. L’Università è una creazione del Medioevo e in essa per secoli si sono formati i pensatori più audaci, gli spiriti più liberi e più creativi, riuniti in fraternità di insegnanti e discepoli, in federazioni di collegi.
Quando poi sono diventate tutt’uno con le città, simboli del loro orgoglio, le Università hanno dimostrato la loro indipendenza anche dall’influenza ecclesiastica, trasformandosi in centri di studio e riflessione libera, aperta al nuovo.
La figura del professore vecchio e fossilizzato nelle sue idee obsolete e stantie, magari formulate vent’anni prima, nel tardo Medioevo era una figura sconosciuta: appartiene tutta all’età moderna. Le Università sono state la culla della civiltà europea, senza le quali questa non è nemmeno concepibile o comprensibile. Soprattutto però le Università sono state libere creazioni di associazioni, il frutto dell’iniziativa privata e non di quella politica.
L’apparizione di nuove Università per secoli è stata stimolata dalla continua formazione di gruppi autonomi di professori che si separavano dall’Università di appartenenza (ad esempio Padova da Bologna), al fine di costruirne una nuova, più consona ai loro ideali e libera da influenze politiche.
Così le Università sono state generalmente il frutto dell’organizzazione spontanea, dell’associazione volontaria: da quella dei gruppi di professori, a quella degli studenti (che vi esercitavano un grande controllo, come a Bologna), che hanno conservato per secoli i loro statuti e le loro tradizioni: un insieme composito che ha prodotto un’esplosione di studi e di scienza senza precedenti nella storia umana.
Tutto questo perché erano studia generalia liberi dalla minaccia pel potere politico e religioso e riunivano persone desiderose di imparare ed altre che volevano mettere a disposizione le loro conoscenze e che venivano pagate in misura della loro bravura.
Tra i Professori vi erano differenze di reddito e prestigio, secondo le Facoltà, che erano in concorrenza tra loro. Per studiare si andava lontano, dove avvenivano le più belle “battaglie intellettuali”, condotte da maestri universitari itineranti e di qualità internazionale riconosciuta. Perfino contadini o figli di calzolai riuscivano a diventare nobili dopo lo studio nell’Università, con una evidente ascesa sociale. Non a caso allo studio si riconosceva una grande importanza sociale. Per gli studenti poveri esistevano le “provvidenze” stabilite dalle stesse Università come privilegium paupertatis.
Il New College di Oxford fra il 1380 e il 1500 era composto per più del 61% di figli di contadini e il numero di studenti di origini rurali era nettamente superiore a quello degli studenti di origini urbane. Inoltre gli studenti, che riuscivano sempre a conoscere l’ebbrezza della libertà intellettuale negli “studi che liberano” (Giovanni di Salisbury) non erano sottoposti alle leggi che valevano per i cittadini comuni e godevano di consistenti sgravi fiscali. Nessuna autorità accademica determinava gli incarichi e i titoli.
Queste istituzioni costituivano il vero tessuto, quello culturale, dell’Europa senza confini, della quale l’Unione Europea attuale, confinaria e statalista, non è che una pessima e tragicomica caricatura.
Nell’epoca della Riforma tuttavia è iniziata l’occupazione statale, la sottomissione al controllo regio, che è diventata sempre più massiccia e militare, fino all’epoca devastante del Nazionalismo.
Trasformatesi a partire dall’Ottocento sotto imposizione governativa in fabbriche di burocrati sia all’interno (i Professori trasformati in “burocrati della scienza”) che verso l’esterno (produzione di amministratori e servitori) e in strumento di controllo di Stato, sul modello europeo-continentale della centralizzata “Università Imperiale” francese, l’Università europea è decaduta, fino a raggiungere il livello disastroso di quella italiana attuale.
Di Università considerate ovunque per secoli le migliori del mondo (Bologna, Padova, Pavia, ecc.), sono rimasti fantasmi.
Persino quelle che oggi continuano a figurare come “private” sono di fatto dipendenti dallo Stato, perfettamente inserite nel sistema statale. Assaltate da bande di predoni estranei alla scienza, sono diventate centri di potere, prede di partiti e consorterie, bottino di una lotta politica tanto imponente quanto distruttiva, centri di parassitismo devastati da cavallette e sanguisughe.
Il potere politico le affama per tenerle sottomesse.
Burocrati della conoscenza dettano “l’agenda degli studi”, condannando i non-conformisti, che sono stati la linfa vitale delle Università storiche, fondate su un sapere libero e polemico, insofferente dei dogmi, al palo e alla fine della carriera. Ma nei primi secoli dell’istituzione universitaria chi accedeva al titolo di dottore poteva insegnare il giorno successivo.
Il livello culturale delle Università brutalmente statalizzate è andato precipitando negli ultimi due secoli.
Lo Stato è l’antitesi dello spirito e del movimento universitario, fondato sulla totale libertà di pensiero e sull’autogoverno.
Fuori lo Stato dalle Università!
domenica 18 aprile 2010
Ricordando Ward

La scomparsa del militante e pensatore anarchico inglese costituisce un momento di dolore per chi l’ha conosciuto, ma anche di riconoscimento e gratitudine per il contributo davvero eccezionale che Colin ha dato ad una visione moderna e realistica dell’anarchismo.
La sera dell’undici febbraio di quest’anno è morto, all’ospedale di Ipswich, Colin Ward. Una e-mail della sua insostituibile compagna, Harriet, ce lo comunicava subito con poche toccanti parole.
Colin è stato ed è, per me, tuttora un maestro, una persona che non ti rivela mai la verità, ma umilmente ti incita a cercarla dentro di te e nelle piccole quotidiane cose della vita. L’averlo conosciuto e l’averlo sentito amico mi appare ora più che mai un privilegio e il vuoto che egli lascia dentro di me, e in altri come me che l’hanno conosciuto e frequentato, è veramente grande.
Colin appartiene a una generazione ormai molto rara di anarchici che, dal dopoguerra ad oggi, hanno tenuto accesa la luce del nostro ideale e testimoniato, con la loro coerente vita, la loro scelta, nobilitando con una sensibilità e una umanità vera e profonda, l’idea anarchica stessa.
La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nella rete (lui che usava ancora la sua vecchia macchina da scrivere!) e nella stampa di tutto il mondo e numerose e sincere sono state le testimonianze di dolore e dispiacere che sono arrivate ad Harriet e all’intera famiglia. Non solo nel milieu anarchico e libertario questa notizia ha turbato gli animi di molti di noi, ma soprattutto in una vasta area di uomini e donne che si sono incrociate, personalmente o attraverso i suoi numerosi scritti, con questa persona così umanamente sensibile e dotata di una cultura così poco ostentata ma così profonda e intelligente (solo nel 2001 riceverà un dottorato onorario in filosofia).
Da un articolo di Francesco Codello, il resto su "A Rivista Anarchica"
Colin Ward ha saputo descrivere in modo esemplare l’uso non convenzionale che gli esseri umani (a partire dai bambini) fanno del loro ambiente, delle loro città, delle loro scuole, dei loro giochi e delle loro attività, quando si liberano dall’egemonia soffocante del dominio, e come questo uso libertario ci permetta di intravedere che rapporti egualitari, solidali e liberi, esistono già e, pertanto, debbano essere incoraggiati, stimolati, creati e sviluppati per costruire fin da subito società diverse. Si badi bene, tante società sperimentali, non un’unica soluzione necessariamente totalitaria. Infatti egli ribadisce con forza che “l’alternativa anarchica è quella che propone la frammentazione e la scissione al posto della fusione, la diversità al posto dell’unità, propone insomma una massa di società e non una società di massa”.
mercoledì 14 aprile 2010
Torah e libertà

di Francesco Berti
Un recente libro di Furio Biagini analizza le relazioni tra pensiero ebraico e anarchismo. E ne sottolinea numerosi aspetti comuni.
Ne proponiamo qui una lettura critica.
Furio Biagini, docente di storia dell’ebraismo e di storia della filosofia ebraica all’Università del Salento, è autore di un volume il cui stesso titolo sembra, di primo acchito, un ossimoro: Torà e libertà. Studio sulle corrispondenze tra ebraismo ed anarchismo (Icaro, Lecce 2008, pp. 271, 12,00 euro). Da anni Biagini si dedica allo studio dell’ebraismo e delle sue connessioni con il movimento anarchico (1).
Non è da molto tempo, tuttavia, che si è cominciato a studiare le intersezioni tra ebraismo e anarchismo. Certo, si sapeva che molti appartenenti al popolo ebraico – un popolo vissuto per quasi 2000 anni, sia pure non per scelta, senza Stato, condizione che forse ha agevolato lo sviluppo di teorie critiche del potere politico in ambito ebraico – avevano aderito, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, all’anarchismo; si sapeva anche che alcuni di questi avevano avuto nel movimento un ruolo importante e riconosciuto – Emma Goldman, Alexander Berkman, Gustav Landauer, Bernard Lazare Vsevolod Mikhailovic Eichenbaum (Volin) – solo per citarne alcuni; si sapeva anche che alcuni tra i maggiori intellettuali del Novecento, ebrei di nascita e spesso anche di identità, erano stati vicini al movimento oppure avevano espresso, nelle loro opere, delle simpatie spiccatamente libertarie – Gershom Scholem, Martin Buber, Franz Kafka, Eric Fromm, Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Leo Löwenthal, Ernst Bloch; si sapeva, infine, che anche nel secondo dopoguerra molti ebrei avevano aderito alle idee anarchiche; tra di loro, alcuni intellettuali, artisti e scrittori di fama internazionale, come Paul Goodman, Julien Beck e Judith Malina, Murray Bookchin, Noam Chomsky.
Sebbene tutto ciò fosse relativamente conosciuto, non si era ritenuto, sino a qualche tempo fa, di farne l’oggetto di specifiche ricerche, anche perché l’incontro tra ebraismo e anarchismo era stato oscurato dall’adesione, ben più massiccia in termini quantitativi, di decine di migliaia di ebrei alle ideologie socialiste e marxiste. Il Convegno di studi tenuto a Venezia nel 2000, L’anarchico e l’ebreo. Storia di un incontro (da cui l’omonimo volume, curato da Amedeo Bertolo, Elèuthera, Milano 2001), ha certamente segnato un punto di svolta per lo sviluppo di queste ricerche, nelle quali si inseriscono anche i lavori di Biagini, la cui ultima fatica, però, si distingue dalla gran parte degli studi sinora pubblicati su questo argomento: riallacciandosi soprattutto alle ricerche di Gershom Scholem, Michael Löwy ed Arturo Schwarz (2), Biagini ha analizzato il fenomeno da una prospettiva diversa, cercando le corrispondenze tra il pensiero anarchico e l’ebraismo con esclusivo riferimento alla tradizione religiosa e storica del popolo ebraico.
In rivolta contro la religione dei padri
Che molti ebrei, tra Otto e Novecento, siano divenuti anarchici, non pare, in fondo, una cosa così singolare, soprattutto se si considerano la condizione di vita di centinaia di migliaia di ebrei negli shtetl alla fine del XIX secolo, le emigrazioni di massa di molti di questi ebrei dell’Europa orientale verso l’Inghilterra e le Americhe, dove venivano in contatto con sindacati, movimenti e partiti di sinistra, la voglia infine di riscatto sociale che accomunava il proletariato ebraico a quello non ebraico: desiderio di redenzione terrena che si incrociò inevitabilmente, per molti decenni, con le ideologie socialiste. Sebbene sia esistito anche un movimento anarchico ebraico con caratteri peculiari, è anche vero che molti ebrei che divennero anarchici rigettarono, o avevano già precedentemente ripudiato, la tradizione religiosa di provenienza, ed abbracciarono le idee anarchiche in rivolta contro la religione dei padri, percepita come oppressiva e castrante in generale la libera espressione dell’uomo e nello specifico il riscatto individuale e collettivo degli ebrei. Né può sorprendere che molti di costoro continuassero a rivendicare, insieme a quella anarchica, anche l’identità ebraica, una identità che è sempre stata prima etnica che religiosa, e i cui contorni, in età contemporanea, sono divenuti sempre più sfuggenti, a cavallo tra l’appartenenza religiosa, il legame nazionale, l’etica praticata, la dimensione culturale.
Ciò che davvero può apparire paradossale è il tentativo di rinvenire una dimensione libertaria nella religione ebraica, nei testi sacri dell’ebraismo, il Tanakh (la Bibbia ebraica, acronimo delle sue tre parti: Torah, Nevi’im, Khetuvim), la Ghemarà e la Mishnà (cioè il Talmud, la codificazione della Torah orale), il Midrash (i commenti rabbinici alle Scritture), la Qabbalà (la mistica ebraica), nonché nella storia del movimenti messianici ebraici. Sino ad oggi, pochi si erano spinti così avanti in un parallelo di questo tipo, che, relativamente invece alla religione cristiana, era stato compiuto dal grande teologo protestante Jacques Ellul (Anarchia e cristianesimo, Elèuthera, Milano 1993).
La legittima domanda che chiunque può porsi di fronte al lavoro di Biagini è la seguente: cosa può avere a che fare una tradizione religiosa fondata sul rispetto della legge – traduzione di torah, che in ebraico significa propriamente “insegnamento”, come ricorda l’autore – con l’anarchismo, una tradizione politica che si propone di liberare gli uomini da ogni autorità, in primis quella divina, e, nell’accezione comune, anche da ogni legge? Che legame può avere Bakunin – l’autore di Dio e lo Stato – con l’halakhà, l’insieme dei precetti, positivi e negativi, che un ebreo osservante deve seguire? Nella Torah sono indicati, come ha insegnato Moshè Ben Maimòn (Maimonide), il più grande filosofo ebreo del Medio Evo, ben 613 mitzvòt (precetti: cfr. Le 613 mitzvòt, a cura di M. Levy, Lamed, Roma 2007), sebbene molti di essi non siano ritenuti, per diverse ragioni, attuali. L’halakhà permea la vita dell’ebreo dall’istante in cui si sveglia a quello in cui si corica, giorno dopo giorno, ed ogni festa – Shabbat, Yom Kippur, Purim, Chanukkà, Pesach, Rosh ha-Shanà etc. – prevede non una diminuzione bensì un aumento di regole da osservare. Che un ebreo diventi anarchico non dovrebbe stupire; piuttosto, dovrebbe sorprendere il contrario, e in ogni caso ogni tentativo di trovare intersezioni può apparire – ad un rabbino come ad un anarchico – una “vile” provocazione, da ricambiare con una cherem (scomunica), da un lato, un calcio nel sedere, dall’altro.
Biagini, però, ci mostra che si può vedere la cosa anche da un diverso punto di vista. Un punto di vista particolare, certo non il più tradizionale, ma non per questo meno legittimo o del tutto nuovo. Rav Giuseppe Laras, rabbino capo di Milano, nella sua prefazione al libro succitato di Schwarz, ha scritto: «Di tipi come Arturo Schwarz, fra gli ebrei, ce ne sono parecchi; non solo, ce ne sono sempre stati». Tale osservazione, che va interpretata non nel senso di piccato disappunto, bensì in quello di ironico e benevolo ammiccamento, offre una patente di legittimità anche ad interpretazioni radicali delle Scritture come quelle di Schwarz o di Biagini, purché, ovviamente, fondate sul testo ed adeguatamente argomentate: è chiaro che con un “combinato disposto”, con l’estrapolazione cioè di alcune frasi da un testo e la loro successiva ricucitura, più o meno abile, si può far dire ad un autore anche il contrario di quello che voleva dire; tanto più se questo autore, come nel caso della Bibbia, … non ha scritto l’opera di suo pugno. Nel suo lavoro, Biagini chiarisce in che senso la sua interpretazione dell’ebraismo debba essere ritenuta pertinente: la Torah è sempre stato un libro vivente, sempre aperto a nuove interpretazioni. È il Talmud a dire: «Ogni epoca ha il proprio interprete delle Scritture» (‘Avodà Zarà 5a, cit. in Biagini, Torà e libertà, p. 15).
Le stesse autorità preposte al commento dei testi sacri si sono spesso dimostrate, nei secoli, adogmatiche. «Nel Talmud» – ricorda Biagini – «quando una questione viene risolta facilmente e non trova obiezioni è considerata negativamente» (p. 18). Nell’ebraismo il commento e l’interpretazione, la Torah orale e scritta, hanno la stessa importanza, perché l’Eterno ha rivelato a Mosè, sul monte Sinai, anche la Torah orale. Chiarito questo aspetto fondamentale, chiarito cioè che l’ebraismo si è sempre fondato su una sorta di “anarchismo metodologico”, parafrasando Feyrabend – Biagini ci conduce all’interno delle Scritture e dei commenti, individuando gli elementi che, nella tradizione ebraica, permettono una lettura “libertaria” dei testi sacri. Essi si legano strettamente alla speranza messianica, in quanto nella religione ebraica – una religione del fare, del vivere, non un viaggio puramente spirituale – si trovano diversi momenti che anticipano e vorrebbero fare pregustare quella che sarà la vita dopo l’avvento del Messia.
Libertà e legge sono antinomiche, ma...
Lo Shabbat, anzitutto, che visto dall’esterno appare un concentrato di imposizioni e divieti volti ad appesantire la vita dell’ebreo, può essere visto e vissuto, al contrario, come una giornata in cui i precetti negativi e positivi hanno lo scopo di liberare l’uomo dai problemi quotidiani, dal lavoro, anzitutto – e questo è uno dei più grandi contributi dell’ebraismo alla civiltà, la quale sembra ora volersene sbarazzare – ma anche dalle preoccupazioni e dagli affanni dello spirito; un giorno che è un inno alla vita, nel quale ciascuno è restituito ai suoi affetti, ai suoi cari, nel quale riflettere sul significato dell’esistenza, sulla bellezza del Creato, nel quale darsi ai piaceri, inclusi quelli sessuali. Un giorno, insomma, che è la santificazione della vita, come ha chiarito Abram Joshua Heschel (Il Sabato, Garzanti, Milano 2001). In questo senso, la domanda giusta non è “cosa viene impedito di fare il Sabato?”, bensì “cosa si è liberi di fare il Sabato grazie a quegli impedimenti?”. La prospettiva è opposta, ed è una prospettiva di libertà.
È ovvio (ad un anarchico, per lo meno) che libertà e legge, o libertà e costrizione, sono antinomiche, ma è pur vero che la libertà può esistere solo dove sono rispettate alcune leggi; ogni società si fonda, si è fondata e non potrà che fondarsi sempre sul rispetto di alcune norme – e tutte le società moderne ne prevedono ben più di 613 – che sono le condizioni grazie alle quali è possibile la vita in società, le “regole del gioco”. Contrariamente ad una opinione comune, l’anarchismo, se non nella versione stirneriana, non ha mai teorizzato una società senza leggi. L’anarchismo non è un movimento per l’abolizione delle norme, ma per l’abolizione dello Stato, e le due cose non sono affatto coincidenti. Arché in greco significa principio ma anche autorità, ed è in questa seconda accezione che gli anarchici hanno sempre inteso l’anarchia: an-archia, cioè assenza di autorità, o, meglio, assenza di dominio; una società senza un potere centrale che abbia il monopolio del diritto e delle forza, nella quale tutti i rapporti sociali, dalla politica all’economia, sono informati a valori non gerarchici; non una società senza princìpi, o senza leggi (3).
Tornando al libro di Biagini, egli ravvisa questo spirito libertario anche in altre istituzioni ebraiche, sempre pensate e vissute come anticipazioni del tempo messianico: l’anno sabbatico e, soprattutto, l’anno del giubileo, un anno che prevedeva una legislazione sociale nei confronti dei poveri, imponendo una redistribuzione delle ricchezze, la liberazione degli schiavi e la remissione dei debiti. Ma è lo stesso monoteismo ebraico, per Biagini, ad essere – paradossalmente? – passibile di una lettura libertaria: l’affermazione dell’unicità del Signore del primo comandamento è associata all’idea di liberazione, non solo spirituale ma anche materiale: «Io sono il Signore Iddio tuo che ti fece uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa degli schiavi»; l’affermazione dell’unicità dell’Eterno è seguita dal divieto di idolatria – «non avrai altri dèi al Mio cospetto» (Esodo, 20, 2-3) espressione che, ricorda Biagini sulla scia di Fromm, anticipa, per certi versi, quello di alienazione umana (p. 30).
In Torah e libertà si possono trovare numerosi riscontri di concetti e pratiche presenti nelle Scritture e nella storia dell’antico Israele che si possono prestare, ad avviso dell’autore, ad una interpretazione libertaria. Impossibile qui ricordarli tutti: uno dei più significativi – e sempre attuali – è laddove l’Eterno, nel Levitico, invita ad amare il Gher, lo Straniero: straniero non solo in senso proprio, perché tutti siamo figli di Adamo, ma anche figurato, vale a dire colui che è in stato di necessità e di bisogno, ossia il povero, la vedova, l’orfano. «Il principio fondamentale di giustizia sociale che scaturisce dalla Torah – scrive Biagini – è di proteggere chi non ha potere da chi lo esercita» (p. 42). In breve, l’autore cerca di evidenziare come la Torah, diversamente da quanto tramandatoci da una certa cultura cristiana e dallo stesso illuminismo, sia un libro di libertà, e che l’Eterno della Torah non sia il Dio degli eserciti, ma il Santo dell’amore verso il prossimo. Voltaire certo non concorderebbe, ma probabilmente sarebbe incuriosito dalle argomentazioni di Biagini.
Forse, se mi è consentita una critica, Biagini sembra spingersi un po’ troppo innanzi in questa lettura, per esempio quando scrive che nel Sinai il popolo ebraico ha ricevuto una sorta di «costituzione civile e politica», e che la Torah è un catalogo dei «diritti dell’uomo» (p. 54). A questo punto mi par di vedere il “patriarca dei Lumi” scoperchiare la sua tomba nel Pantheon ed uscirne veramente arrabbiato, e forse non del tutto a torto: questo lessico mi pare poco appropriato, perché le culture antiche – quella greca, quella romana e anche quella ebraica, per non parlare delle altre – non concepivano, come ha evidenziato tra i molti Isaiah Berlin (Libertà, a cura di H. Hardy, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 324-25) diritti soggettivi, diritti che vengono pensati e rivendicati solo in età moderna, in opposizione allo Stato assoluto: le “dieci parole” (id est il Decalogo) a me continuano a sembrare una lista di doveri, sia pure reciproci. Più convincente mi sembra Biagini quando rilegge l’esperienza del Sinai come una sorta di “contratto sociale”, una interpretazione che tra i primi propose, se non erro, Spinoza (Trattato telogico-politico, a cura di A. Dini, Bompiani, Milano 2001, pp. 561-65).
Messianesimo radicale e movimenti rivoluzionari
La seconda parte del libro è dedicata al messianesimo radicale ebraico: il messianesimo – nella versione moderata o radicale – è una delle componenti fondamentali della religione ebraica, una religione vissuta nel presente ma proiettata nel futuro, un futuro di liberazione spirituale ma anche materiale. Il messianesimo ebraico, anche nelle sue versioni più moderate, pone, in quanto tale, in virtù cioè della sua prospettiva teocratica, una ipoteca di legittimità su ogni autorità terrena: ogni potere dell’uomo sull’uomo è, in un certo senso, illegittimo, in quanto l’unico legittimo sovrano è il Signore, che dopo la venuta del Messia punirà i potenti e i tiranni e governerà direttamente il mondo (pp. 73-96). Gli anatemi dei profeti contro re e tiranni, così come le istituzioni simil-repubblicane che il popolo ebraico si diede per alcuni secoli, rappresentarono un costante punto di riferimento per molti pensatori e movimenti antitirannici o antimonarchici tout court (4). Alcuni libri della Torah – l’Esodo, in particolare, come ha evidenziato Michael Walzer (Esodo e rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 91-99) con la loro promessa di liberazione dalla schiavitù, hanno per secoli costituito un modello di libertà e l’archetipo stesso della rivoluzione. Non bisogna tuttavia dimenticare che, nella storia del popolo ebraico come in quella di tutti i popoli che l’hanno fatta propria, la prospettiva teocratica, come Biagini stesso riconosce, è servita sì (sempre) come strumento di delegittimazione del potere politico (laico), ma (spesso) anche in funzione della legittimazione del governo dei preti, di ogni ordine o grado: governo in cui diritto e morale coincidono, e dunque ancor più temibile, da un punto di vista libertario. Inoltre, se la “politeia biblica”, la respublica hebraeorum, è stata un costante riferimento, sino all’età moderna, per ribelli e repubblicani, molte parti del testo biblico, non solo quelle esplicitamente filo-monarchiche, sono state altresì – e prevalentemente, direi – utilizzate per difendere e legittimare il potere dei re, dei papi e in generale la struttura sociale gerarchica (5).
Biagini si sofferma su tre movimenti messianici radicali sviluppati nelle comunità ebraiche della diaspora, soprattutto dell’Europa orientale, tra XVI e XIX secolo: il movimento sabbatiano – fondato da Shabbetày Tzevì –, quello frankista – iniziato da Jacob Frank – infine quello hassidico – che prese le mosse dalla predicazione di Yisra’èl ben Eli’ezer.
Tali movimenti furono contraddistinti da uno zelotismo manicheo e da un nichilismo estremi, e furono accomunati dall’idea che il Messia, identificato con il fondatore del movimento, era finalmente arrivato e che era giunto il momento di distruggere ab imis fundamentis un mondo governato dal Male ed inquinato dalla corruzione, attraverso una condotta paradossalmente antinomica e pantoclastica, vale a dire distruttrice della halakhà, di tutte le norme di comportamento dell’ebreo. Solo così – pensavano i messianici radicali – si sarebbe potuti giungere all’era messianica, l’era in cui ogni dominazione sarebbe stata abolita, l’era della libertà e dell’uguaglianza assolute. Questi movimenti millenaristi radicali – osserva Biagini – non elaborarono un vero e proprio programma politico, ma crearono le premesse spirituali e culturali per lo sviluppo dei movimenti rivoluzionari moderni, in particolare quello anarchico (pp. 243-49).
L’ipotesi non è affatto strampalata. La connessione tra messianesimo radicale – ebraico e cristiano – e i movimenti rivoluzionari moderni – di estrema sinistra ma anche di estrema destra, giacché pure il nazismo fu un movimento rivoluzionario volto a distruggere la “corrotta” società liberale –, era già stata messa in rilievo, con argomentazioni convincenti, da importanti studiosi (6). L’impianto fondamentalmente gnostico del pensiero rivoluzionario moderno, pure ovviamente attraversato da differenze radicali al suo interno, pure animato da ideali opposti – generosi e nobili nel caso dell’anarchismo e del comunismo, infami e ignobili nel caso del nazismo – da questo punto di vista è una versione secolarizzata dell’idea messianica radicale, in quanto strutturato intorno all’idea che l’umanità è divisa in tre gruppi: una minoranza di “pneumatici” – i rivoluzionari, «destinati, a motivo della loro “purezza”, a svolgere un ruolo di paracleti – una massa di psichici – il popolo che, pur contaminato, è passibile di essere redento e, infine, tutti quegli elementi ilici, corrotti e corruttori» che devono essere spazzati via (L. Pellicani, Lenin e Hitler. I due volti del totalitarismo, Rubettino, Soveria Mannelli 2009, p. 10). Nella dottrina comunista e in quella nazista, tradottesi tragicamente in pratica, tale opera di “pulizia” soteriologica viene esplicitamente identificata nello sterminio di massa, nella “pulizia etnica” o nella “pulizia di classe”, come affermano inequivocabilmente non solo i testi e i discorsi di Hitler, Goebbels, Himmler, e degli altri leaders nazisti ma anche quelli di Engels, Lenin, Zinovev e di numerosi altri capi bolscevichi. L’eredità del messianesimo religioso radicale non è tuttavia univoca. A mio avviso, essa può assumere, nella sua traduzione anarchica secolarizzata, anche una valenza positiva, a patto di rimanere entro i confini di un’idea regolativa. Ma questo complesso argomento meriterebbe una trattazione a parte.
Società aperta
Per concludere, Torah e libertà suggerisce, tra le altre cose, che il problema della legge, da un punto di vista anarchico, non riguarda tanto il numero delle norme (le “regole del gioco” necessarie al vivere civile), bensì, piuttosto, la fonte e, direi soprattutto, il loro contenuto e la loro estensione: che un precetto religioso sia seguito da un credente non è un problema in quanto tale, a patto che la norma religiosa sia accettata volontariamente, che sia laicamente distinta da quella civile o politica, e che alla religione, come scriveva Locke, sia data la possibilità di convincere, mai di costringere (Lettera sulla tolleranza, Laterza, Bari-Roma 2005). In fondo, come aveva intuito o compreso Bakunin dopo aver scagliato fulmini e saette contro l’idea di Dio, archetipo di ogni autorità, una società libera non è, né può essere, una società di atei o di anarchici; essa non potrà che essere una società in cui l’eresia è, per così dire, “istituzionalizzata”. Una società libera è una società aperta, una società in cui il credere o il non credere (nella divinità o in qualunque altra cosa) è un problema che attiene la coscienza del singolo: è quella società in cui non esiste una verità ufficiale, in cui ciascuna Chiesa, setta, partito o movimento, ciascuna associazione «non escluse quelle che avranno per scopo la distruzione della libertà individuale e pubblica» ha «libertà illimitata di svolgere ogni tipo di propaganda con le parole, con la stampa, nelle riunioni pubbliche o private; senz’altro freno che il naturale e salutare potere dell’opinione pubblica» (7). Quale che sia la forma che può assumere, una cosa è certa: una società libera non può essere una società che costringe gli individui ad essere liberi, come invece auspicava il padre del pensiero totalitario, Rousseau (8). Libera sarà sempre quella società che sa tutelare, in primo luogo, più o meno bene, la libertà individuale: il diritto di ciascuno di essere «fannullone o laborioso» (9), cioè di vivere, se così gli pare, della carità volontaria; «la libertà di perseguire il nostro bene a modo nostro, fino a quando non tentiamo di privare gli altri del loro o di impedire che i loro sforzi lo raggiungano» (10); «il diritto di opporsi, di essere impopolari, di difendere le nostre convinzioni solo perché sono le nostre convinzioni. È questa la vera libertà, e senza di essa non esiste nessuna specie di libertà, e anzi neppure l’illusione della libertà» (11).
da: "A Rivista Anarchica"
Note
1. Su questo tema Biagini ha pubblicato diversi lavori, tra i quali si segnala il volume Nati altrove: il movimento anarchico ebraico tra Mosca e New York, BFS, Pisa 1998.
2. Cfr. almeno G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, Einaudi, Torino 1993; Id., Shabbetai Sevi: il messia mistico (1626-1676), Einaudi, Torino 2001; M. Löwy, Redenzione e utopia. Figure della cultura ebraica mitteleuropea, Bollati Borlinghieri, Torino 1992; A. Schwarz, Sono ebreo, anche. Riflessioni di un anarchico ateo, Garzanti, Milano 2007.
3. Cfr. A. Bertolo, Potere, autorità, dominio. Una proposta di definizione, «Volontà», a. XXXVII, 1983 n. 2, pp. 51-78. Ciò che piuttosto appare discutibile nel pensiero anarchico è che in esso, in virtù della sua prospettiva rivoluzionaria, non si può rinvenire nessuna chiara indicazione su quali istituzioni dovrebbero essere autorizzate ad emanare le leggi, su chi dovrebbe farle rispettare, su chi dovrebbe punire i trasgressori, e in quali modi. Su questo tema, spunti critici nel numero monografico di «Volontà», a. XLVIII, 1994 n. 1, Il diritto e il rovescio.
4. Cfr. «Il pensiero politico», a. XXXV, 2003 n. 2, Politeia biblica, a cura di L. Campos Boralevi e D. Quaglioni.
5. Un esempio di utilizzo in modo opposto del testo biblico è offerto da 1 Samuele, 8, 5-22, alla cui autorità Thomas Paine fa appello per condannare nella maniera più categorica ogni monarchia, tanto quanto Thomas Hobbes vi aveva fatto ricorso, un secolo prima, per giustificarla nella sua versione assoluta. Cfr. T. Paine, Common Sense, in I diritti dell’uomo, a cura di T. Magri, Roma 1978, pp. 76-78; T. Hobbes, Leviatano, a cura di A. Pacchi, Laterza, Bari-Roma 1989, pp. 171-72.
6. Cfr. per tutti N. Cohn, I fanatici dell’Apocalisse, Edizioni di Comunità, Milano 1976; L. Pellicani, La società dei giusti. Parabola storica dello gnosticismo rivoluzionario, Etaslibri, Milano 1995.
7. M. Bakunin, La libertà degli uguali, a cura di G. Berti, Milano 2009, p. 98.
8. J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, a cura di R. Derathé, Einaudi, Torino 1994, p. 28.
9. M. Bakunin, La libertà degli uguali, cit., p. 98.
10. J.-S. Mill, Sulla libertà, a cura di G. Mollica, Milano 2007, p. 63.
11. I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 2002, p. 166.
martedì 13 aprile 2010
IL CORPORATIVISMO NON E' CAPITALISMO!

di Nereo Villa
Lavorare o rubare è il problema! Lavorare concerne i mezzi economici, rubare concerne i mezzi politici. Il corporativismo (organizzazione statale delle persone giuridiche come strumenti politici) garantisce a chi sa impadronirsi del suo complesso armamentario un’illimitata possibilità di sfruttamento della ricchezza prodotta tramite i mezzi economici. Il corporativismo nasce quindi come chiave di ogni relazione parassitaria in ogni convivenza politica, ed è sostenuto da una legale ma non legittima classe di professionisti del parassitismo. George Orwell nella neolingua del suo romanzo “1984” chiamava tale classe “miniver”, cioè “Ministero della Verità” che era invece ministero della menzogna, come è oggi ogni ministero di qualcosa; ad esempio chiamiamo Ministero dell’Economia qualcosa che di fatto genera debito, altro che economia! In tale contesto si sviluppa una vera e propria civiltà della menzogna poggiante su tre slogans: 1) la guerra è pace; 2) la libertà è schiavitù; 3) l’ignoranza è la forza. Come mai?
A partire dall’1989 - anno del crollo del muro di Berlino - si predica una nuova ideologi a “marxista ma non marxista”, che confonde le idee alla gente prendendo come capro espiatorio il capitalismo inteso come causa di ogni male. Così facendo, si chiama capitalismo il corporativismo, che è la degenerazione statalistica del capitalismo sano. Il trasformismo nominalistico per cui si chiamano le cose con un altro nome (trasformismo) non è forse la primigenia operazione che Marx praticò rispetto alle idee di Hegel, generando la medesima confusione che continua ancora oggi soprattutto nella sinistra e in ogni portatore del pensiero debole, sempre più debole? Tale trasformismo ricorda appunto l’operazione del sopracitato “miniver”! E oggi tale operazione vorrebbe condurre l’individuo all’accettazione del debito pubblico come normale economia del debito. La logica dei fatti reali vorrebbe invece che il debito fosse pagato. Abbasso il capitalismo?
Il capitalismo è un bene, non un male. Oggi pochissimi lo affermano non capendo che il capitalismo nasce (anche etimologicamente) dal capo umano e dal logos del pensare che vi risiede. In ebraico “cranio” si dice “golgota” (Giovanni 19,17), che è anche il nome del luogo in cui il sangue del figlio dell’uomo (il sangue è veicolo dell’io) feconda la terra di nuovi impulsi: con la croce del Golgota nasce infatti il segno “più” (+) dell’addizione ed il segno “per” (x) della moltiplicazione. Ma non solo. Nasce la tecnica, la tecnologia... Eppure l’economia, che avrebbe dovuto generare credito e beni economici, è stata ridotta - dal corporativismo - ad ingigantire un debito pubblico che in realtà è inesistente in quanto creato artificialmente dalle banche, emittenti denaro creato dal nulla, ma prestato poi a costo nominale!
Questo è corporativismo! Legame poltiglioso fra Stato e banche centrali, funzionali al parassitismo del primo. Parassitismo che consiste nella pretesa di avere denaro senza dover lavorare per ottenerlo (ed è appunto questo che i governatori delle banche centrali forniscono ai vari governi). Nutrendosi di menzogne, il pensiero debole crede e fa credere che il capitalismo sia un male in quanto proveniente dal capo dell’uomo anziché dalla “legge” (come se le leggi fossero fatte dagli dei)! E questa è alienazione. Invece, a differenza di ciò che accadde nelle società socialiste pianificate (che condusse al crollo del muro perché il calcolo dei bisogni precedeva e predeterminava l’offerta) nel capitalismo l’offerta è un dono, rispetto al quale il donatore non sa mai con certezza cosa riceve in cambio. L’offerta mercatoria in realtà è carità, congiunta alla fede ed alla speranza che dando, si riceva pure! (cfr. G. Gilder "Ricchezza e povertà" , Milano,1982). L’artista non crea per denaro ma per mettere al mondo qualcosa di sé che ancora non c’è, come un dono al mondo. E così è per qualsiasi altro produttore di qualsiasi bene (dal CD musicale a un pomodoro, o da un quotidiano on line ad un giornale cartaceo). Chi produce non immette nel mercato i suoi prodotti per mero denaro ma per offrire al mondo il suo dono, e quasi per sfidare il proprio futuro con le sue capacità creative, coi suoi talenti. Il senso di ciò è soprattutto quello di estrinsecare al massimo grado l’elemento creativo della natura umana che, essendo a immagine di quella divina, crea. Questo è il vero spirito imprenditoriale. L’imprenditore è un creativo che opera economicamente.
Chi invece opera solo secondo la logica delle ricchezze - cioè secondo mera economia politica - non è un imprenditore, ma un parassita di questo.
Oggi il vero capitalismo è imprigionato in un vuoto conoscitivo, generatore di rinuncia rispetto all’unica risorsa umana possibile: la creatività.
In definitiva oggi il socialismo è fallito ma il capitalismo è visto come un male. Da chi? Dal parassitismo, cieco-volontario rispetto al fatto che il male vero non risiede nel capitalismo ma nel corporativismo dello Stato padrone.
Oggi siamo appunto governati da un Berlusconi che, proclamandosi keynesiano, blatera “meno Stato”: una contraddizione in termini. Infatti il keynesianesimo continua ad ingrandire lo Stato, assieme al debito! Ovviamente i parassiti non sono soltanto i portatori di pensiero debole di sinistra ma anche i portatori di pensiero debole di destra, insomma sono tutti coloro che hanno il grave torto di non capire che le forze creative e innovatrici agenti nel campo umano e nella natura sono le stesse che sempre condussero imprenditori e commercianti ad avventurarsi oltre ogni situazione statica, assicurando all’umanità il capitalismo come strumento più efficace per la sopravvivenza.
Invece di odiare il capitalismo proclamando paradossalmente al mondo tale odio tramite computers e tecnologia (meravigliosi prodotti del capitalismo) sarebbe meglio incominciare a capire che la più bella forza del capitalismo è il suo carattere individualistico etico. Ecco perché per il libertario Ludwig von Mises l’ostilità verso il capitalismo non c’entra nulla con la miseria crescente della gente. L’umanità ha infatti migliorato - grazie al capitalismo - il proprio tenore di vita. L’ostilità verso il capitalismo, afferma Mises, è dovuta al risentimento del falliti (cfr. Mises, “La mentalità anticapitalistica”).
venerdì 9 aprile 2010
Carmelo Miragliotta 1, SIAE (fanculo)

La notte di Capodanno scorso, un tizio - identificatosi come "agente della Siae" - si presentò nell'agriturismo Amarant, a Bergamasco (AL), nel bel mezzo del lavoro chiedendo carte e bolli della serata. Carmelo Miragliotta, titolare dell'azienda, poco avvezzo a farsi intimorire, prese sottobracio il "funzionario" e lo invitò a lasciare quel posto, presentandosi magari con un mandato se del caso.
Pochi giorni fa, a Miragliotta è stata recapitata una raccomandata dalla Siae con la richiesta di 660,51 euro di tassa per quella serata di festa.
Di seguito, vi proponiamo la risposta spedita da Miragliotta alla Siae, giusto per rendervi testimoni del fatto che alle intimidazioni non si deve cedere di un solo millimetro. (LF)
"Egregi signori,
con riferimento alla vostra raccomandata “diffida” pensiamo siate incorsi in errore poiché non abbiamo mai ingaggiato alcuna orchestra come sostenuto negli allegati alla vostra missiva, né tantomeno disponiamo di 100 posti come riportato in uno dei vostri fogli ed i prezzi delle consumazioni nella nostra AZIENDA sono regolarmente depositi presso l’ ATL di Alessandria ed presso il nostro Comune di residenza e sono, purtroppo per noi, ben diversi da quanto da voi sostenuto.
Desideriamo inoltre precisare che il nostro non è un locale pubblico ma un AGRITURISMO (attività accessoria e complementare a quella agricola per giustificare, ANCORA E A FATICA, la permanenza in vita di un’azienda agricola) al quale si accede o previa accettazione di prenotazione o su invito per manifestazioni organizzate. Altri non sono ammessi a meno che non si tratti di autorità munite di valida e giustificata autorizzazione di accesso a proprietà privata.
Tuttavia, per spirito di collaborazione, ( perché noi non ce ne ricordiamo né ce ne siamo accorti presi come eravamo e siamo a guadagnarci a fatica la vita e cercare di mantenere in essere un’attività oberata di balzelli e pastoie burocratiche) possiamo ipotizzare che se mai brani musicali fossero stati eseguiti potrebbe essere stato ad iniziativa individuale ed hobbistica di qualche ospite.
Infine, nel caso, come minacciate, voleste trascinarci in un tribunale per ottenere il pagamento, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso: chiudere e trasformarci in ospiti a pranzo e cena di quei personaggi che, grazie alle sempre più numerose imposte e vessazioni a carico della gente produttiva, vivono a spese di chi svolge, ancora e nonostante tutto, un’attività".
Distinti saluti
Tratto da: Movimento Libertario
mercoledì 7 aprile 2010
Maledetti assassini!
La morte di un fotografo e due bambini commentati come incidente, ecco la missione di pace del ''pacifista'' Obama.
martedì 6 aprile 2010
"L'indipendenza non è un'utopia"

Intervista a Ornella Demuru su Sardi News
“L’indipendenza per noi è un percorso a lungo termine. Questo significa che nei tratti intermedi è necessario conquistare fette di sovranità in determinati campi. Faccio un esempio: possiamo essere indipendenti dal punto di vista dell’energia, con un serio investimento nel fotovoltaico. Oppure in ambito fiscale dove potremmo creare una politica di defiscalizzaione per le PMI”.
Ornella Demuru, nella foto, 38 anni, nuova segretaria di iRS (indipendèntzia Repùbrica de Sardigna). Eletta il 17 gennaio, data simbolica che nella cultura sarda coincide con l’inizio della primavera. Il partito ha voluto utilizzarla come “data simbolo della primavera indipendentista”.
Attivista iRS dal 2008, ha un passato da sindacalista, responsabile Cgil in Tiscali per tre anni, ha collaborato alla campagna elettorale di Renato Soru del 2004 e lo ha seguito in Regione nella comunicazione sul web. E’ laureata in Antichità e Istituzioni medievali a Cagliari.
L’indipendenza è un’utopia?
“No. Se noi avessimo una politica economica e fiscale, all’indomani di queste riforme politiche potremmo realizzare un’indipendenza totale. Solo leggi internazionali che ci garantiscono la possibilità di renderci indipendenti. Stiamo guardando con particolare attenzione l’esempio della Scozia, paese in cui, solo 30 anni fa, il partito indipendentista aveva una forza politica del 2 per centro. Oggi gli indipendentisti sono al governo. Tutto questo è accaduto senza alcun ricorso alla violenza”.
Quali leve intendete agire per i vostri obiettivi?
“La politica di iRS si basa su tre principi. Il primo è quello della non violanza. Le storie dei popoli raccontano una libertà conquistata spesso con guerre sanguinose. Gandhi, invece, parlava di un concetto che in italiano potremmo tradurre come “forza dell’amore e della volontà”. Su questo prima cardine impreniamo il nostro credo politico. Il secondo è quello del non-nazionalismo; concetto di difficile comprensione perchè sono poche le nazioni che si vogliono affermare senza nazionalismi. Non crediamo di essere un popolo unito da un’origine etnica, non abbiamo ripiegamenti sul passato perchè la nazione sarda è in divenire e non vogliamo fare richiami al sangue”.
Un concetto complesso.
“E’ un concetto collettivo e moderno rivolto a chiunque voglia far parte della nostra terra”.
E il terzo principio?
“Il non-sardismo, che per noi è una tradizione politica più o meno esplicita che considera la Sardegna come una nazione “abortiva”. Questa espressione appartiene a Camillo Bellieni, uno dei padri del sardismo. La parola “abortito” significa “morto, non nato”, mentre la parola “abortivo” racchiude in sè un significato ancora più stringente, significa “ciò che genera in continuazione la propria morte”. E’ un concetto auto-razzista che si è sviluppato su una politica basata sul rivendicare risorse e trsferimenti dallo Stato italiano. Un’abitudine all’assistenzialismo che è l’esatto contrario dell’evoluzione di una autonoma capacità di gestione. Non è possibile costruire una repubblica indipendente accettando questa prassi”.
L’esperienza Soru?
Sicuramente una delle legislature più importanti degli ultimi 30 anni. Ha avuto il coraggio di dare una svolta a daterminate empasse come gli enti locali, le comunità montane. L’ho apprezzato dal punto di vista legislativo. Una critica? La mancanza di uno spirito collegiale nelle scelte”.
E l’attuale governo?
“Assente. Abbiamo assistito a tutta una serie di finanziamenti privi di un disegno politico. Dopo le critiche all’autoritarismo di Soru ci si attendeva una linea riconoscibile. Nel governo Cappellacci non ci sembra di ritrovare una linea o un progetto. Da una parte abbiamo un centrodestra che non trova una propria identità, dall’altra un centrosinistra che non ha niente da proporre”.
Quali le cause della frammentazione tra sardisti, autonomisti, indipendentisti?
“Noi siamo sciolti dalle idee del sardismo proprio in base ai nostri tre principi. Ma ogni posizione assunta al’interno di questi schieramenti fa si che si concretizzi sempre più il concetto dell’indipendentismo. Tutti i partiti operano in Sardegna all’interno di una visione italiana, ma sono di destra, di sinistra, di centro. Se volessimo congiungere le aspirazioni di sardisti, autonomisti e indipendentisti è come se chiedessimo a PD e PdL di diventare in Sardegna un unico partito. Con questo intendo dire che ogni movimento politico porta avanti le proprie istanze. Noi, per esempio, alle prossime provinciali correremo da soli”.
Come vede lo spostamento a destra del Partito Sardo d’Azione?
“Sinceramente nel progetto politico del PSd’Az non c’è mai stata una definizione statutaria che li renda appartenenti alla destra o alla sinistra”.
Avete quantificato temporalmente il percorso verso l’indipendenza?
“Rifacendoci all’esempio scozzese, parliamo di 30 anni. Ma la storia ha i suoi percorsi, e non possiamo escludere che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo anche prima”.
Com’è suddivisa la nazione Sarda?
“Ci sono otto regioni che corrispondono all’attuale ordinamento amministrativo. In più una regione che noi abbiamo chiamato “Disterru”, ovvero quella composta dai “disterrati”, quelli che vivono fuori dalla Sardegna, nel mondo”.
Avete paura che, staccandovi dall’Italia, ci possano essere ripercussioni sotto il punto di vista dell’import-export?
“Una nazione autarchica è impossibile, ma dobbiamo considerare il problema da un’altra prospettiva. Il cordone ombelicale che ci lega all’Italia preclude tutta una serie di scambi con gli altri paesi che si affacciano sul mediterraneo, facilitati dalla nostra posizione geografica. L’aumento degli scambi con l’estero porterebbe un naturale aumento della produzione in una terra votata naturalmente all’agricoltura e che, invece, occupa il 70 per cento delle sue maestranze nel terziario. L’Italia ci ha condannati a un tessuto produttivo limitato e troppo limitato all’import”.
(http://www.irsonline.net/2010/03/lindipendenza-non-e-unutopia-ma-percorso-politico-a-lungo-termine/#more-2092)
domenica 4 aprile 2010
giovedì 1 aprile 2010
Alessandria: convegno su Sante Pollastro

Il Laboratorio Anarchico Perla Nera organizza un convegno di studi sulla figura del leggendario bandito di Novi Ligure " SANTE POLLASTRO - BANDITO FRA GLI ANARACHICI"
nei giorni 22 e 23 maggio in Alessandria presso il Museo della Gambarina (situato nell'omonima piazza).
Sabato 22 maggio inizio alle ore 15.00: presentazione del convegno e piccola premessa sul perchè delle giornate di studi su Sante Pollastro a cura di Salvatore Corvaio;
Giorgio Sacchetti storico (Università di Trieste) "Il movimento anarchico italiano all'epoca di Pollastro";
Gian Domenico Zucca - autore del libro "Sante Pollastro il bandito in bicicletta", parlerà della vita e della figura di Sante;
Alberto Ciampi - ricercatore - Pollastro si racconta, tracce per una biografia;
Tobia Imperato - anarchico - " Giuseppe de Luisi, Caterina Piolatto e altri anarchici nella banda o in contatto con essa" ;
Franco Castelli - dell' Istituto Storico della Resistenza di Alessandria - "Banditismo, ribellismo e anarchia nella cultura popolare alessandrina";
Riccardo Navone - editore - " La rivolta di Santo Stefano";
ore 20.00 cena al Laboratorio PerlaNera e intrattenimento.
Domenica 23 maggio ore 10.00:
Giorgio Sacchetti "L'importanza della memoria";
seguirà dibatto.
Per contatti e altre informazioni:
Salvatore Corvaio 3474025324 oppure Antonietta Catale 3467924283
domenica 28 marzo 2010
giovedì 25 marzo 2010
L’autodeterminazione dell’individuo: base di tutte la libertà

Un analisi partendo dal pensiero di Michel Foucault
di Domenico Letizia
La violenza dello stato in ogni suo aspetto ha un punto di partenza: quella della proibizione sociale. Questi sono anni dove il personale svilupparsi dei propri corpi, della propria libertà di scelta sono messi in discussione anzi, a decidere per il bene della singole scelte e del proprio benessere deve essere sempre lo stato.
L’Italia è il paese dove ogni singola scelta che riguarda il proprio intimo, il proprio corpo, l’dea religiosa o filosofica della vita non conta, conta solo la legge non importa che sia imposta da forze clericale, populiste e assolutamente anti-individualiste, insomma lo stato nel colpire e imporre la propria ‘coercizione sociale’ parte dall’individuo, dal corpo e dalla salute dell’individuo. Il cambiamento lo si nota anche nelle terminologie, quello che una volta era il ministero della sanità ora è il ministero della salute, come se la salute fosse un qualcosa di statale e non di intimamente privato.
Foucault ritiene che le istituzioni sotto il nome di ‘assistenza pubblica’ costituiscono forme di controllo, orientate alla normalizzazione dei diversi ( possiamo dire dei non conformi al catalogo dei buoni cittadini redatto dallo stato o per coloro che hanno atteggiamenti alternativi soprattutto in ambito sessuale)
Anzi per Foucault il controllo della sessualità, e al tempo stesso produzione della sessualità, mostra che il corpo è un punto di attacco privilegiato del potere: ‘Il sesso diventa il punto centrale per un potere che si organizza intorno alla gestione della vita piuttosto che intorno alla minaccia della morte’.
Ecco perché ritengo che per una ripresa culturale e politica del pensiero libertario, contro l’attacco della cultura imposta dallo stato, sia indispensabile per ogni libertario diffondere e occuparsi di tematiche considerate individuali, diffondere libertà di scelta e autodeterminazione dei propri corpi.
Pubblicato sulla Rivista libertaria Cenerentola, Marzo 2010
mercoledì 24 marzo 2010
CRISI ECONOMICA ED SETTORE URBANISTICO

di Domenico Letizia
Pecca tutta Italiana è quella che nelle discussioni politiche siano esse economiche o riguardanti questioni civili e democratiche vi è sempre molta ideologia, di quelle più dogmatiche e becere. Lo si è notato nel dibattito attuale e post-crisi tra mercato e stato. Con un trionfo dello Statalismo direi, statalismo assistenziale, clientelare e coorporativista, insomma quella che da decenni è il metodo di gestire la politica in Campania.
Nel Casertano come nel Napoletano la crisi economica ha cambiato le misere prospettive presenti, giustificando, stesso con l’appoggio dei cittadini, l’estendersi minaccioso del potere politico. L’unica alternativa è il far ritornare almeno tra i dibattiti una sana infarinatura di fantasia liberista e libertaria e in Campania si potrebbe partire dalla gestione dell’urbanistica combattendo la stupida pianificazione che da anni ha appesantito il territorio, diamo spazio, insomma, all’individuo e al pensiero dell’individuo.
Non si tratta di Utopie o di sogni o di chi sa quale progettazione politica per arrivare a questo sistema gestionale per l’urbanista e non solo direi, esperienze vi sono storicamente confermate, come nella Gran Bretagna di inizio Ottocento in cui l'iniziativa privata nella gestione della città ha dato buona prova anche in questo campo che tradizionalmente viene considerato come riservato allo stato.
Si tratta insomma di dare spazio ad una fantasia produttiva e liberale, riscoprendo metodi di gestione urbanistica che sognavamo ma che la storia ci ha consegnato come esempi cui ispirarsi. La vera vittoria consisterebbe, anche, nell’abbattere finalmente le clientele che dietro questo statalismo coorporativista vivono e fanno vincere le elezioni sempre ai soliti noti siano essi di destra o di sinistra.
( http://www.movimentolibertario.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4493:crisi-economica-ed-settore-urbanistico&catid=1:latest-news )
lunedì 22 marzo 2010
Roberto Bertoldo e l’anarchia

Carlo Luigi Lagomarsino
Roberto Bertoldo e l’anarchia
Cosa abbia spinto Roberto Bertoldo a dedicare un libro all’anarchia (Anarchismo senza anarchia. Idee per una democrazia anarchica, Mimesis, 2009) per tentare di fornirne, evitando le pieghe sentimentali, una definizione accettabile è da ricercare a mio parere nell’ambizione di dare uno sviluppo coerente alle idee che aveva espresso in altri lavori e soprattutto nei saggi di Nullismo e letteratura (1998). In quei saggi tuttavia si leggeva, seppur in forma eccentrica quanto pervasiva, un riferimento privilegiato ad Albert Camus il quale stranamente in Anarchismo senza anarchia (Mimesis, 2009) è nominato appena e per giunta in nota. Che poi quel riferimento lo si possa ritrovare vivificante anche nei sotterranei di questo nuovo libro è un altro discorso.
Ciò che più sembra aver interessato Bertoldo è palesemente il prendere in esame la vasta letteratura anarchica, individuarvi ciò che gli sembrano dei limiti sia concettuali sia operativi, azzardarne una classificazione e porre tutto in relazione alla visione niente affatto ortodossa che si è venuto formando attraverso vecchie consuetudini e nuove riflessioni. Probabilmente i maggiori punti di contatto si dovrebbero cercare fra quegli autori anglosassoni che, come Colin Ward, seppure pubblicati e ripubblicati, non trovano veri e profondi riscontri teoretici nella galassia (o nelle galassie, se si preferisce) dell'anarchismo continentale. Allo stesso tempo Bertoldo rifiuta come “finti anarchici” quei “libertarian” “free market” americani legati alla “scuola economica di Vienna” - in particolare, ovviamente, Rothbard - sui quali l'analisi, nelle pagine conclusive del libro, si fa sofisticata e allo stesso tempo appena suggerita, per quanto con degli argomenti la cui”apertura” possa somigliare a una “chiusura” (come se dire e suggerire si equivalessero) che l'impoverisce nell'opposizione – che nel contempo può richiamare proprio Camus – fra l'utilitarismo (la “malvagità dell'anarcocapitalismo”) e l'umanitarismo.
Non si può tuttavia rinunciare a pensare che la stessa accusa di un camuffamento attraverso l'evocazione dell'anarchia possa essere indirizzata a Bertoldo per quella che è la sostanza del suo libro. Poco incline all'anarchismo della tradizione bakunista, perplesso di fronte a quello “ecologista” di Bookchin, avverso alla “finzione” anarcocapitalista, Bertoldo sceglie infatti la via di un anarchismo nella democrazia, ma non attraverso la prevedibile idea di un democratismo radicale tutto da inventare, bensì attraverso la sua definizione formale, vale a dire attraverso la democrazia conosciuta. Cosa che fa pensare - seppure ridotto a pura gestione della ricchezza sociale di un'umanità che dovrebbe essere comunque sempre libera di scegliere - allo Stato democratico. Si può immaginare come le frange sentimentali dell'anarchismo, che pure non hanno disdegnato di arruolare un eccentrico come Francesco Saverio Merlino nel proprio pantheon, insorgano contro tale visione. Ciò nondimeno il retro testo di questa visione è possibile interpretarlo come una forma di ortodossia, persino di “collettivismo anarchico”. In questo caso il merito di Bertoldo è sia di aver letto l'anarchismo attraverso le sue ambiguità e aporie, sia di averlo pensato in concreto attraverso esiti formali.
Se nel liberalismo lo Stato non deve mettere naso nell'economia e limitarsi alla difesa di regole e persone, nella visione di Bertoldo dovrebbe prosciugarsi della “politica” per rimanere un semplice magazzino di risorse così da poter aver cura dei bisognosi (e qui si può avvertire l'eco de La conquista del pane di Kropotkin). Il discorso dell'”uguaglianza” democratica si sposta dunque sulle differenze personali per tornare a un'uguaglianza non semplicemente formale. A questo punto la dialettica fra il detto e il suggerito si ripresenta – ma questa volta in modo più equilibrato ed esplicito - nell'analisi che Bertoldo fa dei concetti di individuo, libertà e proprietà – quest'ultima distinta dal possesso. Nelle pagine relative, poste alla fine del primo terzo del libro, Bertoldo – casomai i concetti fossero vaghi, per non dire ambigui, come in effetti sono – mette in atto una assai stretta concatenazione di idee al fine di essere il più preciso possibile, malgrado la consapevolezza della difficoltà. In un certo senso tutto ciò che ho fin qui definito la visione di Bertoldo - suffragata per giunta da un tono assertivo che nelle finali “considerazioni a latere” assume addirittura l'aspetto delle Tesi - è sottoposto di continuo all'azione di forze centrifughe, come la pensosità all'umorismo. Lo è tanto che solo adesso mi accorgo di quanto fosse già indicativo – di serietà e umorismo, di riflessivo e da riflettere - il titolo del libro.
sabato 20 marzo 2010
Quelli della Cecilia
di Raùl Zecca Castel
Per quattro anni, il tempo che durò in Brasile la Colonia Cecilia, dal 1890 al 1894, più di 250 persone arrivarono a mettere in pratica una convivenza improntata sul volontarismo, sul mutualismo, sulla solidarietà, sull’assemblearismo, su tutti quei presupposti teorici che sono la base dell’anarchismo.
Quando si tratta di socialismo libertario si ha direttamente a che fare con la questione dell’organizzazione dal basso della società. E parlare di organizzazione dal basso significa inevitabilmente porre al centro del discorso l’invito a pensare un drastico sovvertimento delle dinamiche socio-politiche così come siamo soliti intenderle. Ecco che lungo questa nuova linea direttiva, lungo questo invito al pensiero, che solo a prima vista risulta esclusivamente teorico, speculativo, è in realtà anche possibile individuare vicende storiche in cui tale componente anti-gerarchica è effettivamente esistita ed ha costituito il terreno fertile su cui gettare i semi di un nuovo ordinamento sociale, un nuovo avvenire.
L’esempio forse più significativo è da accreditare all’esperienza comunitaria messa in pratica nell’ultimo decennio del XIX secolo in Brasile dall’anarchico pisano Giovanni Rossi, ovvero l’esperienza della colonia Cecilia.
L’importanza storica della Cecilia è ancora oggi facilmente riscontrabile non solo sui luoghi dove essa sorse più di un secolo fa, ma in tutto lo stato del Paranà, regione meridionale del Brasile, e addirittura anche a San Paolo, dove è accertato che tra i promotori e sostenitori del primo grande sciopero che nel 1917 paralizzò la capitale economica del paese vi erano diversi membri dell’ormai disciolta comune italiana. D’altra parte vi è ormai l’assenso degli storici brasiliani nel riconoscere nella Cecilia le radici di quella nuova coscienza che avrebbe portato nel giro di pochi anni alle grandi lotte e rivendicazioni sociali. Senza dimenticare infine che furono proprio gli ex-coloni a fondare i primi giornali di matrice anarco-comunista che si potevano leggere nella zona agli inizi del secolo scorso, contribuendo notevolmente alla diffusione delle idee socialiste.
Detto questo non c’è da meravigliarsi se il nome di Giovanni Rossi e della colonia Cecilia resta ai margini, se non addirittura escluso, dalla storiografia italiana. Ritengo che l’efficace opera di rimozione che ha investito tale vicenda è da ascrivere all’incomprensione che sin dall’inizio ne ha accompagnato il suo evolversi. La proposta di Rossi di costituire una comune socialista era stata osteggiata non tanto dalla destra nazionale, che restava estranea ed indifferente ad un dibattito di questo tipo, ritenendo il proposito di Rossi per nulla pericoloso, quanto piuttosto dagli stessi esponenti del socialismo e dell’anarchismo italiano.
“Rossi un disertore” firmato: E. Malatesta
Andrea Costa, fondatore del Partito Socialista Rivoluzionario Italiano e primo deputato socialista del parlamento italiano, aveva inizialmente fatto intendere di appoggiare il progetto di Rossi – con il quale fra l’altro intratteneva un fitta relazione epistolare –, ma quando era arrivato il momento di passare ai fatti si era improvvisamente tirato indietro sostenendone il carattere utopistico e giudicando dunque inopportuno procedere lungo tale via ritenuta un binario morto.
Errico Malatesta da parte sua non aveva usato mezzi termini: a suo giudizio Rossi era un disertore e la realizzazione di una comune avrebbe significato un’inutile sottrazione di forze a quella che riteneva la vera ed imminente rivoluzione sociale. Non c’era dunque spazio per quelli che aveva definito inutili esperimenti da dilettante di socialismo monastico, elitario, e aveva sentenziato: “Se Rossi vuole fare i suoi esperimenti li faccia pure, ma lasci stare i socialisti, i rivoluzionari, e raccolga dei poveri lavoratori, i più degradati, abbruttiti, e faccia il nobile tentativo di elevarli a dignità umana. I rivoluzionari restino al loro posto di battaglia”.
L’incomprensione in cui si era imbattuto Rossi e che lo aveva lasciato solo nel suo proposito stava proprio nel fatto che nessuno aveva saputo cogliere le sue vere intenzioni. Rossi non era un politico, né tanto meno un ideologo, o almeno mai si sarebbe presentato come tale. La rivoluzione, nei termini in cui ne parlava Malatesta, gli interessava ben poco in realtà. Egli si sentiva ed era a pieno titolo uno scienziato. Non a caso i suoi studi si erano da sempre rivolti al mondo naturale. Professionalmente era agronomo e veterinario, e fino alla sua partenza per il Brasile aveva sempre esercitato come tale.
L’interesse per la politica discendeva direttamente da quello per le scienze naturali. Essa rientrava nei suoi interessi poiché positivisticamente intesa come scienza, ovvero come quella scienza che si occupa della migliore organizzazione sociale possibile. È solo partendo da questo presupposto che si può comprendere come Rossi fosse convinto della necessità di applicare al socialismo i metodi e i criteri d’indagine scientifici utili a stabilirne l’efficacia. Secondo Rossi, la politica, e dunque il socialismo, in quanto scienza, doveva essere in grado di risolversi, con successo o meno, attraverso prove empiriche sperimentali, alla pari di qualsiasi altra disciplina scientifica.
Le ragioni dello sperimentalismo
Conviene forse che sia lo stesso Rossi a spiegarsi meglio con le sue parole, a chiarire cioè quale fosse il suo vero intento:
Come in un laboratorio fisiologico si pongono pochi soggetti in condizioni varie, onde studiarne sperimentalmente le funzioni per poi estendere a tutti i risultati conseguiti su i pochi, determinando in tal modo le leggi naturali che reggono la vita, così vorrei che in uno Stabilimento sperimentale ci riunissimo alcune centinaia di cultori devoti degli studi sociali [...] nell’intendimento più serio di studiare quale grado di sviluppo abbia raggiunto questa tendenza naturale che è la sociabilità [...] dimostrando così quali forme di vita sociale, per essere più consentanee all’indole umana, vere realtà naturali, si impongono come prototipo alla civiltà moderna.
Già da queste poche parole, da queste brevi frasi, si capisce dunque come l’impianto teorico di Rossi non fosse tanto politico quanto, a mio parere, di tipo socio-antropologico. La domanda fondamentale che assilla il suo fare è quella circa la natura dell’umano. Che cos’è l’uomo?, si domanda. Il suo vero proposito difatti stava proprio nello studio delle potenzialità umane, nell’indagarne le capacità relazionali.
Di qui lo sperimentalismo, ma soprattutto l’anarchismo. Un anarchismo sui generis che in Rossi si dimostra più metodologico che ideologico. L’anarchismo di Rossi non è mai stato così lontano dall’essere un fine. Esso, al contrario, è un mezzo, uno strumento, la condizione di possibilità necessaria per mettere alla prova l’uomo, proprio come in un laboratorio nel quale l’essere umano si presenti allo stato puro, cioè naturale – secondo la terminologia propria di Rossi –, privo di quelle strutture e sovrastrutture che nel corso dei secoli si sarebbero cristallizzate in istituzioni e convenzioni ormai date per scontate come la famiglia, la società, la proprietà privata, il denaro e così via.
Resta inteso che tale prospettiva rientra già di per sé in un orizzonte anarchico. E Rossi d’altra parte si dichiarò sempre tale.
Alla luce di tutto ciò ecco allora che la colonia Cecilia si presenta come l’occasione perfetta per un’indagine di questo tipo, per un organizzazione della vita sociale che faccia a meno dei rapporti di potere fino ad allora conosciuti, a favore cioè di una reale organizzazione dal basso, anarchica nel vero senso etimologico del termine.
Per quattro anni, il tempo che durò la colonia, dal 1890 al 1894, più di 250 persone arrivarono a mettere in pratica una convivenza improntata sul volontarismo, sul mutualismo, sulla solidarietà, sull’assemblearismo, su tutti quei presupposti teorici che sono la base dell’anarchismo, senza mai fare ricorso a norme organizzative di alcun tipo, compromessi elettorali o procedure di delega.
Come lo stesso Rossi conferma,
il gruppo volle essere assolutamente inorganizzato. Nessun patto, né verbale né scritto, fu stabilito. Nessun regolamento, nessun orario, nessuna carica sociale, nessuna delegazione di poteri, nessuna norma fissa di vita o di lavoro. La voce di uno qualunque dava la sveglia agli altri; le necessità tecniche del lavoro, palesi a tutti, ci chiamavano all’opra, ora divisi, ora uniti; l’appetito ci chiamava ai pasti, il sonno al riposo.
Detto questo si potrebbe essere indotti a pensare tale micro-società come l’isola felice del socialismo libertario, una sorta di paradiso terrestre dove la vita scorre felice e senza problemi, in perfetta simbiosi con la natura e con gli altri membri della Cecilia. In realtà è evidente che le cose non stavano proprio in questo modo. Diverse difficoltà gravavano sulla vita dei coloni, sui loro rapporti interni e soprattutto sui loro rapporti con l’esterno. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, Rossi stesso indica quelle che a suo parere sono state le maggiori difficoltà per la buona riuscita dell’esperimento.
In sintesi si può parlare di un forte conflitto con la vicina e preesistente comunità polacca, fortemente cattolica e dunque poco accogliente nei confronti dei costumi dei nuovi arrivati. Si deve tener conto degli inevitabili attriti con il clero locale, anch’esso evidentemente ostile alla condotta dei coloni - e questo per ovvi motivi, primo fra tutti il dichiarato ateismo degli anarchici, che tra l’altro era la causa per la quale veniva negata loro la sepoltura nei cimiteri. Si deve quindi fare riferimento all’ostracismo che le autorità politiche locali attuarono nei confronti delle attività agricole dei coloni, vessate da sempre maggiori imposte ed infine alle obiettive difficoltà economiche e logistiche cui dovevano far fronte i coloni per reperire il materiale necessario ai lavori agricoli.
Come se tutto ciò non fosse abbastanza, nell’arco dei 4 anni, si verificò anche una grave epidemia di difterite che colpì a morte diversi membri della comune.
Il tutto evidentemente in un contesto di estrema povertà ed indigenza che non dava adito ad illusorie speranze.
Per quanto riguarda invece i problemi interni alla colonia, legati proprio al nuovo stile di vita condotto, questi erano tutti da ricondurre ad un unico motivo: la teoria dell’amore libero, fortemente esaltata e propagandata da Rossi ma ben poco condivisa dal resto dei membri della Cecilia, che in alcuni casi si erano dovuti rassegnare a spartire con altri l’amore per la propria donna, pur di non rinnegare quello che per Rossi costituiva probabilmente uno dei capisaldi teorici più importanti dell’anarchismo, fulcro di tutta la sua concezione libertaria.
In questo caso, l’obiettivo polemico di Rossi era l’istituzione familiare. L’amore libero ne era semplicemente la conseguenza. Il suo interesse stava nella demolizione della famiglia intesa proprio come istituzione politica, luogo genetico del sistema sociale, embrione di tutti quei mali che la società futura non avrebbe potuto fare a meno di manifestare amplificandone i difetti.
Lungo questa prospettiva Rossi giunge ad analizzare il fenomeno familiare da un punto di vista economico, riconducendo le responsabilità dello sviluppo e del sostegno del regime capitalistico proprio all’interno delle relazioni di famiglia. Ecco perché la questione dell’amore libero è fondamentale per Rossi. Vi è, a suo dire, un bivio insormontabile cui deve far fronte ogni organizzazione sociale: da una parte la famiglia, e dunque un egoistico sistema di convivenza basato su rapporti capitalistici; e dall’altra il libero amore, dunque il socialismo, la solidarietà, la libertà. Non da ultimo, tale forte critica all’istituto familiare, che dunque implicava l’amore libero come conseguenza logica e necessaria, esprimeva l’istanza di una rivendicazione di genere, ovvero quella dell’emancipazione femminile.
In realtà, però, c’è da dire che nessuno di questi motivi fin ora elencati risulta tanto decisivo per lo scioglimento della comune quanto la volontà stessa di Giovanni Rossi. Difatti, nonostante il definitivo scioglimento avvenga solo nel 1894, già un anno prima Rossi aveva dichiarato che ai fini scientifici l’esperimento poteva dirsi concluso. Si può dire che per Rossi era passato abbastanza tempo da consentirgli quello studio sperimentale sulla natura umana, sulle sue inclinazioni e potenzialità che costituiva il vero proposito dell’esperimento.
Il merito della Colonia
L’obiettivo dell’esperimento difatti non era stato che questo. Fortemente polemico nei confronti di coloro che sapeva avrebbero colto nel termine dell’esperimento un motivo per ricavarne la natura fallimentare del proposito e screditarne la sua operazione, a scanso di equivoci, scrive Rossi:
Alcuni hanno creduto che noi siamo venuti qua a fabbricare il campione, lo specimen della società futura, per presentarlo poi, brevettato o no, all’umanità, onde all’indomani della rivoluzione sociale non avesse altro fastidio che ordinarne la fabbricazione all’ingrosso. [...] Ma noi non siamo venuti a fabbricare il puerile specimen. [...] non siamo venuti a sperimentare l’anarchia, né a tentare la miniatura della nuova società. [...] Nessuno di questi propositi fu ed è il nostro. [...] il nostro proposito non è stato l’esperimentazione utopistica di un ideale, ma lo studio sperimentale – e per quanto ci fosse possibile rigorosamente scientifico – delle attitudini umane in relazione a quei problemi.
E i problemi cui si riferisce Rossi sono evidentemente quelli relativi all’ambito politico, qui inteso come luogo nel quale si esplicano i rapporti sociali di convivenza. Sono i problemi che fanno riferimento all’ordinamento gerarchico dello stato e a tutto ciò che ne consegue in termini di libertà e possibilità di partecipazione diretta dell’individuo alla vita politica e civile.
Problemi che evidentemente non si sono certo esauriti nel corso di quest’ultimo secolo e che anzi, in modalità sempre più diverse e talvolta aggressive, si ripropongono quotidianamente all’attenzione di ognuno di noi, invitandoci a ripensare i rapporti di potere che regolano le nostre vite.
E il merito della colonia Cecilia, a prescindere dalla sua dimensione ingenuamente scientifica e sperimentale, che resta però perfettamente comprensibile all’interno della cultura positivista del tempo, sta proprio in questo; da una parte nell’aver proposto un esempio concreto di alternativa possibile, lungo quel tentativo, sempre nobile, che è l’impegno per la costruzione di una società migliore; e dall’altra nell’aver effettivamente rappresentato un terreno fertile per quei semi che paradossalmente si sarebbero schiusi solo con la morte della Cecilia, per germogliare anni più tardi con le prime conquiste sociali in cui ebbero un ruolo attivo gli ex-membri della comune italiana.
A questo proposito, per concludere, vorrei leggervi un’ultima citazione di Miguel Sanchez Neto, docente di letteratura all’Università Statale di Ponta Grossa, nello Stato del Paranà.
La colonia Cecilia riuscì a fruttare nella misura in cui fu abbandonata, funzionando come un fuoco propagatore di conoscenze sociali ed agricole, e compiendo, a partire da lì, un ruolo significativo nella consolidazione del Paraná. Come essa non fu concepita dal suo mentore per essere perenne, dovendo esistere appena durante il periodo necessario per l’osservazione delle attitudini umane nella vita anarchica, possiamo concludere che il suo successo fu pienamente possibile solo con la sua dissoluzione.