
Qui vengono delineate le strutture portanti del pensiero anarchico "classico". Esse mettono in luce il suo carattere pluralistico inteso come un insieme di sequenze teoriche ognuna delle quali concorre a completare il nucleo profondo dell'argomentare anarchico. Si vuole, quindi, cogliere le ragioni messe in campo dall'anarchismo per giustificarsi come pensiero e come azione.
Giustizia e verità
William Godwin (1756-1836) porta all'estremo limite concettuale i presupposti razionalistici dell'illuminismo, che affermano la supremazia della ragione, per cui il vero ordine della società è quello naturale. La premessa fondamentale scaturisce dalla concezione newtoniana del cosmo: la sua unità fisica è al tempo stesso un'unità intellettuale e la sua verità implica il concetto oggettivo di necessità. Il compito dell'uomo è quello di scoprire il senso morale di queste leggi, per coniugare la ragione con l'etica, deducendo da questa sintesi tutte le implicazioni politiche, sociali, economiche ed educative che ne conseguono e che, in quanto vere, se portate alla loro radicale effettualità, comportano la felicità del genere umano. Ai fini di questa impresa è perciò decisivo il ruolo assegnato alla conoscenza, veicolo peculiare di appropriazione del disegno immanente sotteso a questo ordine, la cui evidenza non ammette interpretazioni distorte. La valenza politica e sociale della spontaneità e dell'equilibrio di tale ordine si traduce nell'idea di un autogoverno nelle cose e negli uomini. Dall'insieme di tutte queste considerazioni, si ha così una sorta di tautologia epistemologica: quello che la società deve essere è in fondo quello che essa è nella sua autenticità: raggiungere lo stato ottimale è raggiungere lo stato originario. La concezione anarchica di Godwin si fonda dunque su un cognitivismo allo stesso tempo intellettuale e morale: lo sviluppo della conoscenza conduce al progresso della giustizia. Dalle premesse di questo archetipo universale naturale, Godwin parte per rifiutare le tre forme classiche di giustificazione dell'autorità politica: quella per diritto divino, quella fondata sul riconoscimento dei rapporti di forza, quella che scaturisce dalla tradizione contrattualistica. Sono tutte, a suo giudizio, manipolazioni artificiali prodotte dalla creazione storica: nessuna può cogliere l'immanenza dell'ordine sociale. Una società senza coercizione, dunque, in cui la socialità sarà fondata sulla verità e sulla giustizia e la sicurezza dei cittadini si baserà sulla generale partecipazione di tutti i suoi membri alla vita pubblica: la quale, pertanto, non avrà bisogno di corpi separati che facciano rispettare la legge, sovrapponendosi all'ordine immanente prodotto dalla spontaneità dei rapporti sociali. La società anarchica delineata da Godwin si fonda sull'assenza di ogni forma coercitiva perché fondamentalmente motivata dall'etica. Poiché il "completo annullamento" del governo non può avvenire che con la maturazione di un'alta coscienza civile, si deve cercare la via di una costruzione societaria, dove sia determinante la partecipazione popolare. Gli argomenti portati da Godwin sono quindi, in parte, quelli adottati da Jean-Jacques Rousseau: di per sé, la sovranità non ammette deleghe o divisioni. Tuttavia, la soluzione del pensatore inglese è diversa da quella del filosofo ginevrino perché mentre questi risolve il problema del potere con una mediazione politico-istituzionale (rapporto maggioranza-minoranza), l'anarchico mantiene irrisolvibile il principio dell'indivisibilità, nel senso della sua non trasferibilità decisionale. Ne consegue la teorizzazione della democrazia diretta, del federalismo e del decentramento, che non sono delineati nella loro fattualità concreta, ma implicitamente posti come soluzione ineludibile, qualora si voglia far coincidere la libera volontà di tutti con la libera volontà di ciascuno. Il criterio fondamentale che spinge Godwin a rifiutare ogni forma di etero-direzione politica scaturisce da una premessa ontologica e morale, dalla constatazione, a suo giudizio incontrovertibile, secondo cui tutti gli uomini partecipano di una facoltà comune, la ragione, che, in quanto tale, non può che essere unica; pertanto essa unifica tutti gli individui dal momento che la sua universalità contiene la fattiva possibilità di superare i conflitti inter-umani sciogliendoli nell'esperienza del confronto razionale e del dialogo. La razionalità è spinta alla sua massima enfatizzazione, nel senso che la politica ha per oggetto la razionalità dell'agire umano perché unico termine di riferimento universale e unico criterio di edificazione positiva del mutamento sociale. La felicità, la virtù e il benessere non sono mète o entità incontrollabili, rispetto alla coscienza razionale del soggetto. E ciò perché non si tratta di pensare una nuova società, ma di trovare la sua verità ultima. A sua volta questa verità non scaturisce da un'indagine delle forme politiche pregresse, né dall'analisi astratta di forme politiche ipotetiche, ma dall'empirica constatazione dell'effettività pratica connessa all'universale desiderio di benessere. Siamo a una delle fonti originarie del pensiero anarchico, cioè all'insanabile divisione tra società e governo, tra politica e morale. I primi termini rientrano nell'ambito della natura, i secondi in quello della storia. Lo sfondo culturale che fa da principio informatore a tale concezione è il giusnaturalismo, qui ricondotto al suo radicale presupposto, secondo cui la legge morale deve coincidere con quella naturale, nel senso che l'etica e la politica, se rettamente intese, devono esprimere verità naturali universali, trascendenti il diritto positivo configurato dai processi storico-culturali. È questo un paradigma che in parte ricalca lo schema dicotomico di Rousseau fra natura e società e che vive pertanto del mito dell'autentico: originariamente la società rifletteva l'umanità al suo stato incontaminato. La storia, degenerando, ha creato forme artificiali di convivenza, la cui espressione suprema è data dall'istituzione governativa. Per inverare l'autentica condizione umana è necessario pervenire a uno stato di giustizia, solo modo per dare agli uomini la felicità e la virtù. Ma cos'è la giustizia? È l'architrave della società umana. Non ha tempo perché la sua natura è inalterabile. Non esiste una giustizia sociale o una giustizia individuale, ma la giustizia, come, per perfetta analogia, non c'è una ragione personale o una ragione comunitaria: c'è la ragione. In questo modo Godwin introduce il rapporto anarchico tra libertà e uguaglianza, partendo dalla premessa che la prosperità di tutti è l'interesse di tutti. Il rapporto anarchico dell'inscindibile nesso tra felicità pubblica e privata deriva dalla relazione tra giustizia e uguaglianza: gli uomini vanno considerati uguali in quanto sono tutti eticamente equivalenti di fronte alla giustizia, che non è individuale o collettiva, ma la giustizia, come, per l'appunto, non c'è una ragione singola o multipla, ma la ragione. Per questi stessi motivi, per avere cioè delineato l'idea di giustizia come ordine immanente e razionale dell'espressione del bene pubblico quale somma addizionale di quello privato, Godwin nega la teoria liberale e democratica dei diritti perché a suo giudizio errata sotto il profilo epistemologico e ingiusta sotto quello assiologico. La considerazione epistemologica che spinge Godwin a questa radicale affermazione discende dalla constatazione dell'inscindibilità dei nessi che legano ogni individuo al tutto: il singolo non è mai sciolto dalla totalità che lo circonda ed è una sua illusione credere di poter prescindere dalle insopprimibili esigenze di questo ordine vincolante. Ciò, naturalmente, non significa affatto che questa totalità possa essere interpretata come valenza delle ragioni della collettività perché anche quest'ultima, per gli stessi motivi, deve sottomettersi ai dettami dell'immutabile ragione, vale a dire in questo caso della giustizia. È evidente a questo punto che l'uguaglianza di fronte alla giustizia diviene uguaglianza di fronte alla verità, che la ragione riconosce come indiscutibile. Ogni individuo ha il diritto di accedere alla verità e di esprimere il suo insindacabile giudizio personale che diventa la sola guida morale e politica della propria condotta pubblica. Nessuno, dunque, può imporre il proprio punto di vista perché non esiste alcun individuo che abbia il diritto arbitrario di coartare la ragione, il cui esercizio è uguale per tutti. Il concetto anarchico è qui rappresentato dalla libertà insindacabile del soggetto che si attiene al vero, qualunque siano le condizioni sociali e politiche esistenti. E poiché etica, ragione e giustizia sono facce diverse di uno stesso prisma, ne deriva che è proprio questo universale intreccio assiologico a rendere sacro e invalicabile il territorio dei diritti individuali i quali, data questa necessaria interdipendenza, si riducono appunto a uno solo. La verità non scaturisce dai rapporti di forza e non è quindi necessariamente storica. Tra un'intera collettività che erra, perché non si attiene all'"immutabile voce della ragione e della giustizia", e un solo individuo che invece la persegue, è nel giusto quest'ultimo, e ha il diritto di rivendicarlo contro tutto e tutti. Dunque, la ragione è la garanzia della libertà individuale in quanto si erge contro ogni pretesa storica particolare, sia essa religiosa, politica, culturale o di qualsiasi altra natura. L'associazionismo politico nato dalla secolarizzazione moderna non è quindi una forma istituzionale favorevole alla libertà individuale e all'indipendenza del giudizio personale. Anzi, è l'ultimo sostitutivo della subalternità del singolo a entità che lo sovrastano. Nessuna giustificazione deve far recedere l'individuo dalla propria spontanea ricerca del vero e del giusto. L'uomo diviene progressivamente libero in quanto è suscettibile di un'acquisizione culturale infinita dovuta a questo incessante rapporto tra civiltà e libertà, tra verità e ragione. La crescita delle prime comporta la crescita delle altre e tutte conducono ad un progresso continuo della specie.
Educare per cambiare
Date queste premesse, è logico che la soluzione sociale proposta da Godwin sia improntata all'educazionismo più radicale e conseguente. Il suo educazionismo estremo intende dimostrare che il cambiamento materiale è sempre l'effetto di quello culturale. Soltanto la riforma continua dei costumi, la discussione pacata e razionale, la persuasione derivante dall'evidenza incontrovertibile delle cose può sopperire al compito immane di cambiare la società, dal momento che non sono i rapporti di forza a determinare veramente la forma politica e sociale della comunità, ma i giudizi che gli uomini si sono fatti di essa. A tal fine l'educazione è pressoché onnipotente e in tutti i casi non c'è altra strada per cambiare la mentalità e le abitudini umane. Così per estirpare l'idea del governo occorre procedere all'abolizione del suo vero sostegno, la credenza della sua necessità, perché ogni governo è fondato sull'opinione. La pratica di una libera opinione testimonia perciò il grado di libertà vigente in una data società. Secondo Godwin, esiste un legame logico e necessario tra la libertà delle azioni umane e la libertà delle opinioni. Pur opposte, autorità e libertà originano ugualmente dalla stessa fonte: dall'effettivo, esplicito e spontaneo consenso a un sistema di convinzioni. Godwin individua così con largo anticipo un'idea importante della politologia moderna: lo stretto nesso tra legittimità e trasformazione. È il criterio della legittimità, come vera matrice coesiva dell'opinione pubblica, ciò che determina il fondamento ultimo dell'istituzionalità inerente alla socievolezza umana. Il mutamento della società è possibile nella misura in cui esprime le esigenze spontanee del cambiamento sociale, per cui queste non risultano una forzatura rispetto all'esistente. Ciò può avvenire soltanto attraverso un'azione graduale, che garantisca il consenso collettivo e non provochi violenze e rotture indesiderate. Occorre appropriarsi dell'inalterabile ordine della giustizia e della verità, capire l'intrinseca razionalità che le sottende; e questo può scaturire solo dal carattere intellettuale e razionale dell'agire. La forzatura rivoluzionaria ha un'implicita valenza di autorità perché non rispetta la prima regola fondamentale dei rapporti interumani: quella fondata sulla ragione. Pare evidente, secondo Godwin, che una vera concezione realistica deve andare al di là della classica interpretazione machiavellica: in ultima istanza le relazioni sociali non si reggono sui puri rapporti di forza, ma sul consenso spontaneo e generalizzato. Una vittoria ottenuta con la pura forza non conduce a nulla e si regge fintantoché essa mantiene tale amorfo vantaggio di violenza. L'illuminismo radicale che porta Godwin a esaltare la ragione, con Max Stirner (1806-1856) giunge all'approdo ultimo della secolarizzazione: il nichilismo. Stirner si propone di eliminare ogni trascendenza dal piano autentico dell'essere, problematizzando una morte di Dio che supera per radicalità quella di Friedrich Nietzsche e di Martin Heidegger, e che non trova confronto in nessun altro esponente del pensiero occidentale. In lui, più che in qualunque altro, la morte di Dio è totale e definitiva. Cosa sostanzia l'ateismo stirneriano rendendo irreversibile la morte di ogni divino? La coscienza del nulla, che non è un orizzonte teorico aperto sull'indicibilità dell'essere, ma è la pura e definitiva consapevolezza della morte di ogni pensare filosofico che sia rivolto alla ricerca dell'essere stesso: Dio è negato in quanto non c'è nulla da dire sull'essere non perché il nulla intenda o alluda a esso, ma perché la consapevolezza del nulla testimonia l'arbitrarietà di ogni discorso sull'essere, la sua gratuità, la sua non-fondazione. Il nulla è la valenza non ontologica di ogni scelta e dunque la valenza non ontologica di ogni esistere, nel senso che ogni scelta non ha fondazione essendo ontologicamente arbitraria. Essa testimonia infatti l'infinita possibilità di tante fondazioni, di tanti esseri, e quindi della mancanza dell'Essere. Il nulla stirneriano non è il nulla ontologico in sé, vale a dire lo speculare rovesciamento di un nuovo filosofare teologico. È, piuttosto, la nientificazione del pensare in quella direzione, l'azzeramento di ogni nostalgia dell'essere. La consapevolezza del nulla inteso come niente è dunque la coscienza della mancanza di ogni fondazione, precisamente dell'impossibilità ontologica dell'esistenza di un centro. Così con la morte di Dio viene affermata l'impossibilità ontologica di un'unica e sola legittimazione, e per conseguenza la possibilità esistenziale dell'unico. Questa possibilità deriva dalla radicale assunzione del nulla quale esito ineludibile del disincanto del mondo. Con Stirner gli obiettivi dissacranti dell'illuminismo arrivano alla loro logica conclusione: il filosofare dell'unico, a differenza di ogni altro filosofare, non soltanto esplicita il nulla, ma lo rende indispensabile per operare la conversione da una significazione del mondo imposta all'individuo a una significazione del mondo prodotta dall'individuo. Questi è, di per sé, un ente già compiuto, finito e, in questa finitezza, anche perfetto, appunto perché unico. Poiché anche l'unico è fondato sul nulla ed è unico perché ha la piena e definitiva consapevolezza di essere non-fondato, allora l'unico è pure, per intrinseca definizione, un non-centro. Esso non rivendica di essere il centro assoluto, ma un centro. Certo, in questo centro egli è assoluto, ma assoluto nella sua esistenza, cioè nella sua unicità-fattualità. Bisogna precisare che il termine ultimo e non più avanzabile del processo di secolarizzazione si rappresenta, per l'appunto, con il termine unico perché questo è l'ultimo predicato, cioè la terminale descrizione di ogni pensiero. L'unico è soltanto un nome, privo di determinazione, un termine privo di pensieri. La negazione di Dio è al tempo stesso superamento di ogni trascendenza e affermazione della radicale immanenza rappresentata dal singolo inteso come ente irripetibile. Insomma l'individuo, determinato nella sua specifica esistenza, costituisce il termine ultimo al di là del quale la secolarizzazione si arresta. L'unicità individuale è la tappa finale dell'immanentizzazione atea: il centro del mondo non è più Dio, ma l'io: oltre questo non si può andare. La centralità dell'individuo azzera ogni significazione del mondo che non sia la sua creazione. Con essa finisce lo svolgimento concettuale di tutto il pensiero e di tutta la metafisica occidentale. La natura antiautoritaria dell'ateismo stirneriano è chiara: la consapevolezza del nulla rimanda alla non-fondazione di Dio, questa all'unicità dell'unico, che è assoluto e perfetto nella sua unicità appunto perché, come Dio, fondato sul nulla. Non esistendo alcun centro o fondazione, l'unico non può che essere il nulla di ogni altro. Di qui l'ambito sconfinato della libertà, dal momento che il nulla di ogni altro è propulsivo dell'infinita libertà di tanti unici, essendo infinito il campo della possibilità esistenziale derivante dal nulla. Il processo della secolarizzazione giunge all'approdo logico del nichilismo, ma questo si risolve in una libertà senza limiti perché la negazione di Dio (in quanto premessa filosofica della stessa libertà del nulla, della non-fondazione) è propulsiva di un universo esistenziale dove non c'è, per principio, il centro. Così la fine di ogni divino, di ogni trascendenza, di ogni alienazione non consiste nel fatto che tali dimensioni sono venute meno per essere state negate, ma perché è stata affermata, per l'appunto, la non centralità nel tutto e perciò la sua implicita e strutturale non gerarchica costituzionalità.
La trascendenza negata
In questo modo egli allarga anarchicamente l'ambito tematico dell'ateismo, la sua polivalenza critica e ideologica. Qui per ateismo si deve intendere infatti il rifiuto dell'immanentizzazione umanistica intesa quale logica reazione di rigetto alla desacralizzazione del mondo. Non si tratta più di negare il Dio dei cieli, ma ogni forma di trascendenza rispetto al singolo. La trascendenza, ovvero l'estraniazione, regola il rapporto gerarchico che fa dipendere l'uomo da tutto ciò che lo domina e lo condiziona. L'ateismo di Stirner è dunque il dissolvimento di ogni gerarchia: non si uccide Dio spodestandolo dal cielo per farlo rivivere sotto le spoglie dell'uomo, ma abolendo il rapporto stesso di dipendenza tra il singolo individuo e ogni entità che gli è estranea e che lo sovrasta. Dio è negato non perché è Dio, ma perché viene annullato il rapporto di dipendenza tra soggetto e oggetto. La pura forma di ogni rapporto gerarchico-ontologico si riassume pertanto nell'essere-dipendenti-da, nel senso che è ininfluente la specificità dell'oggetto e del soggetto, mentre, decisivo, è il rapporto che li regola. Qui si vede come Stirner accomuni nella dimensione santa (cioè nella sacralizzazione della gerarchia in sé, nell'essere-dipendenti-da) il cattolicesimo, il protestantesimo, il deismo e la religione umanitaria, vale a dire le fondamentali sequenze evolutive dell'esperienza religiosa dell'età moderna. Dalla Riforma alla rivoluzione francese non vi è stata per Stirner che una continua metamorfosi della credenza nel divino. La storia umana è stata dunque, fino a quel punto, la storia della libertà della religione, la sua progressiva valenza spirituale e istituzionale. Questa identificazione tra cattolicesimo, protestantesimo, deismo e umanitarismo non è arbitraria ai suoi occhi, posto l'assunto che vuole la fenomenologia del sacro come essenza della religione. Per cui se gli zelatori del sacro sono diversi, sono pur sempre tutti credenti, non essendo la fede morale sostanzialmente diversa da quella religiosa. In questa critica, che configura una nuova versione del principio di gerarchia nel mondo moderno, Stirner dissolve l'idea di verità nella ragione dell'unico. La verità è l'ultima attestazione della divinità in quanto intrinsecamente ontologica, dal momento che esprime il mondo stesso dell'assiologia, che non sarebbe più tale se non fosse considerato vero. Può essere discusso ogni singolo valore, ma non il concetto di valore perché qualora ciò avvenisse sarebbe come affermare che non c'è verità. Con la morte della verità, come dimensione di un dominio che sta sopra l'unico, muore ogni trascendenza perché il solo orizzonte ontologico è quello della proprietà dell'unico intesa come capacità unicista di appropriazione del mondo. Si apre così per Stirner il varco della libertà effettiva dell'individuo, una volta che questi, naturalmente, si sia liberato da ogni soggezione alla trascendenza. Ma sotto quale punto di vista la fine di ogni trascendenza porta alla libertà? Anche questa, per Stirner, può essere una trascendenza, se viene intesa come qualcosa di assoluto. Bisogna infatti osservare che l'ideale della libertà assoluta ripresenta le stesse assurdità di ogni assoluto. L'assurdità consiste nel fatto che l'ideale di libertà concepito come una nuova missione da compiere, configura un'astrazione alienante, dal momento che esso, realizzandosi in sé e per sé, pone un ambito di estraneità rispetto al singolo, e quindi rispetto alla sua specifica libertà. La libertà deve liberare l'unicità quale dimensione autentica dell'individuo. Precisamente, la libertà è mezzo all'autenticità dell'individuo e l'autenticità dell'individuo è mezzo alla verità della libertà, che risiede nella sua effettività. La potenzialità fonda la capacità creativa e propositiva dell'io, la radicalità richiama la volontà dell'individuo proprietario, termine ultimo e non più scomponibile del processo di secolarizzazione. In questo rapporto la libertà individuale testimonia l'impossibilità di un suo accordo con l'uguaglianza fra gli individui. Infatti, se essa è la manifestazione della reale potenza individuale, intesa come potenza precisa di ogni specifico unico, allora viene meno ogni confronto generale. L'individuo è irripetibile e dunque non è soltanto diverso da tutti gli altri individui, ma è pure, rispetto ad essi, incommensurabile. L'indicibilità della singola esistenza impedisce la possibilità di porre su uno stesso piano le diverse capacità operative degli unici, cioè le diverse libertà. Ogni universalismo è falso, anzi alienante, per cui l'uguaglianza, quale massimo ideale universale, non si sottrae a questa sorte. L'uguaglianza, per Stirner, è un non senso. Come la libertà, come l'umanità, essa è soltanto un nome. Si può dire però che l'azzeramento di ogni alienazione, compresa quella data dall'ideale dell'uguaglianza, permette di fatto, attraverso le diverse libertà individuali, la realizzazione piena delle chances di tutti gli individui, di tutte le loro possibilità esistenziali. Quindi ogni esplicazione della potenzialità individuale è, in ogni dato momento, l'uguaglianza realizzata di tutte le libertà dei singoli: qui l'uguaglianza delle possibilità non viene dichiarata, ma praticata.
L'io indicibile
Arriviamo così a definire la natura anarchica della libertà delineata da Stirner. Il processo di secolarizzazione, nel suo disincanto del mondo, ha evidenziato l'io come termine ultimo della negazione del divino. La logica intrinseca di questa scomposizione della realtà gerarchica, dello svelamento della sua immagine arbitraria, definisce a sua volta l'io come il singolo esistenziale e dunque come una realtà indicibile. Essendo unica, singolare e irripetibile, questa esistenza si sottrae a ogni attributo universale, a ogni tentativo di definirla e di fissarla e dunque di limitarla: niente può veramente nominare e individuare l'unico. Così l'"indicibile" è sempre aperto sulle infinite possibilità esistenziali dell'unico stesso. Esso si riserva all'infinito le intenzioni di questa unicità, che nella sua esistenza può tentare di essere tutto ciò che vuol essere. Ma in che senso l'intenzione apre l'orizzonte anarchico della libertà? La libertà anarchica rovescia, anzi dissolve, l'ideale umanitario nato dalla civiltà stessa del cristianesimo. Questa svolta epocale si verifica perché viene meno ogni significazione esterna dell'individuo, compresa, paradossalmente, anche quella data dalla stessa libertà. Per cui il rapporto tra la libertà e la storia diventa l'impossibile incontro tra l'irripetibilità dell'individuo concreto e la storia universale: la caducità di quello dissolve l'astrazione di questa. Attraverso l'esplicazione della libertà si critica il diritto e lo Stato, in quanto, anch'essi ultime forme secolarizzate della metamorfosi religiosa. Ciò che accomuna tutte queste realtà (Stato, politica, diritto) è dunque l'uguale dimensione autoritaria, che consiste nell'attribuire all'essere umano una vocazione, una specifica missione, pretendere insomma di sapere quello che deve essere e quello che deve fare. La politica è il prolungamento secolare della religione: come la Chiesa è la forma istituzionale di questa, così lo Stato è la forma istituzionale della politica. Lo Stato, infatti, non sarebbe tale se non pretendesse di realizzare l'ideale dell'umanità, cioè la forma secolarizzata della religione. In questo senso lo Stato moderno porta definitivamente a termine la missione terrena della Chiesa: realizza la santità sul terreno della storia mondana. Ponendosi come unico depositario della legge, e pertanto come unico rappresentante della socialità umana, esso esprime la dimensione del sacro nella sua valenza terrena. Stato e Chiesa sono le estreme forme istituzionali di questa sacralità ipostatizzata e del suo ineliminabile rapporto dialettico con la libertà del singolo. Ma lo Stato, a differenza della Chiesa, impersonifica con maggior perfezione il principio di autorità grazie all'immanentizzazione umanistica. Lo Stato è lo stesso principio dominante eretto a istituzione perché unisce la vocazione religiosa con la possibilità secolare, per cui risulta che la forma statale è più universale della forma ecclesiale. Lo Stato, rispetto alla Chiesa, è la logica tappa storica del processo di secolarizzazione, l'umanità universalizzata nella sua forma istituzionale, che si esprime inevitabilmente nella legge dell'uomo contro la volontà del singolo. Con ciò Stirner indica l'equivalenza operata dal dominio statale, che in questo caso si esprime traducendo il genere umano nella forma istituzionale. Gli attributi dell'uomo, trasferiti nell'ideale dell'umanità, sono ricomposti nella forma coercitiva dell'universalità statuale: non c'è vita sociale fuori dello Stato perché non c'è vita umana fuori da questo ideale. Esso esprime tutta l'umanità, per cui chi non rientra nel suo ambito non fa parte della comunità degli uomini. Nello Stato si rappresenta questa intera comunità, la sua universale essenza, la sua genericità tout-court. Esso si dà come realtà assoluta perché è antecedente a ogni singola volontà. Si tratta dunque di una presenza totale, che discende non tanto da una particolare forma dello Stato, ma dalla sua stessa esistenza. La modernità è caratterizzata dal paradosso Stato, che, mentre realizza la vocazione dell'uguaglianza giuridica, invera, per contro, l'aspirazione presente in ogni epoca: porta infatti a compimento, fino alla sua perfezione, il principio di autorità. La rivoluzione francese rivela così l'intima contraddizione insita nell'idea moderna di emancipazione politica: cercando il principio dell'uguaglianza si è realizzato fino in fondo il principio di autorità. In tal modo Stirner individua, in senso fortemente anarchico, un passaggio chiave della storia moderna: il percorso della veicolazione del principio statale (inteso come uguaglianza giuridica dei diritti) attraverso il principio nazionale. è dunque a quest'ultimo che va imputata, per l'anarchismo, la forma ideologica della mistificazione politica dell'uguaglianza democratica nata nel 1789. Nel realizzare l'uguaglianza dei diritti, la borghesia ha dunque portato a compimento il principio di autorità attraverso l'emancipazione politica. L'uguaglianza giuridica, realizzando tale conquista, ha dato piena libertà allo Stato, nel senso, appunto, che da un lato esso si invera nell'universalizzazione democratica dei "cittadini", dall'altro, però, questa universalità pone in essere la libertà assoluta dello stesso dominio statale. Con la radicale contrapposizione allo Stato Stirner conclude la critica ai molteplici aspetti del principio di autorità rappresentati dalla religione, dalla Chiesa, dal diritto e dalla legge. A questo insieme autoritario egli oppone un rifiuto filosofico-esistenziale, le cui implicazioni sono anche politiche e sociali. Tuttavia, il senso della negazione stirneriana, proprio per la sua radicale valenza anarchica, non può essere traducibile in un progetto collettivamente percorribile sul piano storico, inteso, quest'ultimo, quale campo d'azione determinato nello spazio e nel tempo. Di qui la non risolta dimensione della sua ribellione, i cui presupposti epistemologici sono dati dalla contemporanea contrapposizione e distinzione tra essa e la rivoluzione. La rivoluzione è la negazione di un dominio determinato, la ribellione del dominio in quanto tale. Mentre la prima si esprime come negazione concreta, la seconda si dà come negazione metafisica. La diversità della ribellione rispetto alla rivoluzione è dunque chiara. Non esiste, in Stirner, una teoria della ribellione come strategia sociale dell'emancipazione. In questo senso, ma solo in questo senso, si può parlare dell'anarchismo stirneriano come di un anarchismo particolare, sui generis, non strettamente politico-ideologico, ma precipuamente filosofico; oppure di un rivoluzionarismo senza rivoluzione. Il referente antagonista della ribellione, infatti, è il paradigma del potere in quanto tale, non la forma specifica di un determinato potere. L'auto-valorizzazione, quale tensione oppositiva all'auto-pauperizzazione, delinea una specifica scelta metodologica propria della prassi sovversiva, che può, appunto come metodo, essere applicata a tutte le situazioni storico-particolari. Questo è dunque il senso ultimo della ribellione, che in tal modo rende evidente la dimensione irrisolvibile dell'anarchismo unicista: ogni qual volta è messa in atto, esso diventa abolizione del paradigma del dominio in quanto tale perché, per la propria natura, è impossibilitata a prospettare un'azione di mediazione con l'esistente. D'altra parte ogni rivoluzione che non contempli la dimensione della ribellione è destinata alla riformulazione del potere. Di qui l'ulteriore distinzione tra società e unione. La differenza consiste nel fatto che la prima è sempre una perenne forma istituente, la seconda una definitiva forma istituita. Perché l'unione possa sussistere è dunque necessario che i suoi protagonisti siano continuamente pervasi da una spinta vitale a volersi ritrovare. Nell'immediata relazionalità posta dall'unione, gli uomini, in quanto individui irripetibili, smettono di avere qualcosa in comune, ma nello stesso tempo smettono anche di avere qualcosa che li divida. Come unici, infatti, sono incommensurabili e dunque, come non possono avere identità fra loro, così non possono nemmeno avere contrasti. In tal modo Stirner intende andare oltre l'armonismo societario, nello stesso momento in cui rifiuta però anche la strada della conflittualità hobbesiana. Il problema fondamentale di ogni risoluzione collettiva consiste nel delineare un insieme sociale quale continua espressione vitale degli individui. Questo insieme, denominato appunto unione, deve essere capace di rispondere ai bisogni del singolo, ponendo le premesse per il superamento della sclerotizzazione del vivere in comune. Per superare ciò che è sempre stata una ricorrente e pressoché obbligatoria parabola storica (quella del passaggio dalla originaria forma istituente alla definitiva forma istituita), occorre andare oltre il classico rapporto individuo-società, particolare-generale. Si tratta, per Stirner, di una falsa dicotomia, se intesa come dilemma teorico da cui partire per risolvere il problema societario. Infatti tale contrapposizione tra soggettivo-oggettivo, unicità e universalità esiste, ma la forma della sua esistenza indica anche la sua ineliminabilità.
Federalismo e autogestione
Abbiamo visto che in Godwin e in Stirner il rapporto fra libertà e uguaglianza non si risolve in un nesso organico. Ciò avviene invece con Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) che teorizza tale unione attraverso la valorizzazione del movimento storico del socialismo. Questo è concepito lontano da ogni sogno utopistico di rigenerazione totale e di metamorfosi antropologica. Diventa perciò comprensibile la sua critica alla dialettica di Friedrich Hegel. Mentre questi definisce la realtà nella forma triadica di una tesi e di una antitesi, le quali si risolvono in una sintesi superiore, Proudhon afferma che proprio le antinomie sono la struttura stessa del reale. Ogni sintesi è oggettivamente impossibile. Il problema consiste nel trovare non la loro fusione, che sarebbe la loro morte, ma il loro equilibrio incessantemente instabile. Nella sua dialettica, Proudhon distingue la realtà, sede delle opposizioni reali, dal discorso dialettico che ha come obiettivo l'analisi di tali opposizioni. Egli definisce quindi, kantianamente, le opposizioni con il termine "antinomia" e intende con ciò riferirsi all'espressione della realtà delle cose nella loro fattualità; diversamente queste stesse alterità non sono più colte sul fatto, ma argomentate nel discorso, sono da lui definite con il termine controdiscorsi. Perciò il sistema delle antinomie è il metodo impiegato da Proudhon per interpretare la società. Le antinomie, essendo espressione dell'opposizione reale delle cose concrete, dimostrano di per sé l'impossibilità di ogni sintesi a priori e di conseguenza l'impotenza oggettiva di ogni regime volto alla loro forzata mediazione. Si specifica perciò il suo sforzo teorico teso a individuare la forma proporzionale delle parti, nel senso di una loro sostanziale equivalenza. Non esistono elementi più importanti e decisivi di altri nella formazione della realtà, nella strutturazione dello svolgimento storico-sociale. È in tal senso che si precisa l'idea di uguaglianza: come idea di un rapporto reciproco, di un rapporto commutativo. Questa logica di equilibrio e di reciprocità sta alla base del pluralismo, volto appunto a costituirsi come sistema "aperto" capace di far convivere più tendenze di per sé contraddittorie, a porsi come estrinsecazione della libertà nel suo infinito movimento. Perciò questa interdipendenza indica un rapporto di uguaglianza e annuncia in pari tempo la legge della reciprocità e dell'equivalenza che è alla base del mutualismo economico-sociale. Nello stesso tempo, a partire da questa valenza ideologica dell'uguaglianza, è possibile arrivare anche a quella della libertà intesa come pluralismo. Si delinea così in modo inequivocabile il fondamento teorico del suo anarchismo, ossia un relativismo pluralistico che può essere considerato senza alcun dubbio la chiave interpretativa di tutto il suo pensiero, di tutta la sua dottrina. Ne discende pertanto la sua analisi del lavoro collettivo concepito come espressione dell'attività di un essere sociale avente una sua specifica realtà con proprie leggi. La scoperta della società come un essere collettivo reale, autonomo e immanente a tutti i suoi membri, comporta immediatamente la scoperta dei suoi due attributi fondamentali: la ragione collettiva e la forza collettiva.
La forza collettiva
Con la nozione di forza collettiva Proudhon precisa che gli individui, indipendentemente dalle loro capacità e attitudini, vivendo in società ricevono sempre di più di quanto danno; in altri termini l'uomo, nel momento in cui si inserisce nell'attività produttiva e partecipa a un compito comune, diventa immediatamente debitore verso la società di cui fa parte. Questo perché qualsiasi impresa produttiva e sociale, che riunisca gli sforzi individuali altrimenti separati, ha la capacità di generare, proprio attraverso la coesione dovuta al lavoro collettivo, una potenza economica e sociale essenzialmente diversa dalla somma, anche infinita, degli sforzi individuali divisi e non concomitanti. Con la nozione di ragione collettiva Proudhon aggiunge che gli individui non possono associarsi veramente che alla sola condizione che si realizzi tra loro uno scambio fondato sull'uguaglianza. Infatti lo scambio tra non uguali, generando disuguaglianza, provoca continui conflitti sociali, rendendo impossibile la piena realizzazione della socialità umana. La ragione collettiva si estrinseca dunque in questo principio dello scambio paritario fondato su una ragione necessaria, pena la fine della società stessa. Perciò antagonismo e solidarietà, divisione e composizione formano una coppia antinomica irriducibile che si pone oltre l'individualismo classico del liberalismo e oltre l'universo tradizionale del comunismo, per arrivare a una fondazione della società che non è l'assoggettamento dell'individuo alla collettività, né la subordinazione della collettività all'individuo. Il primo, infatti, pretende di liberare l'uomo isolandolo e astraendolo dalla società, il secondo considera l'uomo come una semplice unità sottomessa a una collettività superiore, la quale, schiacciando la personalità, sfocia nel dispotismo. Con queste premesse teoriche il pensatore francese prende in esame ogni forma di proprietà, e quindi ogni teoria che la sottende e la giustifica. Quest'analisi lo porta a concludere che nessuna delle teorie miranti a giustificare tale processo di appropriazione riesce a essere credibile. Non esiste una teoria che riesca a dar ragione logica di questo furto della forza collettiva, che riesca a legittimare ragionevolmente l'esistenza della proprietà. E tuttavia, in merito a tale questione, più importante ancora della critica alla concezione del regime proprietario è la revisione e ridefinizione proudhoniana del concetto stesso di proprietà, con la distinzione fra questa e il possesso.
Proprietà e possesso
Per Proudhon la proprietà non consiste nella facoltà da parte di una persona di fare uso di un bene e di esserne responsabile, ma più esattamente nel fatto economico attraverso il quale la proprietà diventa creatrice di interessi, diventa un capitale fonte di tutte le forme di facile guadagno. Il profitto, l'affitto, l'interesse, in una parola il facile guadagno, sono tutte forme di estorsione, di furto, di plusvalore che Proudhon definisce e raggruppa nell'espressione, intraducibile in lingua italiana, del "droit d'aubaine". Diversamente deve essere inteso il possesso: questo, infatti, è l'uso socialmente responsabile di un bene, al fine di trarne un frutto corrispondente al lavoro individualmente fornito; si tratta di un uso che non implica il diritto assoluto di proprietà, né la possibilità di trasformare il bene di cui si usufruisce in un capitale, a sua volta produttivo di altri, ulteriori beni. Approfondendo l'analisi sociologica Proudhon è riuscito a generalizzare la critica al concetto di proprietà attraverso l'individuazione del concetto di forza collettiva: essa può essere estesa dal campo economico a quello politico. Infatti lo Stato può essere considerato "proprietario" della volontà politica dei cittadini, il partito politico della fede ideologica dei propri iscritti. E ancora: come il capitale risulta dal furto del prodotto della forza collettiva, allo stesso modo il governo deriva dall'appropriazione della forza sociale di cui si arroga la direzione, e così via. La proprietà si presenta quindi come un principio autoritario di equivalenza allargato, nel senso che proprietà e autorità diventano pressoché sinonimi. Abbiamo detto che le antinomie non possono essere superate, ma solo bilanciate e modificate. Questo realismo, teso a cogliere l'infinita pluralità della vita comunitaria, ha il compito di evidenziare la realtà obiettiva delle leggi socio-economiche, affinché da queste leggi il socialismo possa partire per realizzare i propri scopi. Perché qui sta il punto: il socialismo può realizzarsi solo mantenendo l'antinomia. Anche lo Stato è la risultante dell'alienazione della forza collettiva esplicitata a tutti i livelli, da quello sociale a quello economico, da quello culturale a quello psicologico. Per mantenere la propria esistenza, che è fittizia, esso non può che perpetuare l'espropriazione della società e quindi conservare la disuguaglianza: solo a condizione che la società sia e rimanga non egualitaria l'organizzazione statale può sostituirsi a quella sociale, il politico rispondere alle esigenze dell'economico, lo Stato assolvere con autorità ciò che la società dovrebbe svolgere con autonomia. La contrapposizione fra politico e sociale assume senz'altro la forma dello scontro fra autorità e libertà; date queste radicali premesse, Proudhon è conseguentemente contrario a qualsiasi rivoluzione di tipo politico, tale cioè da interessare soltanto il potere. Comprendere la specificità del politico, senza intenderlo come riducibile a mero riflesso delle contraddizioni economiche, significa leggere contemporaneamente la logica del potere, sia nella sua forma generale, sia in quella particolare. La critica proudhoniana si estende a tutte le forme del politico, da quella assolutistica a quella democratica, perché tutte fondate sull'idea che gli uomini debbano cedere la loro autonomia e delegare il loro potere al fine di costruire una sovranità che, volenti o nolenti, dovranno poi rispettare. Perciò solo nella società economica dei produttori, che si contrappongono frontalmente alla società politica dei dominatori, è possibile rintracciare e svelare quella dimensione creativa, spontanea e pluralista dell'agire sociale quale segno inconfondibile dell'emancipazione umana; solo all'interno di una teoria e di una pratica economica si possono correttamente trovare le ragioni e gli scopi di una teoria e di una pratica rivoluzionaria. Secondo Proudhon, le classi operaie sono le sole che possono effettuare la rivoluzione sociale. Tuttavia ciò non avviene in virtù della contrapposizione oggettiva fra capitale e lavoro; infatti questa contrapposizione, sebbene sia la caratteristica centrale del sistema capitalista, è pur sempre una delle tante della società gerarchica; inoltre non esiste una legge deterministica che opponga le masse sfruttate agli sfruttatori: la pluralità delle contraddizioni mostra infatti che i cambiamenti storici non hanno e non possono avere necessitanti esiti univoci, che infiniti fattori dinamici concorrono allo svolgimento complessivo dell'evoluzione umana. Quindi i lavoratori devono mirare all'universalizzazione dei privilegi goduti dalla borghesia; devono, cioè, universalizzare le sue originarie libertà di classe, sorte inizialmente quali strumento di dominio della borghesia stessa. Il compito dei lavoratori non è combattere contro le incompiutezze di classe del liberalismo, per far sorgere dalla classe proletaria un'altra libertà. Ciò è semplicemente un non senso, dal momento che il significato autentico della libertà sta nella sua universalità. Bisogna quindi conferire un significato universale alla libertà, disgiungendola da ogni reazionaria collocazione classista. Il socialismo è dunque il superamento storico del liberalismo. È così che la rivoluzione sociale realizza il suo compito: portare al suo termine finale l'evoluzione politica della società risolvendola nella libertà e nell'anarchia. Ora, qual è la concezione politica più approssimata dell'anarchia? Il federalismo, risponde Proudhon, ed è perciò qui che egli focalizza la sua attenzione e la sua riflessione in modo particolare. Il federalismo proudhoniano sa risolvere in una continua tensione di libertà i termini, dati prima come teoricamente insopprimibili, della libertà e dell'autorità. Il federalismo, cioè, è la realizzazione storicamente possibile della libertà e dell'anarchia perché mantiene i due princìpi di libertà e di autorità, risolvendoli in una transazione che si dà come continua divisione e ricomposizione, come continuo conflitto e perciò, oggettivamente, come continua tensione di libertà. La libertà è la realizzazione di questa transazione, che tende a spostare il peso dell'autorità a favore della libertà, "essendo nella natura delle cose" che il principio di autorità sia "iniziatore" mentre il principio di libertà determinante. Abbiamo detto che la dialettica proudhoniana non risolve in una sintesi superiore le opposizioni della vita socio-economica. Tale concezione, che vede nel continuo svolgimento delle antinomie la struttura stessa del sociale, porta Proudhon a formulare la dottrina del federalismo pluralista, considerata a suo parere l'unica realistica perché le contraddizioni, costituendo la linfa vitale della società, sono insopprimibili. Esso infatti deve garantire, con la sua dimensione aperta, l'eguale possibilità di espressione di ogni individuo o gruppo, in armonia con le proprie esigenze geografiche e le proprie tradizioni storiche. Il sistema federativo deve essere insomma il risultato degli equilibri da ricercarsi nel rapporto fra gruppi e individui, fra unità e molteplicità, fra società globale e raggruppamenti particolari, fra coesione e libertà. Riconoscere l'equilibrio a ogni livello sociale è dunque il compito fondamentale del socialismo che voglia essere veramente autogestionario. Si delinea a questo punto il problema fondamentale della proprietà nel regime autogestionario. Essa può definirsi come possesso nel senso che, "socializzandosi" e "umanizzandosi", diventa una funzione sociale definitivamente sottomessa alla regolamentazione interna del nuovo diritto economico e della giustizia sociale. Su questa proprietà federalizzata che cambia non solo di soggetto, ma di natura, Proudhon fa poggiare la federazione agricolo-industriale, la quale attribuisce gli strumenti di produzione contemporaneamente all'insieme della società economica, a ogni regione, a ogni gruppo di lavoratori, a ogni operaio e contadino considerati individualmente. Essa organizza una proprietà federativa e mutualista dei mezzi di produzione i cui possessori sono simultaneamente l'intera organizzazione economica, centrale e regionale, le diverse branche dell'industria, ogni fabbrica e infine ogni lavoratore. Il possesso universalizzato non comporta però la spartizione della proprietà, che resta una e indivisa. In altri termini, gli individui possono richiedere il riscatto della loro parte, prodotta dal proprio lavoro, al fine di realizzare un'altra, ulteriore unità produttiva o sociale, senza pretendere tuttavia la divisione della proprietà precedente. Nella pluridimensionalità dell'autogestione proudhoniana non deve essere ravvisata una tendenza latente e oggettiva all'integralismo sociale, politico, economico e culturale. Il decentramento e l'autonomia politica, sociale ed economica dei gruppi e degli individui sono la garanzia obiettiva della differenza fra piano politico e piano economico perché nella concezione proudhoniana la dimensione territoriale non coincide con quella produttiva, né quella produttiva con quella politica.
Rivolta e rivoluzione
Il nesso organico tra libertà e uguaglianza che in Proudhon si esplicita come problema di risoluzione di un equilibrio, con Michail Bakunin (1814-1876) diventa il nucleo dell'anarchismo inteso come pensiero in azione: la libertà esprime il momento della rivolta, l'uguaglianza quello della rivoluzione. Sono due aspetti di una stessa sequenza. Vediamo. La libertà è la cifra dell'emancipazione dell'uomo e il fine supremo della storia. Poiché in sé costituisce un tema infinito, la libertà conferma l'infinito e l'indefinito procedere della storia, così da non darsi mai quale finalità teologica, ma quale essenza umana: la storia in sé e per sé non ha un fine prestabilito perché quest'ultimo viene imposto dalla volontà degli uomini. Dire libertà significa dire umanità, nel senso che l'una definisce l'altra. La necessità della libertà coincide con la necessità dell'umanità perché un'umanità non libera non è veramente tale. Solo ciò che è umano può essere libero e un'umanità libera si auto-riconosce come umana appunto perché ha scelto di essere libera. L'uomo è tale in quanto, a differenza di ogni altro essere vivente, ha conquistato la nozione di libertà ponendola quale condizione primaria della sua identità ontologica. Ma la libertà non è solo umana in senso antropologico, lo è ancor più in senso sociale. Non si è liberi se tutti gli altri non lo sono, nel senso che l'universalizzazione collettiva della libertà è la stessa libertà individuale ampliata alla sua infinità. L'universalizzazione della libertà rappresenta la forma sociale dell'essenza umana: secondo Bakunin, infatti, la vera libertà individuale non può non farsi, immediatamente, libertà generale. Ecco dunque il fondamento "oggettivo" della libertà, nel senso che, delle varie possibilità date all'umano di essere quello che vuole essere, solo la libertà contiene fino in fondo la cifra fondativa di se stessa perché niente le è più universale. L'universalità della libertà consiste nel non essere preventivamente fondata e dunque, proprio per questo, nell'essere scelta all'infinito. L'impossibilità di fondare a priori la libertà è la condizione della sua unica e possibile fondazione perché niente può essere più vero dell'umano e niente può dare più umanità all'umano che la sua forma sociale, la sua essenza di libertà, appunto, ampliata all'infinito. Preliminarmente il rapporto tra libertà e rivolta è dato proprio dalla condizione oggettiva della natura necessitante della libertà stessa, nel senso che questa, essendo la cifra specifica dell'umanizzazione della società, è anche, per conseguenza, la cifra specifica del grado di civiltà prodotto dall'evoluzione umana. Questa libertà, intesa come esito necessitante dell'umanizzazione dell'umanità, non è una forma di determinismo, ma di conoscenza scientifica: soltanto se l'uomo è consapevole di essere materialisticamente determinato può essere libero. La libertà è rivoluzionaria non quando attacca un'autorità storicamente determinata, ma quando ne demolisce il principio informatore, la cui natura non può che essere metafisico-universale in quanto essa, per l'appunto, è ravvisabile in ogni particolare concretezza storica. Il principio informatore, ovvero il concetto sotteso all'esistenza specifica di ogni realtà storicamente data. Ecco perché Bakunin si pone contro i due massimi archetipi dell'autorità: l'archetipo divino e quello mondano, ovvero Dio e lo Stato. Essi non sono due entità ideali, ma due princìpi attivi, reali, sono le colonne sulle quali si regge l'ordine gerarchico che governa il mondo. Perciò solo assaltando il supremo principio metafisico del cielo e della terra diventa possibile demolire ogni sua fenomenologia materiale.
Libertà contro autorità
La rivolta della libertà contro il principio di autorità è prima di tutto la lotta mortale dell'uomo contro Dio perché, in quanto tale, Dio incarna il principio di autorità concepito in termini assoluti. La sua dimensione autoritativa si rinviene nel suo stesso concetto. In quanto estremo concetto metafisico, Dio rappresenta al massimo grado l'autorità non tanto in termini di "contenuto" (Dio padrone del mondo), quanto in termini di forma. Essendo, per l'appunto, concepito dall'uomo in senso assoluto (sciolto cioè da ogni determinatezza) esso non può che essere per eccellenza proprio lo stesso principio di autorità elevato alla sua più alta espressione: infatti il principio, inteso per sua stessa natura, è un concetto astratto e Dio è la massima astrazione pensabile di questo concetto. Prima di essere esistenza divina, esso è l'archetipo supremo del dominio. Si apre in tal modo il problema decisivo della secolarizzazione. L'anti-teismo sembra infatti implicare il trasferimento dell'assoluto dal cielo alla terra e dunque la divinizzazione dell'uomo. L'uomo nega Dio diventando a sua volta Dio, per cui il prometeismo tende a risolversi in delirio di onnipotenza. L'uomo non ha più limiti, egli può autorizzarsi qualsiasi cosa. È inutile sottolineare le valenze nichilistiche di questo processo che attraversa, quasi senza soluzione di continuità, tutto l'ateismo ottocentesco, da Auguste Comte a Karl Marx, da Marx a Nietzsche. Ma, viene da chiedersi, ciò vale anche per Bakunin? Bakunin sembra essere consapevole di queste implicazioni assolutizzanti, quando cerca di rovesciare tale obiezione di fondo, dimostrando che la divinizzazione dell'umano è, invece, del tutto consequenziale alla fede dei credenti, mentre, contemporaneamente, l'ateismo postulatorio (la libertà dell'uomo contro la libertà di Dio) non può che sfociare nell'umanizzazione imperfetta e dunque nell'esatto opposto di ogni delirio di onnipotenza. Ciò avviene, però, soltanto se la finitudine dell'uomo è attraversata da quello scambio anarchico di libertà tra gli individui che costituisce l'essenza stessa della società. La libertà, infatti, scaturisce dall'imperfezione umana, cioè dal bisogno associativo degli individui che si riuniscono appunto perché mortali, finiti, imperfetti. La libertà anarchica non può, di per sé, produrre alcun sogno perfezionistico perché sancisce, all'opposto, il bisogno dell'uomo di associarsi, unica condizione perché la libertà diventi umana. Insomma, l'equazione uomo-società-libertà ci riporta alla dialettica tra finito e infinito, attraverso la perfetta incompatibilità antinomica, in termini di libertà, tra l'uomo e la religione. Il delirio di onnipotenza scaturito dall'ateismo non coinvolge l'anti-teismo bakuniniano, che si fonda sul presupposto, irrinunciabile, della libertà umana come libertà ontologicamente imperfetta. L'unico attuabile assoluto che gli uomini possono edificare in terra consiste nell'"infinità uguale degli uomini", nella "società", e nasce dalla consapevolezza che l'umano è libero solo se è sociale ed è sociale solo se si riconosce come imperfetto: la libertà dell'uomo è contro la libertà di Dio perché rivendica la sua infinita finitudine. A questo punto il rapporto tra libertà e rivolta si allarga alla seconda implicazione presente in questo paradigma. Il contrasto tra libertà umana e libertà divina implica l'ulteriore contrapposizione tra libertà sociale e libertà politica, tra società e Stato. L'equazione uomo-società-libertà contiene questa seconda valenza, nel senso che la lotta dell'uomo contro l'ente divino porta per logica conseguenza alla lotta dell'uomo contro l'entità statale. Lo Stato, infatti, è il secondo archetipo del dominio, la seconda impersonificazione del principio di autorità, l'ulteriore impedimento della libertà umana. E come questa è incompatibile con quella divina, così quella sociale è incompatibile con quella politica: insomma, l'umano è antinomico al divino come il sociale lo è al politico. L'equazione uomo-società-libertà esprime tutta la sua simmetria quando dà corso alla seconda contrapposizione derivante dall'intrinseca relazione tra Dio e lo Stato. Ma cosa significa ampliare e rafforzare sempre più la libertà? Significa questo, ovviamente: universalizzare la libertà stessa. E per universalizzarla c'è solo un modo: perseguire l'uguaglianza. In termini bakuniniani il problema chiave del rapporto tra libertà e uguaglianza non è quindi un rapporto dovuto a una sintesi, ma a una estensione del primo termine tramutatosi nel secondo. Di per se stessa, l'uguaglianza non ha una fondazione ontologica pari a quella della libertà: essa è la libertà che si autoriconosce nella sua realizzabilità storico-sociale. L'umanizzazione della società avviene per mezzo della libertà nell'uguaglianza. Infatti la libertà di ciascuno non si realizza che nell'uguaglianza di tutti.
La divisione gerarchica del lavoro sociale
Bakunin analizza la divisione gerarchica del lavoro e specificamente la sua forma verticale più evidente: quella fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, divisione che costituisce a suo giudizio la causa costante e principale della disuguaglianza sociale e quindi delle classi. Tale separazione deriva dal monopolio della scienza e, in generale, dal monopolio di ogni conoscenza socialmente utile ai fini del comando economico e politico. L'analisi della divisione gerarchica del lavoro permette di risalire alla struttura che sta alla base del principio di autorità e di gerarchia, descrivendone e identificandone le componenti costanti e le sue forme caratteristiche, gli elementi che per la loro natura strutturale si ripresentano e si concretizzano nelle differenti società storiche, assumendo di volta in volta le forme socio-economiche a esse inerenti e l'apparato politico che le vivifica e le giustifica. Si comprende ora come si configuri nel pensiero dell'anarchico russo l'abolizione delle classi: essa non può che scaturire dalla abolizione della divisione gerarchica del lavoro e dalla conseguente socializzazione universale del sapere. Nasce così la visione bakuniniana dell'istruzione integrale quale propedeutica all'integrazione del lavoro manuale e intellettuale in ogni uomo e donna. Si deve concludere che solo con l'istruzione integrale uguale per tutti, tesa a portare ogni individuo ai gradi più elevati della conoscenza, si può realizzare l'uguaglianza. Di qui la teorizzazione di una istruzione e di un'educazione che siano finalizzate a uno sviluppo integrale e armonico di ogni potenzialità umana sia fisica sia intellettuale in grado di superare l'alienazione presente nella persistenza di ogni attività unilaterale. Così il lavoro, ricomposto nella sua totalità, farà dell'essere umano una persona completa e libera rispetto alla collettività e alla natura. E con ciò entriamo nella dimensione socialista del pensiero bakuniniano. Ancora una volta, è la libertà a costituire il concetto cardine su cui ruota la costruzione teorica di Bakunin perché è solo nella misura in cui questa libertà può essere universalizzata che si apre lo spazio possibile della socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio. Poiché non è concepibile una trasformazione della società se non partendo dalla indivisibile libertà individuale e, d'altro canto, poiché questa libertà può realizzarsi solo con l'instaurarsi di un'effettiva uguaglianza fra tutti gli individui, se ne deve dedurre che i piani interagenti della libertà e dell'uguaglianza sono l'imprescindibile condizione ideologica per realizzare la società senza classi. Si deve qui, pertanto, aprire una decisiva distinzione tra socialismo, abolizione delle classi e uguaglianza perché queste tre definizioni non sono affatto sinonime. Per Bakunin sia il socialismo sia l'abolizione delle classi hanno senso solo se realizzano l'uguaglianza, dato che questa non è automaticamente implicita negli altri due termini: si possono dare infatti un socialismo o una società senza classi che non includano per nulla l'edificazione effettiva dell'uguaglianza, intesa, appunto, come universalizzazione conseguente della libertà e dunque come realizzazione-restaurazione delle diversità naturali. In conclusione il concetto di uguaglianza (come quello di libertà) è infinitamente più universale di quello di socialismo e di società senza classi, che sono formulazioni legate a particolari contingenze storiche. Il concetto di uguaglianza rimanda a quello opposto di gerarchia e questo all'idea di dominio, tutti termini che di per se stessi non designano una specifica società. In questo senso è solo la categoria dell'uguaglianza che permette a Bakunin di anticipare l'obiezione teorica per una nuova diversa riproduzione gerarchica, e cioè la teorizzazione della disuguaglianza naturale e la conseguente giustificazione ideologica dell'aristocrazia dell'intelligenza. L'ideologia meritocratica, sanzionando appunto, non più una disuguaglianza storica, ma naturale, supera non solo ogni precedente giustificazione etica della gerarchia sociale, ma stabilisce e precisa, in questa gerarchia, dei caratteri assolutamente immodificabili. È evidente infatti che, mentre gli impedimenti di carattere storico sono tutti, volendo, eliminabili, quelli di carattere naturale, sono, al contrario, inamovibili: ammesso che fosse possibile violentare la natura, quali forze storiche, sociali, politiche assumerebbero questa responsabilità? Chi, in altri termini, porrebbe il proprio ordine in antitesi con quello naturale? Per il pensiero bakuniniano la teorizzazione della disuguaglianza naturale (e la conseguente giustificazione dell'aristocrazia dell'intelligenza e della società meritocratica) non è che l'ideologia più conforme al modello puro di società autoritaria. Segnatamente essa giustifica proprio quella divisione gerarchica del lavoro sociale e, specificamente, quella divisione verticale del lavoro fra manuale ed intellettuale, la quale costituisce, come abbiamo visto, la radice strutturale della disuguaglianza sociale fra gli uomini, la causa, cioè, costante e principale di ogni sfruttamento economico in tutte le sue variabili storiche. Bakunin, puntualizzando la sua analisi attorno ai termini profetici, ma non tanto immaginari, di una possibile società organizzata e governata da un'accademia di eruditi e di sapienti, guidati pure sinceramente dalle idee del bene e del vero, intuisce la natura della nuova classe in ascesa verso il potere. Essa fonda la sua forza su una sorta di proprietà dei mezzi intellettuali della produzione, e cioè sul possesso delle conoscenze scientifiche, tecniche e amministrative inerenti alle funzioni direttive dei grandi aggregati economici e politici. La "proprietà intellettuale" è dunque il capitale specifico di questa classe vera nuova aristocrazia, dedita a quelle attività della sfera del lavoro intellettuale corrispondenti alle funzioni direttive nella divisione gerarchica del lavoro sociale. La statalizzazione dei mezzi di produzione, l'accentramento ai vertici direzionali dello Stato delle funzioni economiche, tecniche e scientifiche, la pianificazione della produzione e del consumo costituiscono la base socio-economica di questa classe e la sua giustificazione ideologica è la teorizzazione della meritocrazia che, sanzionando una disuguaglianza non più storica ma naturale, si esprime, come abbiamo visto, come l'ultimo rifugio della volontà di dominio. Abbiamo visto che la rivolta della libertà contro il principio d'autorità di per sé non necessita dell'uguaglianza, mentre la libertà che chiede di universalizzarsi diventa uguaglianza e, una volta riconosciutasi in questa nuova posizione storica, sfocia, inevitabilmente, nella lotta contro il dominio storicamente dato: solo allora la libertà diventerà rivoluzione. Ed è qui che si apre la pagina più problematica del pensiero bakuniniano. Nel farsi attivamente uguaglianza, la libertà passa dal piano della rivolta a quello della rivoluzione attraverso una serie di travagli che segnano contraddittoriamente il pensiero dell'anarchico russo. Si tratta di incongruenze profonde perché scaturiscono da un'azione che vuole porsi contemporaneamente nella storia ma contro la storia, da un progetto che, pur riconoscendo l'oggettività di alcune condizioni storiche, vuole forzarle ai propri fini. In virtù di questa antinomica duplicità, la teoria bakuniniana trasforma l'immanentizzazione del divino in un'immanentizzazione positiva e totale, nel senso che i valori libertari ed egualitari da perseguire non possono essere svolti separatamente né, quindi, essere scissi nella storia e nella società. Per cui la misura umana del precedente anti-teismo si trasforma in un prometeismo senza residui e la rivolta anti-metafisica contro il principio di autorità in una lotta contro qualunque riproduzione storica del dominio e, più in generale, dell'intero esistente. La rivoluzione è il passaggio dall'autorità storicamente determinata alla libertà senza determinazioni e dunque essa non può che delinearsi quale volontà di conferire alla capacità umana la totale potenza universale alienata da Dio, dallo Stato e dall'assetto capitalistico-borghese in un processo di trasformazione senza interruzioni. Bakunin configura la teoria anarchica della rivoluzione come teoria che non conosce condizioni storiche particolari ai fini del perseguimento del suo principio perché fa coincidere, in un medesimo incrocio spazio-temporale, volontà e progetto sovversivo, nel senso che tutto deve accadere subito.
La "fratellanza internazionale"
In questo passaggio-superamento dal tempo storico al tempo rivoluzionario si dispiega il rapporto senza residui tra libertà e rivoluzione. Pare evidente che il carattere negativista della rivoluzione bakuniniana condiziona in modo pressoché assoluto l'azione sovvertitrice. Lo scopo principale della rivoluzione consiste infatti nella distruzione dell'esistente e, in modo particolare, del suo principio informatore. La centralità della lotta politica è data quindi, in ultima analisi, dalla lotta contro il potere statale, con il contraddittorio, ma del tutto consequenziale, effetto che ciò che viene negato (la politica, appunto) è ciò che viene sostituito al fine originario (la rivoluzione sociale). Insomma, per favorire il dispiegamento del sociale è necessario attivare il politico. Senonché la rivoluzione politica, intesa in questo senso, non può che essere una rivoluzione di avanguardie perché solo le avanguardie possono combattere una lotta di prima linea. Ecco dunque la ripetuta teorizzazione bakuniniana di una "fratellanza internazionale", cioè di una minoranza rivoluzionaria che, suscitando, organizzando e convogliando a questo scopo l'energia sovversiva delle masse oppresse, ha il compito di introdurre l'elemento soggettivo e artificiale dell'insurrezione. Comunque, l'insieme di tutte queste contraddizioni deriva dal fatto che l'azione rivoluzionaria vuole essere nella storia ma contro la storia. La libertà, coniugata all'uguaglianza, diventa così volontà di realizzare con la forza tale unione. Ne consegue che la rivoluzione non può che delinearsi, a sua volta, quale atto totale, dal momento che pretende di essere il compimento contemporaneo e immediato di queste due dimensioni. La radicalità del suo esistere, la verità ontologica della sua azione si misurano, infatti, dalla totalità dell'atto, dall'intenzione della sua irreversibilità, dal fatto, insomma, che essa è tale solo se pone in essere la creazione di una nuova storia. La libertà, che tramite l'uguaglianza diventa rivoluzione, non può quindi sfuggire alla morsa dell'antinomia perché la forzatura del passaggio dai tempi storici ai tempi rivoluzionari la porta alla sua auto-contraddizione: la libertà che lotta contro l'autorità non è antinomica, ma la libertà realizzata per forza non può, ovviamente, che autocontraddirsi. In tutti i casi i rivoluzionari devono abbattere la società presente e solo in minima parte costruire quella futura. Bakunin, quindi, è contro la costituzione del partito politico del proletariato voluto da Marx e dai suoi seguaci. Costituendosi inevitabilmente in organismo produttore e monopolizzatore della scienza rivoluzionaria, perché diretto in ultima analisi da un'élite di intellettuali, il partito non fa altro che favorire la formazione di una nuova classe, riproponendo così con contenuti diversi, ma con identica modalità formale, i gradi gerarchici di ogni struttura autoritaria. Il partito politico del proletariato, infatti, in virtù della funzione intellettuale-direttiva svolta, esercita in pratica il dominio sulle classi popolari, cui è assegnata la funzione manuale-esecutiva di massa di manovra. Le conseguenze socio-politiche di tale strategia saranno, per l'anarchico russo, estremamente nefaste: abituate a ubbidire durante il processo rivoluzionario, le masse si ritroveranno sottomesse a nuovi padroni dopo l'avvento della rivoluzione. Si può ora rilevare nel pensiero bakuniniano, alla luce del rapporto mezzi-fini, un'analogia fra la divisione gerarchica del lavoro sociale e la divisione gerarchica nell'attività rivoluzionaria. è un'analogia che rende inequivocabilmente palese l'abissale differenza fra Marx e Bakunin, perché questi, come voleva abolita la prima, così rifiutava anche la seconda. E cioè, come alla divisione gerarchica del lavoro sociale contrapponeva, nei fini, la sua integrazione egualitaria, così alla divisione gerarchica dell'attività rivoluzionaria (teorizzata da Marx con il partito) contrapponeva, nei mezzi, la sua eguale integrazione. Vale a dire la costruzione di un processo rivoluzionario dove, già nel suo porsi, fossero prefigurati gli obbiettivi finali della libertà e dell'eguaglianza. Quindi, nessuna struttura gerarchica, nessuna divisione verticistica tra funzioni intellettuali-direttive e funzioni manuali-esecutive. Un processo perciò scaturito dal basso, senza una testa autonominatasi avanguardia del proletariato. Solo in questo modo sarebbe stata possibile una reale ed effettiva crescita dell'autocoscienza delle masse popolari ai fini della liberazione umana. Ecco perché, a suo avviso, il superamento della "proprietà intellettuale" dei mezzi di produzione non poteva che passare attraverso la distruzione della "proprietà intellettuale" del processo rivoluzionario.
Solidarietà e uguaglianza
Se in Proudhon la libertà e l'uguaglianza sono termini antinomici di uno stesso equilibrio e in Bakunin sequenze dinamiche di un processo calato contemporaneamente dentro e contro la storia, in Pëtr Kropotkin (1842-1921) vogliono essere momenti autentici di una realtà allo stesso tempo naturale e sociale. La ricerca di un fondamento antropologico e scientifico dell'anarchia come essenziale spiegazione e giustificazione dei suoi valori trova infatti il suo punto più alto e problematico nella sistemazione dottrinaria kropotkiniana. La problematicità è dovuta alla complessità dell'accostamento pressoché antinomico fra natura e cultura, ovvero tra la libertà e l'uguaglianza date come dimensioni autenticamente naturali dell'agire umano e la giustificazione della libertà e dell'uguaglianza concepite quali valori etici generali ed esaustivi della socialità dell'uomo. Quello di Kropotkin è il tentativo di giustificare la libertà e l'uguaglianza attraverso una spiegazione di tipo naturale. L'accostamento appare antinomico e problematico perché, mentre la giustificazione attiene al campo dell'etica, la spiegazione si risolve in quello della scienza. Perciò ecco il teorema di Kropotkin: dare la giustificazione dell'etica attraverso la spiegazione della natura. Ma come risolvere la natura nella cultura, la scienza nei valori? Cioè come formulare una spiegazione che stia a fondamento della giustificazione quale espressione logica dell'equazione: etica uguale autenticità naturale? La risposta kropotkiniana si può riassumere in questa progressiva articolazione: una attenta analisi della natura permette di cogliere la struttura logica che presiede al suo dispiegamento; quest'ultimo può essere sinteticamente riassunto come quel movimento evolutivo che va dalla necessità alla spontaneità: la spiegazione della necessità naturale si traduce dunque nella giustificazione della sua spontaneità. A sua volta l'immediata valenza della spontaneità non può che essere colta sotto il significato della libertà. Natura, spontaneità, libertà: questi i termini della sequenza progressiva insiti nella risposta dell'anarchico russo. A renderli evidenti nella loro intrinseca logicità concorre quindi l'unica branca della ricerca umana capace di una tale indagine: la scienza. Per Kropotkin, dunque, non solo si può assegnare alla scienza una funzione ideologica in senso progressista e libertario, ma anche, per converso, assegnare all'anarchismo il compito di una comprensione scientifica che si identifichi con quella delle scienze naturali. Natura, spontaneità, libertà, ecco i tre termini delineati sopra, qui uniti dal filo della spiegazione scientifica come giustificazione della loro duplice sequenza progressiva perché, se si può arrivare all'anarchia partendo dalla natura, si può ritornare a questa partendo dall'anarchia. E ciò per il particolare significato che Kropotkin assegna alle scienze naturali, quelle scienze, appunto, in grado di operare l'accostamento fra natura e cultura, fra scienza e valori. Ne consegue che Kropotkin delinea la società anarchica quale società naturale che si riconosce come l'autentica società umana. E questo riconoscimento della socialità naturale dell'uomo, del solidarismo spontaneo dell'agire umano, della sua immediata significanza anarchica, tutto ciò, appunto, è dovuto alla comprensione scientifica intesa nella sua accezione più vasta, come idea generale di spiegazione di quel rapporto fra uomo e natura che è oggettivamente privo di soluzioni di continuità. Per elaborare dunque le strutture portanti della società liberata dal dominio è necessario innanzitutto individuare quelle forze vitali che sono più consone a tale progetto. Esse permetteranno di concepire la possibilità dell'emancipazione umana a partire da una condizione oggettiva sempre operante in tutto il corso della storia. Tali forze sono la solidarietà e il mutuo appoggio, fattori supremi della civiltà. La ricerca kropotkiniana vuole dimostrare l'inconsistenza scientifica di quella linea culturale del bellum omnium contra omnes che va da Thomas Hobbes a Thomas Huxley, secondo cui la legge della vita si compendia nella lotta tra le specie e tra gli individui all'interno della stessa specie; linea che porta a riconoscere l'ineluttabilità dell'affermarsi dei più forti. La valenza politica di questa credenza universale, che alla fine dell'Ottocento è riformulata sotto il nome di darwinismo sociale, si rintraccia nella giustificazione ideologica del capitalismo più sfrenato e dunque la sua importanza supera di gran lunga la cifra specificamente scientifica della stessa teoria. È evidente che Kropotkin considera centrale demistificare questa concezione conflittualistica del mondo: qualora infatti risultasse che essa risponde a verità, sarebbe impossibile pensare a una società anarchica che, al contrario, pone l'armonia, l'uguaglianza e l'amore tra gli esseri umani quali premesse indispensabili per il suo stesso costituirsi.
Il mutuo appoggio
Kropotkin vede una correlazione strettissima tra la pratica del mutuo appoggio e la tendenza associativa, nel senso che queste forme sono aspetti di un'unica realtà: quella della vita in generale. La vita animale è di per se stessa eminentemente sociale. Ugualmente, la vita umana risponde alla medesima tendenza. Poiché non esiste soluzione di continuità tra il regno animale e quello umano, ne deriva che in quest'ultimo l'associazione assume funzioni simili. A suo giudizio perciò occorre indagare quelle leggi comuni che governano entrambi questi universi e che costituiscono la trama universale della vita presa nella sua interezza. In questo senso (siamo al punto decisivo) la teoria kropotkiniana, che paradossalmente ha vaghe reminiscenze romantiche (l'unità della natura), vuole essere una concezione universale capace di andare oltre la specificità del mondo storico. Essa non analizza separatamente i contenuti dell'azione umana, siano essi politici, economici, culturali, religiosi. Nemmeno ne indaga l'intreccio considerato di per se stesso. Non è quindi una concezione economicistica o politica o genericamente etico-antropologica. Essa vuole essere molto di più: una concezione biologica, una teoria onnicomprensiva dell'essere vivente. Da questo punto di vista, è perfettamente equidistante da quella di Marx come da quella di Bakunin (ma anche, ad esempio, da quella di Godwin). Bisogna tener presente questa fondamentale premessa per capire il senso della filosofia kropotkiniana della storia. Debitrice dell'evoluzionismo, essa afferma l'esperienza comune dell'umanità, nel senso che, poste alcune condizioni generali, le necessità della vita sono sostanzialmente le stesse, per cui ne consegue che nel corso del tempo gli uomini finiscono per percorrere canali pressoché uniformi. Di conseguenza, il fatto che l'analogia di un particolare stadio rispetto a un altro derivi da imitazione o da invenzione indipendente, che sia convergente o parallela, multilineare o unilineare non può intaccare il carattere unico dell'umanità, anche se questa si presenta sotto forme storico-culturali assai diversificate. La storia dell'uomo non ha fondazione autonoma, creatrice di proprie forme e di proprie leggi, perché è una variabile della più grande storia della natura, come questa, a sua volta, non è altro che l'espressione dinamica della vita intesa nel senso universale del termine. Le leggi di questa si impongono alle vicende degli uomini e perciò, da questo punto di vista, la lotta tra libertà e autorità, tra uguaglianza e disuguaglianza si delinea quale momento di una continua opposizione trasversale tale da determinare tutti i possibili comportamenti storici. Ne consegue che nel pensiero kropotkiniano non c'è un concetto di lotta sociale inteso quale lotta di classe, appunto perché il conflitto non è precipuo di una specifica situazione spazio-temporale, in quanto scaturisce da una contrapposizione universale: il mutuo appoggio e la lotta sono momenti che attraversano tutta la storia dell'uomo perché sono insiti nelle leggi della vita; anzi, sono la vita stessa intesa sul piano storico-umano. A questo punto è lecito domandarsi: come è possibile giungere a una condizione di bene universale propulsivo alla nascita della società anarchica? Come si può interrompere l'avvicendamento continuo di lotta e solidarietà, facendo inclinare la bilancia dalla parte del mutuo appoggio? La risposta kropotkiniana si fonda innanzitutto sulla constatazione del rapporto necessitante tra evoluzione determinata e le modalità spontanee di questo stesso procedere. A partire da questa relazione fra necessità e spontaneità deve essere elaborata un'etica capace di riportare la vita degli uomini alla loro originaria autenticità antropologica. Si scoprirà la forma intrinsecamente solidaristica della vita associata, che risulta tanto più forte quanto è maggiore il grado di sedimentazione evolutiva precedente. Va qui sottolineato che per Kropotkin la socievolezza non è una scelta dei protagonisti, ma una necessità della specie, non discende dalla volontà dei singoli, ma dalla loro appartenenza alla collettività. E la società, a sua volta, è il risultato dell'evoluzione spontanea della natura perché deriva da un lento, ma irreversibile sviluppo delle potenzialità libertarie ed egualitarie latenti negli esseri viventi, per cui soltanto la piena coscienza scientifica di questa tendenza naturale trasforma la sua datità deterministica in una possibilità progettuale di liberazione: gli individui si liberano solo attraverso il pieno riconoscimento della loro inscindibile appartenenza alla specie e dunque della loro ineliminabile dimensione collettiva.
Responsabilità individuale
Con tali premesse profondamente deterministiche, Kropotkin tenta di risolvere il problema chiave dell'etica: la responsabilità individuale derivante dall'implicito corollario del libero arbitrio. Si tratta di una questione ardua, che non sembra trovare una facile, rassicurante e univoca soluzione. Come si deve stabilire ciò che è bene e ciò che è male per definire socialmente un'approvazione o una condanna? Come risolvere il classico dilemma della morale, vale a dire il problema del libero arbitrio? Gli uomini hanno l'autonoma capacità e responsabilità di fare il bene e il male? E cosa sono, sotto il profilo ontologico, il bene e il male? La risposta di Kropotkin a questo proposito è chiara: l'idea del bene e del male non ha nulla a che vedere con la religione o con la coscienza misteriosa: è un bisogno naturale delle razze animali. E quando i fondatori delle religioni, i filosofi e i moralisti ci parlano di entità divine e metafisiche, non fanno che ripetere ciò che ogni formica e ogni passero praticano nelle loro società. è questa cosa utile alla società? Allora è buona. È nociva? E allora è cattiva. Il che significa direche l'etica ha una valenza solo sociale e che le motivazioni e gli impulsi dell'azione umana sono ontologicamente insignificanti, visto che vengono dettati comunque da un insopprimibile e oggettivo bisogno naturale. In ultima analisi, ciò che conta è il risultato effettivo e concreto dell'agire, l'esito, per l'appunto, sociale dell'azione. Il senso ideologico profondo dell'interpretazione kropotkiniana dell'etica risiede, in ultima analisi, nella ricerca di una sua progressiva delineazione immanentistica, definibile in chiave materialistica e realistica perché essa vuole prescindere da ogni elaborazione religiosa, mistica e, più in generale, idealistica. La radice oggettiva e radicale di tale immanenza consiste nel rapporto intrinseco e necessitante tra etica e società, tra le forme dell'agire e le determinazioni contestuali, dato che l'etica è l'insieme delle norme senza le quali gli uomini non possono vivere in comune. La società anarchica delineata da Kropotkin non vuole essere la rappresentazione di una realtà statica, uniforme e conchiusa, di una realtà totalmente altra rispetto al presente, ma la raffigurazione complessa delle sue possibilità latenti, dispiegate in tutta la loro multiforme e inesauribile ricchezza. Essa respinge con forza l'idea di una costruzione sociale come una realtà inventata ex novo, come un'espressione di pura desiderabilità intellettuale. Piuttosto vuole configurarsi come un universo pluralistico continuamente componibile e scomponibile secondo le scadenze imposte da un divenire incessante ed emergente e perciò come una continua risposta alla sovrapposizione di realtà mutevoli; essa vuole essere insomma il risultato necessario e libero dell'aumento continuo dei bisogni dell'uomo civilizzato. In questo senso diventa logico modellare le istituzioni umane sui ritmi naturali della crescita sociale, immettendo nella creazione culturale delle forme continuamente adattabili e funzionali al senso spontaneo dello sviluppo collettivo. Una società che per principio fonda il rapporto tra i gruppi e gli individui su impegni reciproci, liberamente conclusi e sempre revocabili, come pure su usi e costumi bene accetti da tutti. Questi costumi, però, non devono essere pietrificati e cristallizzati dalla legge; ma conviene abbiano un'espansione continua, adattandosi ai bisogni nuovi, ai progressi del sapere e delle invenzioni, e al crescere di un ideale sociale sempre più razionale e sempre più elevato. La rete di questa comunità si compone di un'infinita varietà di associazioni federate di tutte le dimensioni e gradi. Come nella vita organica, l'armonia risulterebbe dall'assestamento e riassestamento, dall'equilibrio continuo di forze e di influenze diverse secondo una radicale insorgenza dal basso, una irreversibile immanenza del sociale che deve rendere impossibile ogni costruzione politica imposta dall'alto. Di qui comuni indipendenti per gli aggruppamenti territoriali, vaste federazioni di mestieri per gli aggruppamenti di funzioni sociali e aggruppamenti di affinità personali, varianti all'infinito, di lunga durata o effimeri, creati a seconda dei bisogni del momento per tutti gli scopi possibili. Per Kropotkin la libertà e l'uguaglianza non sono costruzioni culturali che modificano le tendenze naturali, ma sono espressioni funzionali di queste tendenze. Un piano della libertà e dell'uguaglianza deve esplicarsi, secondo l'anarchico russo, attraverso due aspetti complementari: l'integrazione in ogni individuo del lavoro manuale con quello intellettuale, l'integrazione geografico-sociale della città con la campagna. I due aspetti sono complementari perché mirano al superamento di due forme dello stesso fenomeno del dominio, concepito secondo il più classico schema anarchico, vale a dire quale rapporto che va dall'alto al basso, dal centro alla periferia, dal punto più alto della piramide alla linea più bassa della base. Di qui l'analogia formale: come il lavoro intellettuale è dominante rispetto a quello manuale, così la posizione della città è dominante rispetto a quella della campagna: non si può integrare l'uno senza integrare l'altra. Il significato profondo di questa duplice e organica integrazione è dato dalla sua valenza armonica, dalla capacità di unire i valori anarchici della libertà e dell'uguaglianza con l'efficienza tecnico-scientifica ed economica-sociale. Ancora una volta, la norma del dover essere si coniuga con la constatazione dell'oggettività necessitante della sua utilità pratica. Ne deriva, in questo caso, l'idea del perseguimento dell'uomo completo. Come Bakunin, Kropotkin ritiene che il superamento della divisione gerarchica del lavoro sia la via maestra per l'abolizione delle classi. L'integrazione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, fra industria e agricoltura, fra città e campagna non risponde soltanto a un problema economico, ma dà pure corso a un'esigenza più profonda: quella di esprimere in senso culturale ciò che è intrinseco in senso naturale. Attraverso la concezione geografico-sociale, l'utopia kropotkiniana fa ritornare il duplice e reversibile passaggio dalla natura alla storia e dalla storia alla natura.
Volontà ed etica
Errico Malatesta (1853-1932) è l'ultimo pensatore "classico" della storia dell'anarchismo. Egli appare come un "sintetizzatore" che, alla luce dell'esperienza storica, sistematizza la dottrina al fine di tramutarla da verbo ad azione. Tuttavia, in questo sforzo teorico, Malatesta va molto al di là di una semplice sintesi perché tenta di conferire all'anarchismo un respiro universale libero da ogni ipoteca dottrinaria. Per arrivare a questo traguardo Malatesta ha diviso l'anarchia (il fine) dall'anarchismo (il mezzo). I fini dell'anarchia sono stati separati dalla sua scienza analitica per dimostrare che la validità universale dell'idea anarchica non è condizionata dalla comprensione e dalla considerazione storica del presente, per cui, una volta individuate le tendenze e i significati di queste forze, il futuro si dia come complessiva deduzione del passato. Svincolando e autonomizzando i fini anarchici da qualunque deduzione che voglia essere necessitante, univoca e definitiva con il presente, si afferma che la deduzione stessa è già implicita nelle cose, che sempre ci sarà il modo più adeguato per esplicitarla finché tali cose non si risolveranno nell'ordine futuro. In altri termini, poiché l'analisi muta con la diversità del contesto, è inutile e dannoso far dipendere gli scopi dell'anarchia da questo mutamento. Essi non possono essere dedotti da un presente in continua trasformazione, né possono essere ricavati da una sua pura negazione. La validità storica dell'idea anarchica, invece, discende dall'universalità dei suoi valori propositivi. Infatti, per darle un fondamento veramente universale bisogna riflettere su ciò che la motiva. Si vedrà così che la motivazione, o l'insieme delle motivazioni che la sostanziano, non sono dovute a una deduzione, ma rispondono a un'aspirazione. I suoi scopi sono tutti costituiti da valori, che trascendono ogni contingenza storica e ogni particolarismo sociale. Ne viene, del tutto logicamente, che l'anarchia non è fondata su un essere, ma su un voler essere: in questo modo essa ha un respiro universale. La grande divisione epistemologica fra anarchia e anarchismo è la divisione fra giudizi di fatto e giudizi di valore, fra scienza ed etica. L'anarchia, infatti, è un'aspirazione umana, che non è fondata sopra nessuna vera o supposta necessità naturale, e che potrà realizzarsi secondo la volontà umana. Questa "aspirazione umana" si pone oltre ogni valenza razionale e teoretica. Detto in altri termini, l'anarchismo è prima di tutto un'etica che va al di là di ogni spiegazione razionale perché è nato dalla rivolta morale contro le ingiustizie sociali. In quanto aspirazione umana verso la libertà universale, si pone oltre la necessità naturale, come ogni altra necessità storica o scientifica. L'anarchia infatti è una costruzione culturale e il concetto di libertà ne è la massima espressione, nel senso che testimonia la valenza tutta precaria e volontaria di tale conquista. Al centro della teoria dell'azione malatestiana vi è il problema della rivoluzione, considerata un passaggio pressoché obbligato per giungere a una condizione generale di libertà per tutti, anche se non ancora all'anarchia. La rivoluzione è giudicata obbligatoria per il rapporto di forza esistente nella società. Le classi privilegiate non permetteranno di farsi spodestare dai loro privilegi, se non con un'azione violenta da parte dei subordinati. Poiché la rivoluzione non può essere evitata, è necessario che essa sia il più possibile l'esito di una volontà cosciente e non il mero prodotto di circostanze storiche. Dunque, prima di tutto la rivoluzione, la quale deve sbarazzare il campo dagli ostacolo materiali che impediscono il libero dispiegarsi della volontà popolare emancipatrice. La rivoluzione è sempre produttrice di due forze contraddittorie: la prima è quella creatrice della distruzione del vecchio potere, la seconda è quella restauratrice del nuovo dominio. L'anarchismo può solo legarsi alla prima di queste due fasi. Del resto non potrebbe essere diversamente. Analogamente a tutti gli anarchici, Malatesta intende la rivoluzione come liberazione della prima fase, il cui svolgimento non può avere un progetto univoco. Il binomio volontà-rivoluzione non deve assolutamente essere inteso come volontà di imposizione o come volontà di purificazione palingenetica. Da quanto detto sin qui, si può notare come per Malatesta l'azione rivoluzionaria si divida in due tempi. Il primo è quello della distruzione violenta delle condizioni materiali che non permettono una libera evoluzione umana; il secondo è l'esplicazione di questa evoluzione, che esige la più ampia libertà per tutti di sperimentare varie forme sociali e che, pertanto, non può essere condotta con metodi coercitivi. Essa può solo costituire il momento del pacifico confronto delle varie idee di ricostruzione della società. A questo punto si deve ricavare l'inequivocabile considerazione che Malatesta finisca, suo malgrado, col mettere in luce la mancanza di una scienza politica anarchica. Essa deriva dal fatto che gli anarchici non hanno la forza sufficiente per perseguire i propri scopi, né la volontà (anche qualora la situazione fosse diversa) di imporre qualcosa. Così, se gli anarchici non vogliono e non possono imporre coattivamente le loro idee, e ritengono che nemmeno gli altri abbiano il diritto di farlo, si arriva, del tutto logicamente, a una situazione dettata solo dai rapporti di forza. Se a questo punto si tiene conto che l'anarchismo è una delle forze agenti nella società e che la storia camminerà, come sempre, secondo la risultante delle forze, ne deriva ovviamente la necessità di un'azione di forza e dunque il problema dell'uso della violenza. Si apre così una serie di questioni contraddittorie. Infatti, se l'anarchia vuol dire per principio non-violenza, non-dominio dell'uomo sull'uomo, non-imposizione per forza di uno o di più su quella degli altri, come va usato il mezzo della violenza senza farsi sopraffare dalla sua logica? Dove inizia e dove finisce la sua necessità? E chi ha il diritto di usarlo?
Il problema della violenza
Date queste incongruenze, Malatesta non poteva che considerare la violenza rivoluzionaria una dura necessità per evitare, appunto, di scambiare il mezzo col fine. L'azione anarchica, quindi, deve contemplare la violenza come necessità di liberazione dalla violenza dei governi e dei padroni, non per edificare l'anarchia. La necessità della violenza, pertanto, si giustifica come extrema ratio, quasi come riluttante considerazione dell'impossibilità di fare altrimenti. La ricerca continua della coerenza tra mezzi e fini, per evitare il "paradosso delle conseguenze", porta Malatesta al rifiuto sistematico di ogni forma di coazione dell'atto sovversivo e dunque alla critica di tutte le forme ideologiche di tale terrorismo. Il rifiuto malatestiano è di principio e di metodo. La difesa della rivoluzione non può essere attuata che con quei mezzi che sono in coerenza con gli scopi della rivoluzione medesima. Date tali premesse di principio e di metodo, è logico che Malatesta sia radicalmente contrario alla dittatura rivoluzionaria. Poiché vuole essere il risultato riassuntivo della rivoluzione, e perciò rappresentare la somma di tutti i poteri storicamente dati in quel momento, essa esprime un potere totalitario, la cui mistificazione ideologica suprema è data dalla formula marxista della dittatura del proletariato. Se la storia non ha un fine, è ovvio che l'esito della lotta dipenda dal rapporto di forze in campo, ma questo, a sua volta, è determinato dall'energia interna delle forze stesse. Poiché l'obiettivo degli anarchici consiste in una rivoluzione radicale in grado di spazzar via ogni forma di privilegio e di ingiustizia, è necessario a questo proposito avere presente la scarsa possibilità che le grandi masse popolari seguano i rivoluzionari su questo terreno di scelta totale. E ciò perché le masse seguono i loro interessi materiali, che, di per sé, ai fini della trasformazione sociale, non sono portatori di nulla.
Movimento politico e movimento economico
Applicando la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore, Malatesta si schiera a favore di una sostanziale divisione fra movimento politico e movimento economico. Il movimento politico persegue fini universali (la sua valenza è rivoluzionaria perché le sue motivazioni sono ideali); il movimento economico persegue fini particolari (la sua valenza è riformista perché "l'interesse è conservatore"). Questa divisione è a sua volta conseguenza della distinzione tra movimento operaio e dottrina sindacale. Si tratta soltanto di constatare la sua importanza storica, senza caricarla di significati metafisici, come fanno invece i sindacalisti puri o rivoluzionari. è necessario che l'organizzazione sindacale rifletta tale giudizio di fatto, delineandosi, per l'appunto, come un semplice fatto, cioè mantenendo la sua intrinseca e naturale non intenzionalità ideologica. E ciò perché il sindacato, essendo portatore di interessi particolari, è per sua natura corporativo; non si può dunque caricarlo di un compito (la rivoluzione sociale) che non saprebbe comunque assolvere. è necessario quindi che non subisca divisioni ideologiche al proprio interno, mantenendosi sul terreno esplicito della sua natura di parte. Il movimento anarchico deve rimanere un movimento specifico perché la sua peculiarità è indispensabile al mantenimento degli scopi dell'anarchismo, mentre gli anarchici possono (anzi, devono) rapportarsi alle organizzazioni del movimento operaio e popolare. Essi costituiscono la presenza politica dell'emancipazione umana nell'azione storica dell'emancipazione popolare. La mutevolezza, gli avanzamenti e gli arretramenti del movimento operaio non devono compromettere l'azione rivoluzionaria dell'anarchismo perché questo, pur coniugandosi con tutte le vicissitudini storiche popolari, ha il compito di mantenere e ribadire incessantemente il valore della liberazione integrale. Il movimento anarchico non si costituisce in avanguardia rivoluzionaria dell'azione economica delle classi inferiori, ma in irriducibile presenza rivoluzionaria dell'emancipazione universale entro tale azione. Così il perseguimento specifico dei fini anarchici non fa violenza al livello storico raggiunto dalle classi popolari. Lo stesso discorso relativo alla distinzione fra anarchismo e anarchia, fra giudizi di fatto e giudizi di valore, è applicato anche alla composizione delle forze all'interno del movimento anarchico specifico. Malatesta era favorevole all'organizzazione economica comunista della società, riassunta nella nota formula "ognuno dà secondo le proprie forze e riceve secondo i propri bisogni". Ma ciò non gli ha mai impedito di ribadire la relatività e la contingenza di questa stessa concezione perché, come tutte le teorie e le ipotesi, essa poteva avere valore solo qualora fosse stata sottoposta al vaglio dell'esperienza concreta. Il pluralismo, la radicale convinzione della relatività di ogni tendenza, la consapevolezza del rapporto tutto libertario ed egualitario fra proposte e loro conferma pratica, rendono la concezione economica malatestiana equilibrata, complessa e multiforme, autenticamente anarchica. Ogni idea e ogni proposta devono essere confermate dai fatti. E ulteriormente viene precisato: "Noi anarchici siamo comunisti perché pensiamo che il comunismo è mezzo alla libertà. In tutti i casi, il comunismo imposto provocherebbe la reazione e la domanda sociale e politica di un ritorno al passato". La sottovalutazione delle varie dottrine e tendenze è l'indice più evidente della riflessione malatestiana rivolta al decantamento storico dell'anarchismo come puro anarchismo, cioè come anarchismo ridotto a etica. A questo proposito è necessario considerare un paradigma decisivo: il confronto fra anarchia e democrazia, che allude a quello più profondo fra etica e politica. Tale comparazione, infatti, è significativa perché implica la considerazione del "male minore". Ci si deve domandare, in altri termini, se per Malatesta la democrazia va equiparata a qualsiasi regime politico o non valutata, invece, quale scelta del meno peggio. A suo giudizio gli anarchici riconoscono e valutano le differenze esistenti, fino al punto di augurarsi che accadano alcune cose piuttosto che altre, ma non devono compromettere la loro identità e il loro patrimonio ideologico per nessuna ragione. Insomma, essi non fanno nulla perché avvengano determinati fatti o, se lo fanno, è a patto che essi non mettano a repentaglio le loro idee e ciò che queste rappresentano. Vale a dire: le oggettive situazioni storico-politiche devono sempre stare al di sotto delle soggettive intenzioni etico-ideologiche. Poiché la storia di per sé non conduce a nulla, è evidente la necessità di salvaguardare la volontà anarchica, la quale non si affida ad alcuna circostanza, men che meno quando questa può mettere in pericolo i fini ultimi dell'agire. Dunque per Malatesta non si dà agire politico staccato da quello etico, con la conseguenza che, dal punto di vista dell'azione anarchica, il problema del "male minore" è un falso problema. Gli anarchici non devono agire per migliorare le circostanze per quello che esse sono, ma per avanzare nella via diretta delle proprie rivendicazioni. L'intenzionalità anarchica non contempla la considerazione politica del "meno peggio", essendo convinta, tra l'altro, che questo si possa ottenere solo chiedendo il massimo. In conclusione, l'azione anarchica è integralmente rivoluzionaria perché irrimediabilmente etica. La considerazione del "male minore" investe quindi anche la democrazia per quel tanto che questa costituisce un'effettiva diversità rispetto ad altre forme politiche, ma non perché essa sia comparabile all'azione rivoluzionaria, che non può essere incrinata da alcuna circostanza storica. Ne deriva che, sempre, l'assolutezza etica supera la relatività politica. In senso weberiano si potrebbe dire che Malatesta non è pervaso dall'etica della responsabilità, ma dall'etica della convinzione, che si esprime nel sistematico rifiuto di ogni forma di storicismo e di ogni giustificazionismo dell'esistente. In conclusione, la diversità radicale tra anarchismo e democrazia consiste nel principio informatore che presiede ai due rispettivi modelli di società. La differenza sostanziale è questa: autorità o libertà, coazione o consenso, obbligatorietà o volontarietà. è su questa questione fondamentale del supremo principio regolatore dei rapporti inter-umani che bisogna intendersi. Tuttavia Malatesta non va oltre questa fondamentale osservazione perché persiste nel contrapporre al principio politico dell'autorità quello etico della libertà: l'errore è epistemologico, dal momento che le due entità non sono confrontabili in quanto ontologicamente diverse. Ma esiste veramente, per Malatesta, una verità anarchica? La risposta, ovviamente, è no: la verità anarchica altro non è che il criterio anarchico di definizione della libertà, mentre, a sua volta, la libertà non rimanda alla verità tout-court. Quindi, la verità anarchica consiste nella piena consapevolezza che l'universale libertà impedisce un'univoca verità. Libertà dell'errore, vale a dire libertà come concetto laico di verità e quindi come possibilità, per tutti, di dar seguito alle proprie idee purché non limitino la realizzabilità di quelle altrui. Il rapporto ontologico tra libertà e verità fa dunque da supporto alla relazione politica tra libertà e anarchia. La libertà, in prima istanza, non ha nome perché nessuno ha la verità: tutti, pertanto, hanno il diritto di essere liberi, di non conformarsi alle decisioni altrui. Ma l'universalità della libertà non si può dare, se non si offre a ogni individuo la possibilità reale di accedere alle fonti materiali della vita. Ecco perché la libertà effettiva implica una società di uomini liberi e solidali, il che può avvenire solo laddove è stato distrutto il sistema di accaparramento monopolistico dei mezzi di produzione. Il concetto centrale dell'anarchismo, considerato come mezzo all'anarchia, è questo: il libero accordo sostituito alla violenza, la volontarietà contro l'obbligatorietà. La sua idea fondamentale è appunto l'eliminazione della violenza nei rapporti sociali. Infatti anarchia vuol dire non-violenza, non-dominio dell'uomo sull'uomo, non-imposizione per forza di uno o di più su quella degli altri. è solo mediante l'armonizzazione degl'interessi, la cooperazione volontaria, l'amore, il rispetto, la reciproca tolleranza, è solo con la persuasione, l'esempio e il vantaggio mutuo della benevolenza che può e deve trionfare l'anarchia, cioè una società di fratelli liberamente solidali, che assicuri a tutti la massima libertà, il massimo sviluppo, il massimo benessere possibili. Dall'insieme di tutte queste affermazioni si vede in modo netto come la relazione politica tra libertà e anarchia, che intende superare il problema centrale della sovranità posto dalla democrazia, consista nella delineazione di una società fondata sul libero consenso di tutti i suoi membri, al punto che si può dire che "l'anarchia ci sarà per tutti quando tutti saranno anarchici". Essa, inevitabilmente, implica l'universalizzazione di un'etica volontaria, la quale, per sua stessa natura, non può in alcun modo essere il frutto di un sistema predeterminato. In altri termini Malatesta, più di qualsiasi altro anarchico, rende palese l'irriducibile natura volontaria della libertà quale nucleo profondo dell'anarchia, visto che la relazione tra questa e quella consiste nel rapporto non necessitante tra atto e potenza. L'anarchia prefigura una società meta-politica perché il superamento del criterio della coercizione non è l'esito di una qualche scoperta scientifica o storica sulla natura umana, ma è più semplicemente il risultato della libera volontà degli uomini. Essi, se lo vorranno, saranno liberi, altrimenti no. Ma la libertà annullata dall'amore implica che nella società anarchica l'etica stabilisca i limiti della libertà del soggetto. Quali siano le forme concrete in cui potrà realizzarsi questo trionfo della libertà e dell'amore nessuno potrebbe dirlo con esattezza perché non vi sono formule magiche capaci di risolvere le difficoltà né dottrine universali e infallibili applicabili a tutti gli uomini e a tutti i casi. Nessuno, soprattutto, essendo anarchico, potrebbe pensare di imporre agli altri la forma che gli appare migliore. Ancora una volta, l'unico modo per arrivare alla scoperta del meglio è la libertà. Insomma, nella società anarchica si configura una libertà storicamente determinata, che però, per la sua stessa natura, non può essere preventivamente descritta nei suoi termini concreti, se non in senso negativo: abolizione di ogni impedimento materiale alla realizzazione universale della libertà mediante l'uguaglianza.
Mezzi e fini
La libertà concepita dagli anarchici, configuratasi in un Programma anarchico, non è dunque una libertà generica e illimitata. Prevede il principio dell'uguaglianza e della solidarietà, che a loro volta contemplano l'esistenza di una "morale superiore". "Il trionfo della libertà e dell'amore" è il trionfo di una determinata libertà e di un determinato amore che, certo, nelle intenzioni di Malatesta, si delineano come il massimo di libertà e di amore concepibili entro il quadro istituzionale di una società "organizzata senza autorità". Se si vuole mantenere ferma l'istanza suprema dell'abolizione del principio dell'autorità, è necessario che l'istanza opposta, quella della libertà, si conformi secondo le modalità sopra delineate. È necessario sia dal punto di vista razionale, sia dal punto di vista morale. In questo caso, il concepimento di una determinata libertà spinge l'etica e la scienza a coincidere, non però nel senso di una loro auspicabile coniugazione, ma nel senso della constatazione di un loro ineluttabile accostamento dovuto all'integrazione organica della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. Poiché questa organicità rappresenta l'anarchia al suo massimo grado, alla sua più compiuta realizzazione, se ne dovrebbe dedurre che anche la società anarchica è una società organica, una società "non aperta". Deduzione errata, perché Malatesta mantiene contemporaneamente fermo il rapporto metodologico tra anarchia e anarchismo che delinea la distanza pressoché incolmabile tra l'ideale che potrebbe anche non realizzarsi mai, così come non si raggiunge mai la linea nell'orizzonte, e il metodo di vita e di lotta degli anarchici. Tra il fine (l'anarchia) e il metodo (l'anarchismo) vi è di mezzo il metodo stesso. Il rapporto metodologico diventa infatti un rapporto ontologico, visto che è sostanziato da quel concetto di libertà senza nome che a sua volta si dà in un'universalizzazione laica: libertà per tutti, libertà per ciascuno purché non violi l'eguale libertà degli altri solo mezzo per arrivare al vero e al meglio. E non vi è libertà, se non vi è libertà dell'errore. Per arrivare all'anarchia bisogna passare attraverso la libertà che, certamente, viene dopo la rivoluzione (cioè a seguito di un'azione pur sempre coercitiva), ma viene comunque prima della società anarchica
venerdì 28 dicembre 2007
Le radici dell'Anarchia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
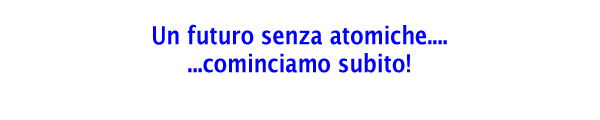





































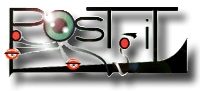
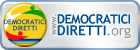
















Nessun commento:
Posta un commento