La proprietà non è un diritto naturale
di LuigiCorvaglia
II parte
Figli del secolo dei lumi, liberalismo, socialismo ed anarchismo sono fratelli bastardi. Sono infatti nati dalla assidua frequentazione della dea Ragione con gli elementi della triade rivoluzionaria “Libertà, Eguaglianza e Fraternità”. E’ la secolarizzazione, infatti, che permette di ripensare l’idea dell’ordine immutabile delle cose, è la caduta dell’ancien regime che dà vigore alla cognizione che l’arrangiamento degli individui possa essere costruito dagli uomini secondo principi liberamente scelti e non imposti. I tre elementi che furono il motto del 1789, però, sono in equilibrio instabile. Questo perché l’ordine lessicale, per utilizzare la definizione che sarà di John Rawls, cioè la graduatoria della loro prescindibilità in un ideale “gioco della torre”, può essere molto diverso. Il socialismo ha privilegiato l’eguaglianza, anche a costo di rimetterci in libertà, qualora fosse costretto ad una scelta. Il liberalismo, invece, presenta un ordinamento inverso, premettendo la libertà individuale ad ogni altro fine, inclusa quindi l’eguaglianza. La fratellanza, terzo elemento della triade, risulta in un compendio delle prime due e non può darsi senza una composizione, un equilibrio. Bene, l’anarchismo mira a dare pari dignità alla diade libertà-uguaglianza. Michail Bakunin scrisse: “ la libertà senza il socialismo porta al privilegio, all’ingiustizia; e il socialismo senza libertà porta alla schiavitù e alla brutalità”. Bisogna ammettere che fra tante profezie politiche e “sol dell’avvenire” di cui XIX e XX secolo sono stati infestati, l’unica ad essersi inverata è questa del rivoluzionario russo. In realtà, però, anche l’anarchismo ha spesso sofferto di sbandamenti verso l’uno o l’altro polo. Lo stesso Bakunin, ad esempio, ha teorizzato un collettivismo che è l’ultima fermata del treno libertario prima del capolinea anarco-comunista di Kropotkin. Inverso il discorso per l’individualismo americano di Warren, Tucker e Spooner, teorici di un “liberalismo” radicale. Solo Proudhon, fra i giganti del dell’anarchismo classico, sembra riuscire nel difficile compito di mantenere un equilibrio, instabile come ogni cosa viva, fra i due estremi (e in ciò è, probabilmente, da ricercare il motivo delle accuse provenienti dai contrapposti fronti di situarsi nella trincea opposta). Ciononostante, non trova spazio nella teorizzazione del tipografo di Becancon alcuna utopica idea di fine della storia, alcun sogno di composizione totale della frattura fra le antinomie. L’esperienza umana, egli ci ricorda, è intessuta di contraddizioni e l’idea di una soluzione unica e definitiva che porti alla stasi, cioè alla morte, ciò che è vivo e dinamico non può che risolversi in un fallimento o nell’arbitrio del potere. Questo è forse il motivo dello scarso appeal che questo pensatore ha presso gli apostoli della palingenesi insurrezionalista. Lasciamo la parola allo stesso Proudhon:
I poli opposti di una pila elettrica non si distruggono. Il problema consiste nel trovare non la loro fusione, che sarebbe la loro morte, ma il loro equilibrio incessantemente instabile, variabile a seconda dello sviluppo della società.
(da Teoria della proprietà)
(da Teoria della proprietà)
La stessa uguaglianza, per Proudhon, è ben lontana dal risolversi nella piattezza del livellamento che soffochi le individualità, “non è affatto una condizione fissa, ma la media algebrica di una situazione sempre mobile”.
Le antinomie sono irrisolvibili. Inclusa quella fra libertà ed uguaglianza. E allora? Allora, il terzo elemento della triade, la fratellanza non può che risolversi in un dinamico sistema che, accogliendo l’uno e l’altro elemento della diade, sia radicato nella Giustizia:
Le antinomie sono irrisolvibili. Inclusa quella fra libertà ed uguaglianza. E allora? Allora, il terzo elemento della triade, la fratellanza non può che risolversi in un dinamico sistema che, accogliendo l’uno e l’altro elemento della diade, sia radicato nella Giustizia:
Scartate l’ipotesi comunista e l’ipotesi individualistica, la prima in quanto distruttrice della personalità, la seconda in quanto chimerica, non resta da prenderne in esame che un’ultima sulla quale del resto la moltitudine dei popoli e la maggioranza dei legislatori sono d’accordo: quella della giustizia. (da La Giustizia nella rivoluzione e nella Chiesa)
Ecco. Giustizia. Questo concetto è fondamentale in Proudhon e l’accezione nella quale egli la considera merita una spiegazione. Proudhon è giusnaturalista. Egli, cioè, è convinto dell’esistenza di indiscutibili norme di diritto naturale. Così il suo concetto di giustizia, come è stato criticamente notato, è quello di un dato immanente e quasi metafisico da scoprirsi con l’uso della Ragione, non da costruirsi storicamente. Ciò ne fa, nel bene e nel male, un chiaro figlio del suo tempo. La giustizia è, la Giustizia, indipendentemente dalla legge, la quale può essere conforme o meno ad essa, è unica e data. Non, però, come qualcosa di esterno e superiore all’uomo, bensì di immanente (“è in noi come l’amore, come le nozioni del bello (…) La giustizia è umana, del tutto umana, nient’altro che umana”, ibidem). Bene, proprio illuminati da questo faro, tanto l’individualismo quanto il socialismo gettano ombre deformi che feriscono il senso del giusto. La cosa qui assume estrema importanza. Ciò perché il richiamo al “diritto naturale” è tradizionalmente la base delle teorizzazioni che, partendo dalla fonte di Locke e scendendo per li rami fino allo stagno di certo sedicente liberismo radicale, vedono la giustizia nel rispetto di diritti “auto-evidenti” quali la proprietà. Eppure, per Proudhon la proprietà è un furto. E’proprio il suo essere un giusnaturalista, quindi, che permette a Proudhon di scardinare la cassaforte ideale dei proprietari. Egli, cioè, si muove sullo stesso terreno di coloro che intende criticare, risultando pertanto particolarmente efficace nel marcare le contraddizioni nel discorso di chi, partendo dalle stesse premesse, intendeva – e intende – giustificare la proprietà quale diritto naturale. Vediamo come. Innanzitutto, egli nota che, presentandosi quale diritto “solo in potenza, come una facoltà inattiva e fuori servizio”, viene meno il criterio di universalità che caratterizza necessariamente i diritti naturali. Sarebbe grottesco affermare che “tutti gli uomini hanno un diritto eguale a proprietà ineguali”. I diritti, infatti, sono “inalienabili” per definizione e non suscettibili di crescite e diminuzioni. Soprattutto, però, avendo la Dichiarazione dei diritti individuato i quattro diritti imprescrittibili dell’uomo in quelli alla libertà, all’uguaglianza, alla sicurezza ed alla proprietà, Proudhon nota un elemento stonato in questo quartetto. Se realmente realizzati e rispettati, infatti, i diritti alla libertà, all’uguaglianza e alla sicurezza si completano a vicenda e portano alla concordia sociale. Armonizzano. Non funziona così per la proprietà. Scrive :
La libertà e la sicurezza del ricco non soffrono della libertà e della sicurezza del povero: anzi, possono rafforzarsi e sostenersi scambievolmente: al contrario, il diritto di proprietà del primo deve essere continuamente difeso contro l’istinto di proprietà del secondo. (…) Così il ricco ed il povero sono in uno stato di diffidenza e di guerra reciproca! Ma perché si combattono? Per la proprietà; dunque la proprietà comporta necessariamente la guerra alla proprietà!
(da Che cos’è la proprietà?)
(da Che cos’è la proprietà?)
Se, in altri termini, gli altri tre diritti portano all’avvicinamento, all’unione, alla socialità, la proprietà si palesa quale diritto antisociale, dotato di una forte carica disgregante. Non è quindi su tali basi che può considerarsi un diritto “naturale”. Su quali allora? I giusnaturalisti hanno ancora due carte, quella del “lavoro” e quella dell’ “occupazione”. Partiamo da quest’ultima. E’ idea ben nota agli anarcocapitalisti, che rivendicano il naturale diritto all’occupazione della “terra” – intesa latamente come qualunque mezzo di produzione che non sia già in mano ad altri. Qui Proudhon riprende un discorso di Cicerone:
Il teatro, dice Cicerone, è comune a tutti; e tuttavia il posto che ciascuno vi occupa è detto suo; nel senso che è da lui posseduto, non che è di sua proprietà. Questo paragone annienta la proprietà; esso implica inoltre l’eguaglianza. Posso forse in teatro occupare simultaneamente un posto in platea, un altro nei palchi ed un terzo in galleria? (…) Secondo questo paragone, ciascuno può sistemarsi come preferisce nel suo posto, può abbellirlo e migliorarlo: ma la sua attività non deve mai superare il limite che lo separa dagli altri”
(da Che cos’è la proprietà?)
In altri termini, se ogni uomo ha eguali diritti di lavorare e produrre, è ovvio che debba godere anche del diritto di occupare la terra, i mezzi di produzione. Da ciò non discende affatto la proprietà dei mezzi, ma solo il loro usufrutto. Ciò per un concetto tanto logico quanto semplice. Se nel teatro di Cicerone entrano altre cento persone, chi già vi si trovava ad usufruire degli spazi, si stringerà per far posto ai nuovi arrivati. Toglierà cappelli e cappotti dai sedili vicini, ad esempio. Ciò vuol dire che il diritto di occupazione è variabile. Insomma, “poiché la misura dell’occupazione dipende dalle condizioni variabili dello spazio e del numero, la proprietà non può costituirsi” (ibidem).
Ora i vari lettori che si imbattono nella definizione della libertà come furto non dovrebbero più incorrere nell’errore che fu anche di Marx e di Stirner, quello di cogliervi, secondo il noto luogo comune, una contraddizione (“come si può rubare se non c’è proprietà?”) . Il furto è nel fatto che chi si considera proprietario si appropria, sottraendolo definitivamente a tutti gli altri, di un bene a cui tutti hanno uguale diritto d’usufrutto.
Arriviamo ora all’argomento principe, il pilastro della teoria della proprietà. E’ quello del “lavoro”. L’idea lockiana del mescolamento del proprio lavoro alla terra fondandone la proprietà. Il proprietario ha migliorato la terra e ha creato il prodotto. “Ma chi ha creato la terra? Dio. In questo caso proprietario ritirati”, scrive Proudhon. Se è innegabile che chi produce qualcosa ha il diritto di possedere tale prodotto ( possesso), di certo non può vantare diritti sullo strumento che non ha creato (proprietà). “Il pescatore”, continua il francese, “che, sullo stesso litorale, è capace di prendere più pesci degli altri diventa forse, per questa sua abilità, proprietario dei paraggi della pesca?” (Che cos’è la proprietà?) .
Ebbene, a dimostrazione del fatto che la lettura di Proudhon non si limita alla mera e sterile ricerca dello storico, c’è proprio l’attualità della questione del lavoro che è da sempre uno degli ambiti più molli del fianco del liberismo estremo, ad esempio del cosiddetto “anarcocapitalismo”. Si è, infatti, molto discusso sulla vaghezza del concetto di lavoro. Sembra che a Murray Rothbard, principale teorico dell’anarcocapitalismo, basti il lavoro di recintare un terreno per renderlo di sua proprietà. In realtà, a voler seguire la lettera della teoria, questo lavoro potrebbe comportare al massimo la proprietà della sola striscia posta al di sotto della recinzione. Seguendo questo discorso, dando per scontato che nulla in una recinzione migliora un luogo, e che quindi la sola azione permetterebbe di sancire una proprietà, anche urinare in mare dovrebbe rendere padroni di un certo tratto di costa. Produrre onde radio rende padrone dell’atmosfera? Quelli che paiono giochetti logici ed elucubrazioni da ossessivi, invece, sono argomento di dibattito nel mondo dell’individualismo libertario che alcuni porrebbero a “destra” dello scenario politico. Comunque, pur presupponendo che sia possibile definire cosa sia lavoro e cosa no e perfino accettando che ogni lavoro comporti un miglioramento, cosa oggettivamente definisce il “miglioramento” nello stato della “terra” rispetto alla condizione precedente? Produrre onde radio migliora o peggiora l’atmosfera? Il miglioramento percepito da alcuni fruitori della “terra” in che modo comporta la necessaria accettazione della proprietà da parte di quanti gli usufruttuari che non ritengono che detto lavoro abbia comportato un miglioramento? Questi sofismi, pur nei loro tratti caricaturali, evidenziano la vaghezza dei criteri in merito. Come non bastasse, procedendo ancora ad un ragionamento per assurdo che dia per scontata la logica dell’appropriazione tramite il lavoro, il punto centrale che invalida l’idea “naturale” del diritto di proprietà frutto del lavoro è nella estrema contraddittorietà che si coglie ponendosi la domanda di cosa giustifichi la proprietà dei latifondisti o dei proprietari d’industria. Questi, ricorda Proudhon, posseggono enormi territori (o fabbriche manifatturiere) che non lavorano ma da cui ricavano delle rendite. Probabilmente essi hanno lavorato in passato e, quindi, acquisito il diritto alla proprietà di tali beni. Ma oggi? Il contadino salariato, il colono, l’operaio continua a lavorare quelle stesse terre, quegli stessi mezzi di produzione e ne trae dei prodotti. Eppure non ne acquisisce la proprietà. In base al principio per cui il lavoro fonda la proprietà, questi avrebbe diritto, non solo ai prodotti, ma anche ad una quota della terra. Ma ciò non avviene. Insomma, ciò che fu valido per alcuni, non può più essere valido per altri. Ciò è un controsenso. In definitiva, la proprietà, che l’autore distingue nettamente dal possesso, è il fatto economico attraverso il quale un oggetto nelle proprie disponibilità diventa creatore d’interessi. (l’intraducibile droit d’aubaine).
Non solo si ritrova in queste considerazioni il germe del concetto marxiano di “alienazione”, ma a Proudhon è da attribuirsi anche la paternità di quella teoria del “plus-valore”, generalmente considerata parto del pensatore tedesco. Il francese la esprime nei termini della forza collettiva:
Ora i vari lettori che si imbattono nella definizione della libertà come furto non dovrebbero più incorrere nell’errore che fu anche di Marx e di Stirner, quello di cogliervi, secondo il noto luogo comune, una contraddizione (“come si può rubare se non c’è proprietà?”) . Il furto è nel fatto che chi si considera proprietario si appropria, sottraendolo definitivamente a tutti gli altri, di un bene a cui tutti hanno uguale diritto d’usufrutto.
Arriviamo ora all’argomento principe, il pilastro della teoria della proprietà. E’ quello del “lavoro”. L’idea lockiana del mescolamento del proprio lavoro alla terra fondandone la proprietà. Il proprietario ha migliorato la terra e ha creato il prodotto. “Ma chi ha creato la terra? Dio. In questo caso proprietario ritirati”, scrive Proudhon. Se è innegabile che chi produce qualcosa ha il diritto di possedere tale prodotto ( possesso), di certo non può vantare diritti sullo strumento che non ha creato (proprietà). “Il pescatore”, continua il francese, “che, sullo stesso litorale, è capace di prendere più pesci degli altri diventa forse, per questa sua abilità, proprietario dei paraggi della pesca?” (Che cos’è la proprietà?) .
Ebbene, a dimostrazione del fatto che la lettura di Proudhon non si limita alla mera e sterile ricerca dello storico, c’è proprio l’attualità della questione del lavoro che è da sempre uno degli ambiti più molli del fianco del liberismo estremo, ad esempio del cosiddetto “anarcocapitalismo”. Si è, infatti, molto discusso sulla vaghezza del concetto di lavoro. Sembra che a Murray Rothbard, principale teorico dell’anarcocapitalismo, basti il lavoro di recintare un terreno per renderlo di sua proprietà. In realtà, a voler seguire la lettera della teoria, questo lavoro potrebbe comportare al massimo la proprietà della sola striscia posta al di sotto della recinzione. Seguendo questo discorso, dando per scontato che nulla in una recinzione migliora un luogo, e che quindi la sola azione permetterebbe di sancire una proprietà, anche urinare in mare dovrebbe rendere padroni di un certo tratto di costa. Produrre onde radio rende padrone dell’atmosfera? Quelli che paiono giochetti logici ed elucubrazioni da ossessivi, invece, sono argomento di dibattito nel mondo dell’individualismo libertario che alcuni porrebbero a “destra” dello scenario politico. Comunque, pur presupponendo che sia possibile definire cosa sia lavoro e cosa no e perfino accettando che ogni lavoro comporti un miglioramento, cosa oggettivamente definisce il “miglioramento” nello stato della “terra” rispetto alla condizione precedente? Produrre onde radio migliora o peggiora l’atmosfera? Il miglioramento percepito da alcuni fruitori della “terra” in che modo comporta la necessaria accettazione della proprietà da parte di quanti gli usufruttuari che non ritengono che detto lavoro abbia comportato un miglioramento? Questi sofismi, pur nei loro tratti caricaturali, evidenziano la vaghezza dei criteri in merito. Come non bastasse, procedendo ancora ad un ragionamento per assurdo che dia per scontata la logica dell’appropriazione tramite il lavoro, il punto centrale che invalida l’idea “naturale” del diritto di proprietà frutto del lavoro è nella estrema contraddittorietà che si coglie ponendosi la domanda di cosa giustifichi la proprietà dei latifondisti o dei proprietari d’industria. Questi, ricorda Proudhon, posseggono enormi territori (o fabbriche manifatturiere) che non lavorano ma da cui ricavano delle rendite. Probabilmente essi hanno lavorato in passato e, quindi, acquisito il diritto alla proprietà di tali beni. Ma oggi? Il contadino salariato, il colono, l’operaio continua a lavorare quelle stesse terre, quegli stessi mezzi di produzione e ne trae dei prodotti. Eppure non ne acquisisce la proprietà. In base al principio per cui il lavoro fonda la proprietà, questi avrebbe diritto, non solo ai prodotti, ma anche ad una quota della terra. Ma ciò non avviene. Insomma, ciò che fu valido per alcuni, non può più essere valido per altri. Ciò è un controsenso. In definitiva, la proprietà, che l’autore distingue nettamente dal possesso, è il fatto economico attraverso il quale un oggetto nelle proprie disponibilità diventa creatore d’interessi. (l’intraducibile droit d’aubaine).
Non solo si ritrova in queste considerazioni il germe del concetto marxiano di “alienazione”, ma a Proudhon è da attribuirsi anche la paternità di quella teoria del “plus-valore”, generalmente considerata parto del pensatore tedesco. Il francese la esprime nei termini della forza collettiva:
Duecento granatieri hanno alzato sulla base in qualche ora l’obelisco di Luxor; si suppone che un solo uomo, in duecento giorni, ne sarebbe venuto a capo? Tuttavia, per il conto del capitalista, la somma dei salari sarebbe stata la stessa.
(Che cos’è la proprietà?)
Il profitto del capitale è nella sproporzione fra le somme consegnate ai lavoratori per le loro singole forze e il prodotto collettivo creato, frutto di una forza collettiva non conteggiata ed intascata dal capitalista. Un furto, quello della forza collettiva, perpetrato sulla scorta del furto primordiale, la proprietà.
In conclusione, ci dice Proudhon,
La proprietà non esiste per se stessa; per prodursi, per agire, ha bisogno di una causa esterna, che è la forza (l’ocupazione) o la frode (far credere che dal lavoro discenda la proprietà).
La proprietà non esiste per se stessa; per prodursi, per agire, ha bisogno di una causa esterna, che è la forza (l’ocupazione) o la frode (far credere che dal lavoro discenda la proprietà).
(da Che cos’è la proprietà)
In realtà, ce ne sarebbe un’altra, ma nulla ha a che fare con i diritti naturali: è l’accordo. Ma questa è un’altra storia.
Continua.....
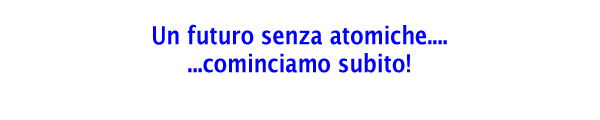






































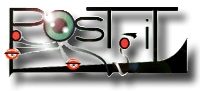
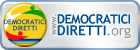
















3 commenti:
l'accordo in sé fa ridere, dato che io posso accordarmi su molte cose e, se non c'è un dato di fatto, ancora e come al solito, Berlucosconi uber alles!
Poi per quanto riguarda il mutualismo...adesso non posseggo la mia auto, non la uso, la mi auto non è più mia.
Come l'anarco capitalista crede di privatizzare tutto e di rendere la proprietà assoluta(cosa impossibile ed ingiusta) così il mutualista diventa invece un deficiente che nega l'evidenza delle cose.
Inoltre checché se ne dica, il paleo conservatorismo è l'unico libertarismo che permette ( se uito al resto dello sviluppo agorista) oltre che una ri-voluzione anche una stabilità teorica dato che unos tile di vita conservator-reazionario nel suo reale sviluppo determina progressi materiali più mirati e meno dispersivi-accumulativi.
Se i marxisti su una cosa avevano ragione è che l'accumulo di materialità determina coercizione dato che aumenta il vizio, e la strada del vizio è la strada del crimine.
Cos'è però il crimine? Ce lo dovrebbe speigare il signor Corvalgia dato che conta solo lo scambio...e di certo la Libertà.Mi sembra di rileggere tra le righe la teoria del Principio di Libertà del signor Renzo.
Si dimostri diamine anche questa!
Che se i Diritti naturali non hanno base, come può averla il Principio di Libertà?
I sentimentalismi qui spiegano più di quel che dovrebbero e potrebbero.
Se non si ha un oggettività in sé, cosa che scrivo ormai a "perdita" di tempo...neanche i diritti nautali sono diritti.
A me poco interessa.Max Stirner comunque ha ancora da insegnare a dei presuntuosi che credono sempre di aver trovato LA soluzione.
Ciao.
D.
ciao D, davvero interessante la tua ''critica'', sono d'accrdo sull'importanza che dai all'agorismo non lo sono invece per quanto riguarda il paleoconservatorismo, anzi, rimanendo in tema, che ne dici del manifesto sviluppato per maddaloni?
bah io vorrei essere un reazionario liberale.
Mi concedo i miei vizi alle volte ma non li osanno e né li condanno.
Ma so che sono vizi.
Una società votata al vizio è una società votata al comunismo.
http://astrolabio.splinder.com/post/20190335#comment
se non sei concervatore, con Lino Banfi ti scrivo...
"che me ne frega a me!"
eheeheh
Ciao!
p.s. sto link è riguardo una cosneguenzialità della critica.L'oggettività è...sarebbe semplice!
Posta un commento