
di Francesco Berti
Un recente libro di Furio Biagini analizza le relazioni tra pensiero ebraico e anarchismo. E ne sottolinea numerosi aspetti comuni.
Ne proponiamo qui una lettura critica.
Furio Biagini, docente di storia dell’ebraismo e di storia della filosofia ebraica all’Università del Salento, è autore di un volume il cui stesso titolo sembra, di primo acchito, un ossimoro: Torà e libertà. Studio sulle corrispondenze tra ebraismo ed anarchismo (Icaro, Lecce 2008, pp. 271, 12,00 euro). Da anni Biagini si dedica allo studio dell’ebraismo e delle sue connessioni con il movimento anarchico (1).
Non è da molto tempo, tuttavia, che si è cominciato a studiare le intersezioni tra ebraismo e anarchismo. Certo, si sapeva che molti appartenenti al popolo ebraico – un popolo vissuto per quasi 2000 anni, sia pure non per scelta, senza Stato, condizione che forse ha agevolato lo sviluppo di teorie critiche del potere politico in ambito ebraico – avevano aderito, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, all’anarchismo; si sapeva anche che alcuni di questi avevano avuto nel movimento un ruolo importante e riconosciuto – Emma Goldman, Alexander Berkman, Gustav Landauer, Bernard Lazare Vsevolod Mikhailovic Eichenbaum (Volin) – solo per citarne alcuni; si sapeva anche che alcuni tra i maggiori intellettuali del Novecento, ebrei di nascita e spesso anche di identità, erano stati vicini al movimento oppure avevano espresso, nelle loro opere, delle simpatie spiccatamente libertarie – Gershom Scholem, Martin Buber, Franz Kafka, Eric Fromm, Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Leo Löwenthal, Ernst Bloch; si sapeva, infine, che anche nel secondo dopoguerra molti ebrei avevano aderito alle idee anarchiche; tra di loro, alcuni intellettuali, artisti e scrittori di fama internazionale, come Paul Goodman, Julien Beck e Judith Malina, Murray Bookchin, Noam Chomsky.
Sebbene tutto ciò fosse relativamente conosciuto, non si era ritenuto, sino a qualche tempo fa, di farne l’oggetto di specifiche ricerche, anche perché l’incontro tra ebraismo e anarchismo era stato oscurato dall’adesione, ben più massiccia in termini quantitativi, di decine di migliaia di ebrei alle ideologie socialiste e marxiste. Il Convegno di studi tenuto a Venezia nel 2000, L’anarchico e l’ebreo. Storia di un incontro (da cui l’omonimo volume, curato da Amedeo Bertolo, Elèuthera, Milano 2001), ha certamente segnato un punto di svolta per lo sviluppo di queste ricerche, nelle quali si inseriscono anche i lavori di Biagini, la cui ultima fatica, però, si distingue dalla gran parte degli studi sinora pubblicati su questo argomento: riallacciandosi soprattutto alle ricerche di Gershom Scholem, Michael Löwy ed Arturo Schwarz (2), Biagini ha analizzato il fenomeno da una prospettiva diversa, cercando le corrispondenze tra il pensiero anarchico e l’ebraismo con esclusivo riferimento alla tradizione religiosa e storica del popolo ebraico.
In rivolta contro la religione dei padri
Che molti ebrei, tra Otto e Novecento, siano divenuti anarchici, non pare, in fondo, una cosa così singolare, soprattutto se si considerano la condizione di vita di centinaia di migliaia di ebrei negli shtetl alla fine del XIX secolo, le emigrazioni di massa di molti di questi ebrei dell’Europa orientale verso l’Inghilterra e le Americhe, dove venivano in contatto con sindacati, movimenti e partiti di sinistra, la voglia infine di riscatto sociale che accomunava il proletariato ebraico a quello non ebraico: desiderio di redenzione terrena che si incrociò inevitabilmente, per molti decenni, con le ideologie socialiste. Sebbene sia esistito anche un movimento anarchico ebraico con caratteri peculiari, è anche vero che molti ebrei che divennero anarchici rigettarono, o avevano già precedentemente ripudiato, la tradizione religiosa di provenienza, ed abbracciarono le idee anarchiche in rivolta contro la religione dei padri, percepita come oppressiva e castrante in generale la libera espressione dell’uomo e nello specifico il riscatto individuale e collettivo degli ebrei. Né può sorprendere che molti di costoro continuassero a rivendicare, insieme a quella anarchica, anche l’identità ebraica, una identità che è sempre stata prima etnica che religiosa, e i cui contorni, in età contemporanea, sono divenuti sempre più sfuggenti, a cavallo tra l’appartenenza religiosa, il legame nazionale, l’etica praticata, la dimensione culturale.
Ciò che davvero può apparire paradossale è il tentativo di rinvenire una dimensione libertaria nella religione ebraica, nei testi sacri dell’ebraismo, il Tanakh (la Bibbia ebraica, acronimo delle sue tre parti: Torah, Nevi’im, Khetuvim), la Ghemarà e la Mishnà (cioè il Talmud, la codificazione della Torah orale), il Midrash (i commenti rabbinici alle Scritture), la Qabbalà (la mistica ebraica), nonché nella storia del movimenti messianici ebraici. Sino ad oggi, pochi si erano spinti così avanti in un parallelo di questo tipo, che, relativamente invece alla religione cristiana, era stato compiuto dal grande teologo protestante Jacques Ellul (Anarchia e cristianesimo, Elèuthera, Milano 1993).
La legittima domanda che chiunque può porsi di fronte al lavoro di Biagini è la seguente: cosa può avere a che fare una tradizione religiosa fondata sul rispetto della legge – traduzione di torah, che in ebraico significa propriamente “insegnamento”, come ricorda l’autore – con l’anarchismo, una tradizione politica che si propone di liberare gli uomini da ogni autorità, in primis quella divina, e, nell’accezione comune, anche da ogni legge? Che legame può avere Bakunin – l’autore di Dio e lo Stato – con l’halakhà, l’insieme dei precetti, positivi e negativi, che un ebreo osservante deve seguire? Nella Torah sono indicati, come ha insegnato Moshè Ben Maimòn (Maimonide), il più grande filosofo ebreo del Medio Evo, ben 613 mitzvòt (precetti: cfr. Le 613 mitzvòt, a cura di M. Levy, Lamed, Roma 2007), sebbene molti di essi non siano ritenuti, per diverse ragioni, attuali. L’halakhà permea la vita dell’ebreo dall’istante in cui si sveglia a quello in cui si corica, giorno dopo giorno, ed ogni festa – Shabbat, Yom Kippur, Purim, Chanukkà, Pesach, Rosh ha-Shanà etc. – prevede non una diminuzione bensì un aumento di regole da osservare. Che un ebreo diventi anarchico non dovrebbe stupire; piuttosto, dovrebbe sorprendere il contrario, e in ogni caso ogni tentativo di trovare intersezioni può apparire – ad un rabbino come ad un anarchico – una “vile” provocazione, da ricambiare con una cherem (scomunica), da un lato, un calcio nel sedere, dall’altro.
Biagini, però, ci mostra che si può vedere la cosa anche da un diverso punto di vista. Un punto di vista particolare, certo non il più tradizionale, ma non per questo meno legittimo o del tutto nuovo. Rav Giuseppe Laras, rabbino capo di Milano, nella sua prefazione al libro succitato di Schwarz, ha scritto: «Di tipi come Arturo Schwarz, fra gli ebrei, ce ne sono parecchi; non solo, ce ne sono sempre stati». Tale osservazione, che va interpretata non nel senso di piccato disappunto, bensì in quello di ironico e benevolo ammiccamento, offre una patente di legittimità anche ad interpretazioni radicali delle Scritture come quelle di Schwarz o di Biagini, purché, ovviamente, fondate sul testo ed adeguatamente argomentate: è chiaro che con un “combinato disposto”, con l’estrapolazione cioè di alcune frasi da un testo e la loro successiva ricucitura, più o meno abile, si può far dire ad un autore anche il contrario di quello che voleva dire; tanto più se questo autore, come nel caso della Bibbia, … non ha scritto l’opera di suo pugno. Nel suo lavoro, Biagini chiarisce in che senso la sua interpretazione dell’ebraismo debba essere ritenuta pertinente: la Torah è sempre stato un libro vivente, sempre aperto a nuove interpretazioni. È il Talmud a dire: «Ogni epoca ha il proprio interprete delle Scritture» (‘Avodà Zarà 5a, cit. in Biagini, Torà e libertà, p. 15).
Le stesse autorità preposte al commento dei testi sacri si sono spesso dimostrate, nei secoli, adogmatiche. «Nel Talmud» – ricorda Biagini – «quando una questione viene risolta facilmente e non trova obiezioni è considerata negativamente» (p. 18). Nell’ebraismo il commento e l’interpretazione, la Torah orale e scritta, hanno la stessa importanza, perché l’Eterno ha rivelato a Mosè, sul monte Sinai, anche la Torah orale. Chiarito questo aspetto fondamentale, chiarito cioè che l’ebraismo si è sempre fondato su una sorta di “anarchismo metodologico”, parafrasando Feyrabend – Biagini ci conduce all’interno delle Scritture e dei commenti, individuando gli elementi che, nella tradizione ebraica, permettono una lettura “libertaria” dei testi sacri. Essi si legano strettamente alla speranza messianica, in quanto nella religione ebraica – una religione del fare, del vivere, non un viaggio puramente spirituale – si trovano diversi momenti che anticipano e vorrebbero fare pregustare quella che sarà la vita dopo l’avvento del Messia.
Libertà e legge sono antinomiche, ma...
Lo Shabbat, anzitutto, che visto dall’esterno appare un concentrato di imposizioni e divieti volti ad appesantire la vita dell’ebreo, può essere visto e vissuto, al contrario, come una giornata in cui i precetti negativi e positivi hanno lo scopo di liberare l’uomo dai problemi quotidiani, dal lavoro, anzitutto – e questo è uno dei più grandi contributi dell’ebraismo alla civiltà, la quale sembra ora volersene sbarazzare – ma anche dalle preoccupazioni e dagli affanni dello spirito; un giorno che è un inno alla vita, nel quale ciascuno è restituito ai suoi affetti, ai suoi cari, nel quale riflettere sul significato dell’esistenza, sulla bellezza del Creato, nel quale darsi ai piaceri, inclusi quelli sessuali. Un giorno, insomma, che è la santificazione della vita, come ha chiarito Abram Joshua Heschel (Il Sabato, Garzanti, Milano 2001). In questo senso, la domanda giusta non è “cosa viene impedito di fare il Sabato?”, bensì “cosa si è liberi di fare il Sabato grazie a quegli impedimenti?”. La prospettiva è opposta, ed è una prospettiva di libertà.
È ovvio (ad un anarchico, per lo meno) che libertà e legge, o libertà e costrizione, sono antinomiche, ma è pur vero che la libertà può esistere solo dove sono rispettate alcune leggi; ogni società si fonda, si è fondata e non potrà che fondarsi sempre sul rispetto di alcune norme – e tutte le società moderne ne prevedono ben più di 613 – che sono le condizioni grazie alle quali è possibile la vita in società, le “regole del gioco”. Contrariamente ad una opinione comune, l’anarchismo, se non nella versione stirneriana, non ha mai teorizzato una società senza leggi. L’anarchismo non è un movimento per l’abolizione delle norme, ma per l’abolizione dello Stato, e le due cose non sono affatto coincidenti. Arché in greco significa principio ma anche autorità, ed è in questa seconda accezione che gli anarchici hanno sempre inteso l’anarchia: an-archia, cioè assenza di autorità, o, meglio, assenza di dominio; una società senza un potere centrale che abbia il monopolio del diritto e delle forza, nella quale tutti i rapporti sociali, dalla politica all’economia, sono informati a valori non gerarchici; non una società senza princìpi, o senza leggi (3).
Tornando al libro di Biagini, egli ravvisa questo spirito libertario anche in altre istituzioni ebraiche, sempre pensate e vissute come anticipazioni del tempo messianico: l’anno sabbatico e, soprattutto, l’anno del giubileo, un anno che prevedeva una legislazione sociale nei confronti dei poveri, imponendo una redistribuzione delle ricchezze, la liberazione degli schiavi e la remissione dei debiti. Ma è lo stesso monoteismo ebraico, per Biagini, ad essere – paradossalmente? – passibile di una lettura libertaria: l’affermazione dell’unicità del Signore del primo comandamento è associata all’idea di liberazione, non solo spirituale ma anche materiale: «Io sono il Signore Iddio tuo che ti fece uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa degli schiavi»; l’affermazione dell’unicità dell’Eterno è seguita dal divieto di idolatria – «non avrai altri dèi al Mio cospetto» (Esodo, 20, 2-3) espressione che, ricorda Biagini sulla scia di Fromm, anticipa, per certi versi, quello di alienazione umana (p. 30).
In Torah e libertà si possono trovare numerosi riscontri di concetti e pratiche presenti nelle Scritture e nella storia dell’antico Israele che si possono prestare, ad avviso dell’autore, ad una interpretazione libertaria. Impossibile qui ricordarli tutti: uno dei più significativi – e sempre attuali – è laddove l’Eterno, nel Levitico, invita ad amare il Gher, lo Straniero: straniero non solo in senso proprio, perché tutti siamo figli di Adamo, ma anche figurato, vale a dire colui che è in stato di necessità e di bisogno, ossia il povero, la vedova, l’orfano. «Il principio fondamentale di giustizia sociale che scaturisce dalla Torah – scrive Biagini – è di proteggere chi non ha potere da chi lo esercita» (p. 42). In breve, l’autore cerca di evidenziare come la Torah, diversamente da quanto tramandatoci da una certa cultura cristiana e dallo stesso illuminismo, sia un libro di libertà, e che l’Eterno della Torah non sia il Dio degli eserciti, ma il Santo dell’amore verso il prossimo. Voltaire certo non concorderebbe, ma probabilmente sarebbe incuriosito dalle argomentazioni di Biagini.
Forse, se mi è consentita una critica, Biagini sembra spingersi un po’ troppo innanzi in questa lettura, per esempio quando scrive che nel Sinai il popolo ebraico ha ricevuto una sorta di «costituzione civile e politica», e che la Torah è un catalogo dei «diritti dell’uomo» (p. 54). A questo punto mi par di vedere il “patriarca dei Lumi” scoperchiare la sua tomba nel Pantheon ed uscirne veramente arrabbiato, e forse non del tutto a torto: questo lessico mi pare poco appropriato, perché le culture antiche – quella greca, quella romana e anche quella ebraica, per non parlare delle altre – non concepivano, come ha evidenziato tra i molti Isaiah Berlin (Libertà, a cura di H. Hardy, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 324-25) diritti soggettivi, diritti che vengono pensati e rivendicati solo in età moderna, in opposizione allo Stato assoluto: le “dieci parole” (id est il Decalogo) a me continuano a sembrare una lista di doveri, sia pure reciproci. Più convincente mi sembra Biagini quando rilegge l’esperienza del Sinai come una sorta di “contratto sociale”, una interpretazione che tra i primi propose, se non erro, Spinoza (Trattato telogico-politico, a cura di A. Dini, Bompiani, Milano 2001, pp. 561-65).
Messianesimo radicale e movimenti rivoluzionari
La seconda parte del libro è dedicata al messianesimo radicale ebraico: il messianesimo – nella versione moderata o radicale – è una delle componenti fondamentali della religione ebraica, una religione vissuta nel presente ma proiettata nel futuro, un futuro di liberazione spirituale ma anche materiale. Il messianesimo ebraico, anche nelle sue versioni più moderate, pone, in quanto tale, in virtù cioè della sua prospettiva teocratica, una ipoteca di legittimità su ogni autorità terrena: ogni potere dell’uomo sull’uomo è, in un certo senso, illegittimo, in quanto l’unico legittimo sovrano è il Signore, che dopo la venuta del Messia punirà i potenti e i tiranni e governerà direttamente il mondo (pp. 73-96). Gli anatemi dei profeti contro re e tiranni, così come le istituzioni simil-repubblicane che il popolo ebraico si diede per alcuni secoli, rappresentarono un costante punto di riferimento per molti pensatori e movimenti antitirannici o antimonarchici tout court (4). Alcuni libri della Torah – l’Esodo, in particolare, come ha evidenziato Michael Walzer (Esodo e rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 91-99) con la loro promessa di liberazione dalla schiavitù, hanno per secoli costituito un modello di libertà e l’archetipo stesso della rivoluzione. Non bisogna tuttavia dimenticare che, nella storia del popolo ebraico come in quella di tutti i popoli che l’hanno fatta propria, la prospettiva teocratica, come Biagini stesso riconosce, è servita sì (sempre) come strumento di delegittimazione del potere politico (laico), ma (spesso) anche in funzione della legittimazione del governo dei preti, di ogni ordine o grado: governo in cui diritto e morale coincidono, e dunque ancor più temibile, da un punto di vista libertario. Inoltre, se la “politeia biblica”, la respublica hebraeorum, è stata un costante riferimento, sino all’età moderna, per ribelli e repubblicani, molte parti del testo biblico, non solo quelle esplicitamente filo-monarchiche, sono state altresì – e prevalentemente, direi – utilizzate per difendere e legittimare il potere dei re, dei papi e in generale la struttura sociale gerarchica (5).
Biagini si sofferma su tre movimenti messianici radicali sviluppati nelle comunità ebraiche della diaspora, soprattutto dell’Europa orientale, tra XVI e XIX secolo: il movimento sabbatiano – fondato da Shabbetày Tzevì –, quello frankista – iniziato da Jacob Frank – infine quello hassidico – che prese le mosse dalla predicazione di Yisra’èl ben Eli’ezer.
Tali movimenti furono contraddistinti da uno zelotismo manicheo e da un nichilismo estremi, e furono accomunati dall’idea che il Messia, identificato con il fondatore del movimento, era finalmente arrivato e che era giunto il momento di distruggere ab imis fundamentis un mondo governato dal Male ed inquinato dalla corruzione, attraverso una condotta paradossalmente antinomica e pantoclastica, vale a dire distruttrice della halakhà, di tutte le norme di comportamento dell’ebreo. Solo così – pensavano i messianici radicali – si sarebbe potuti giungere all’era messianica, l’era in cui ogni dominazione sarebbe stata abolita, l’era della libertà e dell’uguaglianza assolute. Questi movimenti millenaristi radicali – osserva Biagini – non elaborarono un vero e proprio programma politico, ma crearono le premesse spirituali e culturali per lo sviluppo dei movimenti rivoluzionari moderni, in particolare quello anarchico (pp. 243-49).
L’ipotesi non è affatto strampalata. La connessione tra messianesimo radicale – ebraico e cristiano – e i movimenti rivoluzionari moderni – di estrema sinistra ma anche di estrema destra, giacché pure il nazismo fu un movimento rivoluzionario volto a distruggere la “corrotta” società liberale –, era già stata messa in rilievo, con argomentazioni convincenti, da importanti studiosi (6). L’impianto fondamentalmente gnostico del pensiero rivoluzionario moderno, pure ovviamente attraversato da differenze radicali al suo interno, pure animato da ideali opposti – generosi e nobili nel caso dell’anarchismo e del comunismo, infami e ignobili nel caso del nazismo – da questo punto di vista è una versione secolarizzata dell’idea messianica radicale, in quanto strutturato intorno all’idea che l’umanità è divisa in tre gruppi: una minoranza di “pneumatici” – i rivoluzionari, «destinati, a motivo della loro “purezza”, a svolgere un ruolo di paracleti – una massa di psichici – il popolo che, pur contaminato, è passibile di essere redento e, infine, tutti quegli elementi ilici, corrotti e corruttori» che devono essere spazzati via (L. Pellicani, Lenin e Hitler. I due volti del totalitarismo, Rubettino, Soveria Mannelli 2009, p. 10). Nella dottrina comunista e in quella nazista, tradottesi tragicamente in pratica, tale opera di “pulizia” soteriologica viene esplicitamente identificata nello sterminio di massa, nella “pulizia etnica” o nella “pulizia di classe”, come affermano inequivocabilmente non solo i testi e i discorsi di Hitler, Goebbels, Himmler, e degli altri leaders nazisti ma anche quelli di Engels, Lenin, Zinovev e di numerosi altri capi bolscevichi. L’eredità del messianesimo religioso radicale non è tuttavia univoca. A mio avviso, essa può assumere, nella sua traduzione anarchica secolarizzata, anche una valenza positiva, a patto di rimanere entro i confini di un’idea regolativa. Ma questo complesso argomento meriterebbe una trattazione a parte.
Società aperta
Per concludere, Torah e libertà suggerisce, tra le altre cose, che il problema della legge, da un punto di vista anarchico, non riguarda tanto il numero delle norme (le “regole del gioco” necessarie al vivere civile), bensì, piuttosto, la fonte e, direi soprattutto, il loro contenuto e la loro estensione: che un precetto religioso sia seguito da un credente non è un problema in quanto tale, a patto che la norma religiosa sia accettata volontariamente, che sia laicamente distinta da quella civile o politica, e che alla religione, come scriveva Locke, sia data la possibilità di convincere, mai di costringere (Lettera sulla tolleranza, Laterza, Bari-Roma 2005). In fondo, come aveva intuito o compreso Bakunin dopo aver scagliato fulmini e saette contro l’idea di Dio, archetipo di ogni autorità, una società libera non è, né può essere, una società di atei o di anarchici; essa non potrà che essere una società in cui l’eresia è, per così dire, “istituzionalizzata”. Una società libera è una società aperta, una società in cui il credere o il non credere (nella divinità o in qualunque altra cosa) è un problema che attiene la coscienza del singolo: è quella società in cui non esiste una verità ufficiale, in cui ciascuna Chiesa, setta, partito o movimento, ciascuna associazione «non escluse quelle che avranno per scopo la distruzione della libertà individuale e pubblica» ha «libertà illimitata di svolgere ogni tipo di propaganda con le parole, con la stampa, nelle riunioni pubbliche o private; senz’altro freno che il naturale e salutare potere dell’opinione pubblica» (7). Quale che sia la forma che può assumere, una cosa è certa: una società libera non può essere una società che costringe gli individui ad essere liberi, come invece auspicava il padre del pensiero totalitario, Rousseau (8). Libera sarà sempre quella società che sa tutelare, in primo luogo, più o meno bene, la libertà individuale: il diritto di ciascuno di essere «fannullone o laborioso» (9), cioè di vivere, se così gli pare, della carità volontaria; «la libertà di perseguire il nostro bene a modo nostro, fino a quando non tentiamo di privare gli altri del loro o di impedire che i loro sforzi lo raggiungano» (10); «il diritto di opporsi, di essere impopolari, di difendere le nostre convinzioni solo perché sono le nostre convinzioni. È questa la vera libertà, e senza di essa non esiste nessuna specie di libertà, e anzi neppure l’illusione della libertà» (11).
da: "A Rivista Anarchica"
Note
1. Su questo tema Biagini ha pubblicato diversi lavori, tra i quali si segnala il volume Nati altrove: il movimento anarchico ebraico tra Mosca e New York, BFS, Pisa 1998.
2. Cfr. almeno G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, Einaudi, Torino 1993; Id., Shabbetai Sevi: il messia mistico (1626-1676), Einaudi, Torino 2001; M. Löwy, Redenzione e utopia. Figure della cultura ebraica mitteleuropea, Bollati Borlinghieri, Torino 1992; A. Schwarz, Sono ebreo, anche. Riflessioni di un anarchico ateo, Garzanti, Milano 2007.
3. Cfr. A. Bertolo, Potere, autorità, dominio. Una proposta di definizione, «Volontà», a. XXXVII, 1983 n. 2, pp. 51-78. Ciò che piuttosto appare discutibile nel pensiero anarchico è che in esso, in virtù della sua prospettiva rivoluzionaria, non si può rinvenire nessuna chiara indicazione su quali istituzioni dovrebbero essere autorizzate ad emanare le leggi, su chi dovrebbe farle rispettare, su chi dovrebbe punire i trasgressori, e in quali modi. Su questo tema, spunti critici nel numero monografico di «Volontà», a. XLVIII, 1994 n. 1, Il diritto e il rovescio.
4. Cfr. «Il pensiero politico», a. XXXV, 2003 n. 2, Politeia biblica, a cura di L. Campos Boralevi e D. Quaglioni.
5. Un esempio di utilizzo in modo opposto del testo biblico è offerto da 1 Samuele, 8, 5-22, alla cui autorità Thomas Paine fa appello per condannare nella maniera più categorica ogni monarchia, tanto quanto Thomas Hobbes vi aveva fatto ricorso, un secolo prima, per giustificarla nella sua versione assoluta. Cfr. T. Paine, Common Sense, in I diritti dell’uomo, a cura di T. Magri, Roma 1978, pp. 76-78; T. Hobbes, Leviatano, a cura di A. Pacchi, Laterza, Bari-Roma 1989, pp. 171-72.
6. Cfr. per tutti N. Cohn, I fanatici dell’Apocalisse, Edizioni di Comunità, Milano 1976; L. Pellicani, La società dei giusti. Parabola storica dello gnosticismo rivoluzionario, Etaslibri, Milano 1995.
7. M. Bakunin, La libertà degli uguali, a cura di G. Berti, Milano 2009, p. 98.
8. J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, a cura di R. Derathé, Einaudi, Torino 1994, p. 28.
9. M. Bakunin, La libertà degli uguali, cit., p. 98.
10. J.-S. Mill, Sulla libertà, a cura di G. Mollica, Milano 2007, p. 63.
11. I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 2002, p. 166.
mercoledì 14 aprile 2010
Torah e libertà
Etichette:
Alexander Berkman,
Anarchismo,
Chomsky,
ebraismo,
Emma Goldman,
Francesco Berti,
Furio Biagini
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
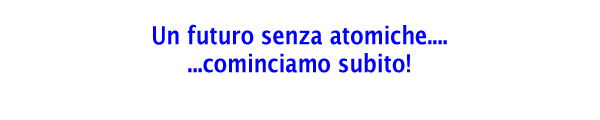





































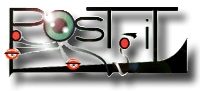
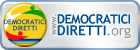
















1 commento:
Ciao Domenico interessante articolo, volevo anche ricordare come tra gli ebrei del '900 anarchico vi era anche un certo Murray N. Rothbard.
Ciao da LucaF.
Posta un commento