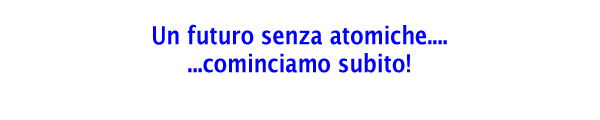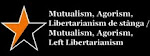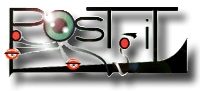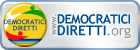Storia di una idea di Roderick T. Long
Ovvero come un argomento contro la fattibilità del socialismo autoritario diventa un argomento contro la fattibilità del capitalismo autoritario.
Nel 1920, Ludwig von Mises dimostrò l’impossibilità del “socialismo” (inteso come proprietà statale dei mezzi di produzione), una tesi successivamente rielaborata da lui stesso e dal suo allievo Friedrich von Hayek.
In breve, l’idea: il valore di un bene del produttore dipende dal valore del bene di consumo al quale questo bene contribuisce. Pertanto, nel decidere tra metodi di produzione alternativi, la scelta più efficiente è quella che economizza su quei beni del produttore che sono richiesti per i beni di consumo più altamente valutati.
C’è però una differenza tra efficienza tecnica ed efficienza economica. (Per questa spiegazione ho un debito con “From Marx to Mises” di David Ramsay Steele).
Supponiamo di paragonare due modi di fare dei gingilli; un metodo A usa 3 grammi di gomma per gingillo mentre un metodo B ne usa 4 (e per il resto siano a parità di costi). In questo caso il metodo A è chiaramente più efficiente del metodo B; questo è un caso di efficienza tecnica, perché possiamo capire quale sia più efficiente semplicemente guardando ai quantitativi impiegati, senza interessarci di concetti economici come la domanda.
Adesso confrontiamo un metodo C, che usa 3 grammi di gomma e 4 di acciaio per gingillo, con un metodo D che ne usa 4 di gomma e 3 di acciaio (sempre a parità di altri costi). In questo caso né C né D sono uno tecnicamente più efficiente dell’altro. Per calcolare quello economicamente più efficiente dobbiamo paragonare i valori di gomma e acciaio – ovvero chi rinuncia ad un uso alternativo maggiormente richiesto, un grammo di acciaio o uno di gomma? Secondo Mises e Hayek, non c’è un modo chiaro per capire questo, se non attraverso la concorrenza di mercato e un sistema di prezzi per cui le valutazioni dei consumatori dei beni di primo ordine vengano tradotte, per mezzo dei prezzi, nelle varie domande dei loro fattori di produzione (ad esempio risulta un prezzo più elevato per l’acciaio che non per la gomma, e di conseguenza i produttori cercano di risparmiare sull’acciaio). La proprietà statale dei mezzi di produzione non fa parte del mercato, e quindi non ne fanno parte nemmeno i prezzi dei beni dei produttori, pertanto non c’è alcun modo di trasmettere questa informazione.
Perché lo stato socialista, pianificatore centrale, non può avere accesso a questa informazione? Bene, in primo luogo la maggior parte delle informazioni rilevanti sulle preferenze è locale, inarticolata, costantemente in evoluzione; può essere espressa attraverso le scelte dei consumatori, che incarna, ma non ci sono altri sistemi per raccoglierle. (Questo è l’aspetto del problema sottolineato da Hayek – che comprendeva altri tipi di informazioni inarticolate, locali e costantemente in evoluzione – oltre che in materia di preferenze – nei suoi scritti). In secondo luogo, anche se potesse ottene queste informazioni in una graduatoria, ma senza traduzione in prezzi cardinali, non ci sarebbe alcun modo di combinare le graduatorie di persone diverse. (Questo è l’aspetto che è stato sottolineato da Mises). Infine, anche ottenendo le informazioni in forma cardinale, per poterle usare allo scopo di pianificare l’economia bisognerebbe risolvere in tempi brevissimi milioni di equazioni simultanee. (I critici di Mises e Hayek spesso hanno affermato che sia questo terzo problema quello principale, supponendo che un calcolatore abbastanza potente potrebbe sostituire il sistema dei prezzi – ma rispetto alla prospettiva di Mises e Hayek è un ripensamento di portata nettamente minore).
Se la pianificazione centrale è uno sforzo senza speranza, per l’impossibilità del calcolo economico, allora perché gli stati socialisti come l’Unione Sovietica non hanno avuto ancora meno successo dei loro risultati attuali (che, pur non pessimi, non sono stati completamente caotici come ci si potrebbe aspettare dai risultati di Mises e Hayek)? La risposta è che lo stato sovietico, come altri regimi, non fu mai completamente isolato dal sistema internazionale dei prezzi (per tacere del suo mercato nero interno). Pertanto i meccanismi di trasmissione, pur gravemente ostacolati, in una certa misura sono stati in grado di funzionare. (La maggior parte delle forme di intervento governativo consistono in una mera distorsione del sistema dei prezzi, piuttosto che in una sua completa soppressione. Naturalmente gli effetti di questa distorsione possono essere seri – come quando, per la teoria austriaca del ciclo economico, lo stato aumenta artificialmente l’offerta di moneta con tassi di interessi inferiori, dando agli investitori il falso segnale che i consumatori sono sono più disposti ad aumentare i consumi di quanto siano in realtà. Gli investitori indirizzano quindi le loro risorse su progetti a lungo termine (boom) che si rivelano però insostenibili (bust), come nel 1929 – o nel 2008. Ma l’applicazione della teoria austriaca del ciclo alla crisi attuale è l’oggetto del mio prossimo intervento).
La dimostrazione dei limiti della centralizzazione statale vennero in seguito estesi altrettanto bene da un allievo di Mises, Murray Rothbard, ai limiti della costituzione di cartelli privati. Dal suo “Man, Economy and State” del 1962 (in particolare qui e qui):
Al fine di calcolare i profitti e le perdite di ogni ramo, una società deve essere in grado di fare riferimento nelle sue operazioni interne ai mercati esterni per ciascuno dei vari fattori e dei prodotti intermedi. Quando uno di questi mercati esterni scompare, perché tutti sono assorbiti all’interno di un’unica impresa, non è possibile eseguire il calcolo economico, e non vi è alcun modo per l’impresa di allocare razionalmente i fattori in un settore specifico. Più questi limiti saranno estesi, tanto maggiore sarà la sfera di irrazionalità e più difficile sarà evitare le perdite.
Se non c’è mercato per un prodotto, e tutti i suoi scambi sono interni, non è possibile per l’impresa determinare il prezzo del bene. Una impresa può stimare un prezzo implicito quando esiste un mercato esterno; ma quando questo è assente il prezzo del bene non può essere stimato, né implicitamente, né esplicitamente. Qualsiasi cifra potrebbe essere un simbolo arbitrario. Non essendo in grado di calcolare un prezzo, l’impresa non può allocare razionalmente i fattori e le risorse da un reparto ad un altro. … Per ogni bene capitale deve esistere un dato mercato. E’ ovvio che questa legge economica stabilisca un preciso massimo alla dimensione relativa di una impresa in un mercato libero. In virtù di questa legge non potrà mai esistere un unico grande cartello su tutto il mercato, o fusioni fino ad arrivare ad un unica impresa proprietaria di tutti gli assets. La forza di legge si moltiplica all’aumentare dell’area del mercato, ampliando le zone di caos per cui è impossibile eseguire il calcolo economico. Mentre la zona di non calcolabilità aumenta, i gradi di irrazionalità, di cattiva allocazione, di perdita, di impoverimento, diventano maggiori. Il proprietario o il cartello che controllasse l’intero sistema produttivo non potrebbe eseguire alcun tipo di calcolo economico, e quindi prevarrebbe il caos più completo.
Tutti conoscono le economie di scala, è il principale motivo per cui esistono le imprese. Quello che l’analisi di Rothbard dimostra è che possono esistere diseconomie di scala, e che tendono a crescere con l’aumento dell’integrazione verticale.
Cosa succede quando una impresa cresce al punto che al suo interno le operazioni si svolgono in modo isolato dal sistema dei prezzi, e le diseconomie di scala iniziano a superare le economie? Dipende dal contesto istituzionale. In un libero mercato, se l’impresa non inverte la tendenza e non comincia a ridurre le sue dimensioni, si svilupperà sempre più inefficiente e finirà per perdere clienti a favore dei suoi competitori: i mercati servono così da controllo alle sue dimensioni.
Ma quando politici amici manipolano il gioco in modo che le imprese favorite ne possano trarre i benefici connessi, socializzando quindi i costi associati alle diseconomie di scala? Allora finiremmo per avere una economia dominata da quel colosso mastodontico, burocratico e gerarchico che tutti conosciamo ed amiamo. (Per vedere alcuni dei modi in cui l’intervento dello stato contribuisca all’attuale natura dilbertiana del mondo degli affari si veda l’articolo di Kevin Carson: “Economic Calculation in the Corporate Commonwealth” e per maggiori dettagli il suo libro “Studies in Mutualist Political Economy” e i suoi tutt’ora in corso “Studies in the Anarchist Theory of Organizational Behavior”).
La buona notizia è che le poco amate caratteristiche dell’economia, spesso addebitate al libero mercato (o a qualcos’altro chiamato “capitalismo”, che dovrebbe significare libero mercato o plutocrazia, oppure magicamente entrambe), sia nei fatti il prodotto di interventi del governo. Possiamo abbracciare il libero mercato senza abbracciare il big business.
Ma non solo gli oppositori del libero mercato che sostengono gli interessi di imprese miste. Ancora troppi libertari difendono giganti multinazionali come Microsoft e Wal-Mart (due imprese il cui intero modello di business dipende in larga misura dall’intervento delle autorità pubbliche – attraverso la disciplina dei brevetti e dei copyright per Microsoft, e per la socializzazione di costi di trasporto per quanto riguarda Wal-Mart; oltre che dalla soppressione dei piccoli concorrenti per entrambe) come se tale difesa sia rivolta verso una parte integrate dei mercati. Come libertari non possiamo lamentarci di essere additati come apologeti della plutocrazia corporativa, finché siamo noi stessi a contribuire a questa percezione, dimenticandoci dei fondamentali riguardo il sistema dei prezzi.
Fino a quando la confusione tra libero mercato e plutocrazia persisterà – fino a quando i libertari confonderanno la lodevole battaglia per il libero mercato con la difesa della plutocrazia, e fino a quando a sinistra confonderanno la loro lodevole opposizione alla plutocrazia con la l’opposizione al libero mercato – né la sinistra, né i libertari risolveranno alcunché, e l’alleanza tra stato e corporations continuerà a dominare la scena politica.